a cura di Cornelio Galas
Siamo arrivati all’ultima puntata sul massacro di Schio. Concludiamo con Giuseppe Mugnone, che nel suo libro «Operazione rossa», così descrive l’eccidio avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio 1945 all’interno delle carceri di Schio:
«Nella prima decade di luglio dell’anno 1945 le carceri d’Italia erano strapiene di detenuti fascisti o “ritenuti tali”: in quella di Schio ve ne erano circa un centinaio.

Lo stabilimento di pena nella cittadina scledense era un piccolo locale a due piani, uno stanzone, due celle, una stanza che fungeva da parlatorio e un atrio al piano terra.
Al primo piano vi erano situate due celle e al secondo piano vi era una stanza.
Cento detenuti potevano muoversi a malapena. Fino alla sera del 6 luglio dell’anno 1945 stavano suddivisi in tutti i locali, anche nell’atrio.
Fra i detenuti, otto erano comuni e venticinque donne, settantacinque provenivano da Schio, diciannove dal mandamento di Schio e nove da altre regioni. Di loro: cinque erano della Brigata nera, tre della Polizia ausiliaria, tre del Servizio ausiliario femminile, trentaquattro fascisti e gli altri ritenuti fascisti e arrestati in gran parte su semplice indicazione di un partigiano o di qualsiasi persona.
C’erano ragazze diciassettenni, donne in stato di maternità, madri e figlie, sorelle, padri e figli, vecchi settantenni.
Fra loro c’erano il primario dell’ospedale di Schio, dottor Arlotta; il commissario prefettizio di Schio, dottor Giulio Vescovi; gli esponenti del fascismo della RSI Mario Plebani, Rino Tadiello, Domenico e Isidoro Marchioro, il dottor Diego Capozzo, vicecommissario prefettizio; una ragazza di sedici anni, Anna Franco; un reduce di Russia, Calcedonio Pellitteri; il vecchio dottor Antonio Sella, che era stato podestà di Valli del Pasubio; il signor Giuseppe Stefani, già podestà di Valdastico e altri detenuti ufficiali e gregari delle forze della RSI.
C’erano anche persone che con il fascismo non avevano mai avuto a che fare, ma che avevano avuto qualche “questione privata” con quanti raggiunsero, in quei giorni, il potere di stabilire il diritto di vita o di morte per la gente.

Luigi Losco
Questo il quadro delle carceri di Schio fino alla sera del 6 luglio 1945, alle ore 23 circa.
Quella sera, verso l’imbrunire, i detenuti si erano stesi sui pagliericci e parlavano fra di loro. Qualcuno dormiva già. Solo quelli dello stanzone al piano terra e quelli della stanza al secondo piano avevano la luce: una lampada di cinque candele per ogni luogo. Gli altri erano al buio.

Valentino Bortoloso
Dalle vicine abitazioni, una radio lanciava nello spazio canzoni e musiche allegre: pareva che volesse burlarsi delle pene dei carcerati o, chissà, credeva di portare una nota di allegria nel cuore di quanti, al calar della notte, sentivano di più la malinconia e la catena del carcere.
Poi, a poco a poco, si era fatto silenzio: la radio era stata spenta, i detenuti non parlavano e dalla strada non si sentivano più i rumori e il vociare della vita cittadina. Era notte e ognuno si era messo a dormire, con le sue speranze e con le sue pene, con le sue gioie o con le sue amarezze. Ma qualcuno, fuori dal carcere, stava operando per compiere uno spaventoso delitto. Infatti, a un certo momento, nel cortile del carcere si sentì un rumore di passi insoliti, uno sbattere di una porta e l’aprirsi di un’altra porta.
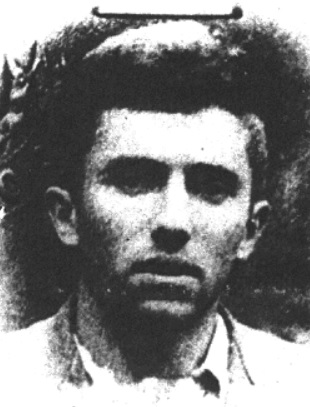
Gaetano Canova
Chi è stato in carcere sa che il detenuto percepisce il più lieve movimento e ne conosce la provenienza; conta anche i passi dei carcerieri.
Quella sera, coloro che erano ancora svegli e avevano sentito quei rumori, in un primo tempo non diedero importanza al fatto, pensando che potessero essere i custodi che dormivano nel carcere con le loro famiglie. Ma i passi continuavano a farsi sentire sempre più sul selciato del cortile, avanti e indietro, e le persone parlavano senza che potessero essere udite le parole.
L’orologio del Duomo batteva le 23 ore con una cadenza che quella notte sembrava lugubre. Uno dei detenuti sistemati nell’atrio si mise ad ascoltare, a prestare silenzio, ma per curiosità. Era mezzanotte.
La discussione nell’atrio improvvisamente si accese, assunse un tono forte, deciso, duro. Il numero delle persone pareva aumentato, due o tre porte vennero aperte e rinchiuse in fretta, ancora molte voci indistinte, un parlare energico come se fossero ordini indiscutibili.
Intanto altri detenuti si svegliarono mettendosi in ascolto, presi da evidenti segni di preoccupazione. Uno aprì lo spioncino della porta dello stanzone, ma si ritrasse subito dando l’allarme: “Persone mascherate”.

Antonio Fochesato
In una piccola cella, alla vista degli uomini mascherati e armati, si cercò di sbarrare la porta che fu puntellata con ceppi di legno e bloccata con una sbarra di ferro. Uno dei detenuti, il signor Bigon, svegliò i Tomasi padre e figlio, capitano e soldato degli alpini, che dormivano vicini e assieme decisero di approntare una possibile difesa.
Intanto vennero ostruite le finestre collocando alcune pesanti mastelle di legno. Il capitano Tomasi si munì di alcune bottiglie da usarsi come proiettili, un detenuto appoggiò due pesanti libri matricolari sulle finestre per ripararsi da eventuali pallottole. Alfredo Tomasi, il figlio del capitano, era il più deciso alla difesa.
La stanza era al buio e si procedeva a tentoni, con la luce naturale che entrava dalle finestre. Tomasi, però, credeva che si trattasse solo di prelevamento di alcuni detenuti, come era avvenuto altre volte. Intanto si sentì un passo decisivo alla porta della cella. Allora furono svegliati i detenuti. Nello stesso tempo sembrò che la porta si aprisse dopo alcuni giri di chiave, ma non era così.

Renzo Franceschini
Il catenaccio fu tirato in più riprese, fu dato uno spintone, poi un altro, ma la porta rimase chiusa, tanto che a un certo punto si udì una voce imperiosa: “Aprite!”. Ma all’intimazione non ripose nessuno, poi ancora una volta: “Aprite!”.
Bigon ripose che non avrebbe aperto se non fosse stato presente il capocarceri. Ma dal di fuori l’intimazione si fece minacciosa: “Aprite! Altrimenti vi bruciamo vivi”. In questo tempo i detenuti si misero al riparo dietro le panche, poi uno di loro, Carozzi, andò ad aprire.
Nello stanzone tutti si alzarono di soprassalto, impauriti, presi di sorpresa. Qualcuno allora pensò di opporsi, ma il fatto di non conoscere il motivo della visita lo convinse a desistere dall’idea. Intanto gli uomini mascherati si avvicinarono alla porta dello stanzone, infilarono la chiave e aprirono le due celle e la stanza sottoportico al piano terra, ordinando ai detenuti di passare nello stanzone.

Aldo Santacaterina
Nel primo momento l’operazione di ammassamento nello stanzone si svolse come un normale trasferimento, poi l’atteggiamento degli uomini mascherati e la minaccia delle armi assunsero un tono preoccupante.
Improvvisamente, un senso di terrore si impadronì dei prigionieri. Intanto entrò un uomo mascherato, portava il cappello di alpino, era armato di mitra e seguìto da altri sei uomini pure mascherati e armati. I detenuti cominciarono ad arretrare fino ad ammassarsi in fondo alla parete dello stanzone. Erano sessantacinque persone dove, in tempi normali, avrebbero potuto trovar posto al massimo quindici persone.

Fra gli uomini mascherati, oltre a quello che portava il cappello di alpino, uno portava il berretto d’autista di piazza, due tenevano la testa coperta con una rete piena di erbe, un altro aveva un berretto tedesco, altri avevano ampi fazzoletti rossi e neri che coprivano il viso, due erano senza copricapo, ma avevano il viso coperto da maschere antigas senza filtro. Tutti indossavano indumenti borghesi.
Anche nelle stanze del primo e secondo piano avvenne l’operazione di ammassamento nella stanza superiore, cioè i nove detenuti nelle celle al primo piano vennero fatti salire nella stanza del secondo piano dove erano rinchiuse le donne. Anche qui operavano sei uomini mascherati e armati di mitra.
Quando, a un certo momento, la porta della stanza si aprì, una delle detenute, Anna Franco, che fungeva da caposala, si alzò di sorpresa. Il primo che fu fatto entrare, sotto la minaccia del mitra, era un professore, il signor Perin.

La stanza era illuminata da una lampadina e la luce era attenuata da una busta. I corpi delle donne, pigiati e sdraiati, ammassati come bestie e i loro volti sotto i riflessi di quella luce pallida, apparivano come in un tragico scenario del film «Noi vivi».
Alla vista del professor Perin, Anna Franco, sorpresa, chiese subito: “Che fa, lei, a quest’ora, nella nostra camera?”. Non si era accorta della presenza degli altri uomini. Era ancora con gli occhi pieni di sonno.
“Alzati, bocia!” le rispose il professor Perin. Intanto entrarono gli altri detenuti e gli uomini armati. Questi portavano fazzoletti scuri sul viso e uno portava la maschera antigas.
Le donne si svegliarono una con l’altra, con scossoni, impaurite, atterrite. La diciottenne Livia Magnabosco ebbe un’esclamazione: “Ci ammazzano tutte”. Intervenne il professor Arlotta dicendo: “State calme, che volete che facciano alle donne?”.

I sei uomini armati stavano in riga, con le armi spianate contro i detenuti che anche qui erano arretrati sulla parete in fondo alla stanza. Intanto vennero fatte uscire dalla stanza le comuni Iaccheo, Facci e Santacaterina.
Nello stanzone al piano terra l’uomo col berretto di autista teneva l’elenco dei detenuti: era evidentemente colui che dirigeva l’azione.
A un certo punto venne chiamato il detenuto Calvi, ma fu risposto che non era presente. Dopo vennero fatti uscire i detenuti comuni Boaria, Renzo Pietrobelli, Gino Pietrobelli, Tarso, Fabrello, Sartori e tre politici: Maron, Antoniazzi e Carozzi. Altri due detenuti, e cioè Borghesan e Mario Faggion, furono messi in prima fila.
La divisione dei detenuti e l’esclusione di alcuni fecero aumentare lo stato di smarrimento e di paura.Ma uno dei mascherati, accortosi del fermento, rivoltosi ai prigionieri, disse: “Non preoccupatevi, siamo venuti per prelevare quattro o cinque persone”.
Nello stesso tempo anche il detenuto Maron fu trasferito in una delle celle al piano terra dove erano stati messi i detenuti comuni e gli altri chiamati da parte.
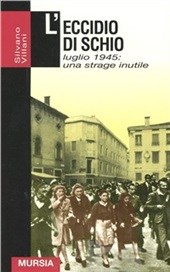
Il dubbio di un’azione sanguinosa aveva cominciato a farsi strada nella mente di tutti. Però nessuno credeva che gli uomini armati potessero arrivare a far fuoco indiscriminato. La gran parte dei detenuti, non avendo conti da regolare con la giustizia, neanche con la giustizia partigiana, era in attesa della scarcerazione e tutt’al più, quella notte, pensava che gli uomini mascherati avrebbero portato via alcuni prigionieri per fucilarli.
Il dubbio del massacro indiscriminato, pur entrando nella mente dei prigionieri, si fermava dinanzi alla mostruosità di un immane delitto nel carcere.
Vi erano, fra i prigionieri, uomini in pieno vigore e certamente sarebbero riusciti a disarmare i sei uomini con un abile atto di forza. Qualcuno sarebbe caduto sotto i primi colpi. Comunque, l’idea di reagire, passata fra alcuni detenuti, cadde, perché, soprattutto, non sapevano e non credevano che si sarebbe arrivati a orribili fatti di sangue.
Cadeva, anche, dinanzi a un interrogativo: erano forse venuti per prelevare realmente quattro o cinque persone? In questo caso, un atto di forza non sarebbe risultato inconsulto e non avrebbe provocato la rappresaglia?
Intanto le quattro o cinque persone non erano ancora state prelevate e mentre supposizioni disparate e raggi di speranza si alternavano nella mente dei prigionieri, nello stanzone pianterreno, uno dei detenuti, il dottor Giulio Vescovi, chiedeva di parlare con il “capo” e quando fra i due avvenne l’incontro, di cui diremo più avanti, si ebbe l’impressione esatta di ciò che sarebbe avvenuto.
Il panico si impadronì dei prigionieri, gli occhi si sbarrarono, i volti assunsero gli aspetti del terrore e ognuno cercò una via di scampo, un rifugio. Chi gridava di essere innocente, chi diceva di avere aiutato i partigiani; uno alzava forte la voce per dire che non aveva colpe; in un angolo, un padre faceva scudo con il proprio corpo al figlio, un figlio si parava davanti al padre, un vecchio chiedeva pietà per la sua vecchiaia. Ma le sei armi restavano spianate in un gelido silenzio che era eloquente: tragica contraddizione di termini.
La massa dei detenuti ondeggiava, si urtava, premeva su se stessa, in una disperazione desolante, non c’era via di scampo. Erano le 0,15 del 7 luglio: nelle due stanze, quella al piano terra e quella al secondo piano, stavano ammassati quasi novanta detenuti, mentre, in una piccola cella delle stesse carceri, ne stavano rinchiusi undici.
Dinanzi ai detenuti nelle due stanze stavano in posizione di sparo dodici uomini con dodici mitra caricati e sul punto di far fuoco. A quell’ora, dal cortile del carcere, partì un colpo di pistola: era il segnale di fuoco.
Al secondo e al piano terra i mitra iniziarono una sparatoria infernale, rabbiosa, tirando alla vita, alle gambe e al petto dei detenuti: uomini e donne caddero, in un indescrivibile lago di sangue, con un urlo di terrore che nulla aveva di umano e che si spegneva in gemiti, in rantoli, in grida di aiuto, soffocati anch’essi dalle ultime raffiche. Erano caduti quelli di prima fila, poi gli altri e gli altri ancora.
Negli attimi fuggenti, quelli che ancora non erano stati raggiunti dal fuoco, cercavano, come dannati, con gli occhi fuori dalle orbite, un riparo dietro ai morti e ai vivi, gli uni con gli altri, nel tentativo di salvarsi. I morti si ammucchiavano, i feriti gravi agonizzavano.
In fondo alla prima stanza, dietro alcune tavole, si erano nascosti alcuni detenuti, ma le tavole, sotto il peso dei morti che vi stavano sopra, caddero e lasciarono allo scoperto quelli riparati. Anche per loro partirono altre raffiche e giunse la morte. Poi il fuoco cessò, a parte qualche colpo isolato che sfogava la ferocia sui corpi che ancora si muovevano tra gli spasimi dell’agonia. Poi, silenzio.
Il sangue era sprizzato sulle pareti, sui tavolini, aveva bagnato tutto il pavimento, zampillava dalle carni forate e formava un lago, poi finiva in rivoli scorrenti giù per le scale, nell’atrio, nel sottoportico: tutte le carceri erano insanguinate. Il massacro di Schio era compiuto.
La luce delle lampade illuminava i volti bianchi, cadaverici. Qualcuno dei prigionieri era rimasto miracolosamente illeso, altri erano salvabili. I più erano morti, giacevano gli uni sugli altri in una visione impressionante.
Fra i caduti c’erano il primario dell’ospedale, colonnello medico Arlotta; il maggiore Ruggero Rizzoli, già componente la Commissione per l’armistizio con la Francia; il capitano di fanteria Gio Batta Mignani; il farmacista dottor Sella, ex podestà di Valli; il signor Giuseppe Stefani, ex podestà di Valdastico; e tra i feriti, poi morti all’ospedale, si vedevano il commissario prefettizio di Schio, dottor Giulio Vescovi; Mario Plebani, uno dei principali esponenti del fascismo scledense; il maggiore del Genio Giuseppe Fistarol; il maggiore Agostino Micheletto, della GNR.
Intanto, con il terribile scannatoio dalle tipiche caratteristiche della rivoluzione rossa, che aveva eliminato i maggiori esponenti del fascismo e della RSI nella zona e con loro i semplici gregari, l’Italia subiva da ogni parte del mondo un’onta, un insulto, un tremendo giudizio.
Al triste bilancio dei morti si aggiungeva un più triste bilancio di vergogna gravante sugli italiani. Ma in quella tragedia tanti dei morituri superarono le barriere dell’odio e lasciarono una testimonianza di amore e di patriottismo, di umanità e di civismo che riscatta, di fronte all’azione degli esecutori della strage, il patrimonio di civiltà del popolo italiano …
… Chiusa la sparatoria micidiale, la tragedia si manifestò più tremenda per gli scampati: grida, rantoli, corpi che ancora si muovevano, gente che era salvabile. In questa terribile e sconvolgente visione, uno dei detenuti, il dottor Diego Capozzo, già vicecommissario di Schio, scampato miracolosamente alla carneficina perché finito sotto molti cadaveri dei suoi camerati, uscì da quell’inferno sanguinante e corse fuori dal carcere in cerca di soccorso.

Nella cittadina dominava la paura, ancora gli autori del massacro e i loro protettori controllavano la città e uscire dal carcere per chiedere soccorso era come rischiare di lasciarci la vita. Ma il dottor Capozzo uscì, avvertì i carabinieri, corse all’ospedale dove chiese aiuto; il personale però ebbe paura di rappresaglie. Allora Diego Capozzo insistette, richiamò ai doveri umani e civili, scudisciò quella paura dicendo: “Andiamo, in testa ci sarò io!”.
Così furono organizzati i primi aiuti agli scampati, ai feriti, ai morenti, ma quest’opera venne impedita, in qualche momento, da gruppi di partigiani; poi intervennero gli alleati e i carabinieri e le carceri vennero sgombrate: i cadaveri, ammucchiati su autocarri “come gli appestati di Milano manzoniana”, furono portati al cimitero, i feriti all’ospedale civile.
Fuori dal carcere, Umberto Perazzolo, leggermente ferito, aiutò i più gravi. Suo figlio era già spirato. Alcaro, colpito a un braccio, portò Bigon verso l’ospedale.
Il maggiore Fistarol, che non aveva voluto essere trasferito a Vicenza per restare a Schio vicino alla sua famiglia, era su di una barella prossimo alla morte; vicino a lui stava Ferrj Slivar, piegato sul corpo del padre che rantolava nell’agonia.
Ferrj accarezzava il viso di suo padre, ma poi si alzò preso dalla disperazione. Antonio Slivar era dalmata, amava l’Italia; nativo da genitori triestini, era stato perseguitato dall’Impero austroungarico per i suoi sentimenti di italianità.
Ai feriti, portati all’ospedale dagli stessi feriti o da mezzi dell’esercito americano e italiano, non vennero prestate le necessarie cure immediate, anzi si temeva un attacco all’ospedale per l’eliminazione dei superstiti, tanto che vennero piazzate alcune mitragliatrici davanti al luogo di cura.
Il dottor Sola ebbe qualche parola di conforto e parve più premuroso, come il dottor Schiesari. La suora dell’ospedale faceva l’ultimo giro alle ore 21 e dopo i moribondi restavano soli, senza alcun conforto, senza nessuno che potesse rispondere alle loro necessità. Il dottor Frasson compiva la sua visita regolarmente senza battere ciglio.

Il dottor Vescovi era stato ferito al braccio e alle gambe, lo avevano ingessato, intanto le ferite sotto il gesso emanavano pus, l’infermo gridava dal dolore. Solo dopo qualche tempo gli venne praticata un’apertura nell’ingessatura; lo si curò con delle sondature per praticare lo svuotamento della vescica da cui usciva un liquido rosso.
Tadiello soffriva per le molte ferite in varie parti del corpo, aveva una gamba sospesa e fratturata in diverse parti. La moglie e la figlia avevano cercato, ma invano, di conoscere la sorte del giovane Carlo che era rimasto ucciso, poi raggiunsero il congiunto ferito e sulle piaghe trovarono anche i vermi, tanto che denunciarono il fatto alle autorità alleate che rilasciarono il permesso di assistere l’infermo. Lo stesso permesso lo ebbe la signora Bigon che bussò a tutte le porte, presso tutte le autorità con coraggio, con tenacia, pur di aiutare il marito.
Pellitteri aveva una gamba maciullata ed era ferito a una mano e alla bocca; Ghezzo aveva una larga ferita e gli si andavano formando molti ascessi, dopo qualche giorno morì.
Vescovi, ferito non in parti vitali, aveva la febbre molto alta, soffriva moltissimo. I suoi gli stavano vicino, erano disperati; la moglie cercava in tutti i modi di confortarlo. Il padre, medico, sembra che a un certo momento abbia intuito che il figlio fosse molto grave e per suo interessamento gli alleati fecero pervenire un farmaco specifico per le infezioni. Ma Vescovi si era aggravato proprio per le infezioni e quando il farmaco arrivò, nella giornata del 18 luglio, i medici lo praticarono nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, ma prima di sera il dottor Vescovi morì.
Nell’ospedale vennero il procuratore del Re e il governatore alleato con altre autorità. Si avvicinarono al letto di Plebani: il governatore gli chiese se avesse riconosciuto qualcuno degli assassini. Plebani, morente, rispose di sì, ma quando l’ufficiale alleato chiese i nomi, Plebani rispose: “Non ho mai fatto la spia in vita mia, vuole che la faccio proprio ora che sto per morire?”.

Nel pomeriggio dell’8 luglio, verso le ore 16, Mario Plebani lasciò la vita terrena comandando ai figli che gli stavano accanto: “Perdonate come io ho perdonato”, lasciando cioè un insegnamento che supera i princìpi di una fazione ed entra nel regno delle più alte manifestazioni di umanità.
Tadiello gridava maledizioni agli assassini di suo figlio e il vecchio Sandonà, febbricitante, delirava canticchiando: “Partigiani di razza dannata”. Settima Bernardi morì dopo tante sofferenze, la sorella Quinta era rimasta uccisa nelle carceri, il padre settantenne era stato prelevato, ucciso e sotterrato in una campagna.
“Nessuna mano amorosa — scrisse il Giornale di Vicenza — ha bagnato quelle labbra arse dagli spasimi della morte, nessuna mano amica ha chiuso gli occhi vitrei, sbarrati dal terrore della morte violenta, nessuno ha composto quei corpi e quelle membra delicate, nessuno ha raccolto la loro ultima parola, la loro ultima preghiera.
I rivoli di sangue purpureo si succedevano ai rivoli per tutto il mesto tragitto, come a inghirlandare coloro che solitari, con la sola scorta dei soldati alleati, si avviavano verso l’ultima dimora, verso il sonno che non ha risvegli. Alle prime luci dell’alba del 7 luglio 1945, in via Baratto, via Fusinato, fino al cimitero, si rispecchiavano le tracce di sangue purpureo, tragico, sbalorditivo annuncio per gli scledensi e per il mondo”».

La strage di Schio costò la vita a cinquantatré persone, sette delle quali morirono nei giorni successivi. Questi i loro nomi, assieme ad alcuni tratti caratteristici:
| 1. |
Amadio Teresa, anni 41, operaia tessile, di Magrè di Schio |
| 2. | Arcaro Teresa, anni 45, impiegata, di Torrebelvicino |
| 3. | Arlotta Michele, anni 62, di Patti (Messina), primario chirurgo a Schio. Stimato e benvoluto da tutti, aveva più volte salvato ebrei e partigiani precludendo ai tedeschi l’ingresso in ospedale. Morendo, fece scudo col suo corpo ad alcune giovani donne. Al momento dell’eccidio giaceva da due giorni a Schio il suo ordine di scarcerazione firmato dalla Corte d’assise di Vicenza |
| 4. | Baldi Irma, anni 20, casalinga, di Chiuppano (Vicenza). Era stata fermata e imprigionata per costringere il padre — ammazzato dai partigiani a maggio nei pressi di Conegliano — a presentarsi |
| 5. | Baù Giovanni, anni 24, commerciante, di Torrebelvicino. Deceduto all’ospedale di Schio l’8 luglio 1945 |
| 6. | Bernardi Settima, anni 21, operaia, di Giavenale di Schio. Venne uccisa assieme alla sorella Quinta (vedi sotto), dopo essere stata incarcerata in quanto fidanzata di un militare della RSI. Il padre, settantenne e padre di undici figli, era già stato ammazzato dai partigiani ai primi di aprile, a Giavenale di Schio. Morì all’ospedale di Schio il 7 luglio 1945 |
| 7. | Bernardi Quinta, anni 28, operaia tessile, di Giavenale di Schio |
| 8. | Bettini Umberto, anni 40, impiegato, residente a Schio e originario di Bologna. Venne ucciso assieme alla moglie, Fernanda Franchini |
| 9. | Bicci Giuseppe, anni 20, impiegato, di Montevarchi (Arezzo), studente in servizio nella Milizia della strada |
| 10. | Calvi Ettore, anni 45, tipografo, di Magrè di Schio. A 20 anni era stato a Fiume con Gabriele d’Annunzio |
| 11. | Ceccato Livio, anni 37, impiegato di Schio. Ebbe un fratello ucciso negli ultimi giorni della guerra civile. Lasciò moglie e due figli nella più nera indigenza. Nel dopoguerra la sua tomba venne profanata da ignoti |
| 12. | Dal Collo Maria Teresa, anni 56, casalinga, di Cogollo del Cengio |
| 13. | Dal Dosso Anna, anni 19, operaia al “Lanificio Rossi”, di Magrè di Schio. Era stata incarcerata per essere fidanzata a un alpino della “Monterosa” |
| 14. | Dal Santo Antonio, anni 37, operaio, di Schio |
| 15. | Dal Cucco Irma, anni 19, casalinga, di Valli del Pasubio |
| 16. | Dellai Francesco, anni 42, cardatore presso il “Lanificio Rossi”, di Torrebelvicino |
| 17. | De Munari Arturo, anni 43, tessitore, deceduto il 7 luglio 1945 all’ospedale di Schio |
| 18. | Fadin Settimo, anni 49, commerciante, di Schio |
| 19. | Faggion Mario, anni 27, autista, già in servizio nella GNR come autiere |
| 20. | Fasson Severino, anni 20, calzolaio, di Villa d’Este (Padova). In servizio nell’Esercito (contraerea) |
| 21. | Fistarol Giuseppe, anni 47, originario di Belluno e residente a Schio, impiegato all’“Italcementi”, maggiore in servizio al Genio militare. Deceduto all’ospedale di Schio il 7 luglio 1945 |
| 22. | Franchini Fernanda, anni 39, casalinga, originaria di Sella Predosa e residente a Schio. Il marito venne ucciso nello stesso eccidio |
| 23. | Govoni Silvio, anni 55, impiegato, di Ferrara, ufficiale di amministrazione presso il Comando della “Brigata Nera” |
| 24. | Lovise Angela-Irma, anni 44, casalinga, originaria di Isola Vicentina e residente a Schio |
| 25. | Lovise Blandina, anni 33, impiegata, sorella di Angela-Irma |
| 26. | Magnabosco Lidia, anni 18, casalinga, di Schio |
| 27. | Manovani Roberto, anni 44, segretario comunale di Tretto, domiciliato a Schio, originario di Novara |
| 28. | Marchioro Isidoro Dorino, anni 35, commerciante, laureato in economia e commercio, di Magrè. Dopo la sua incarcerazione, il magazzino gli era stato saccheggiato e la casa, dove s’era installato un comando partigiano, spogliata. Dopo la sua morte, la famiglia — moglie e quattro figli — restò nella più completa indigenza. Il fratello Domenico, 20 anni, era già stato seviziato e ucciso a Pedescala. Era stato segretario del Fascio di Schio e di S. Vito di Leguzzano |
| 29. | Menegardi Alfredo, anni 17, capo stazione della “Società Veneta” di Piovene Rocchette |
| 30. | Miazzon Egidio, anni 44, originario di Monticello Conte Otto (Vicenza) e residente a Schio dov’era impiegato presso la locale “Associazione Commercianti” |
| 31. | Mignani Giambattista, anni 26, commerciante, di Torrebelvicino. Era stato militare nella contraerea |
| 32. | Nardello Luigi, anni 35, cuoco, di Santorso (Vicenza) |
| 33. | Pancrazio Giovanna, anni 31, impiegata, di Torrebelvicino |
| 34. | Perazzolo Alfredo, anni 29, meccanico. Il padre rimase ferito nello stesso eccidio |
| 35. | Plebani Mario, anni 49, commerciante. Volontario della Grande Guerra, aderì al primo fascismo estraniandosi in seguito da ogni attività politica. Nel 1924, per aver espresso duri giudizi sulla piega che stava prendendo il fascismo, venne arrestato e scontò 15 giorni di carcere. Fascista di sinistra, dopo l’8 settembre rientrò nella scena politica, collaborando alla costituzione del PFR di Schio. Uomo noto e stimato, fu presidente e fondatore della società calcistica scledense e dirigente della Federazione di atletica leggera. Arrestato e incarcerato a Schio durante la guerra civile, nonostante avesse in passato salvato la vita a numerosi partigiani catturati dai tedeschi, respinse sdegnosamente l’interessamento di un prelato tendente a farlo scarcerare. Prima di cadere nell’eccidio, si rivolse a uno degli assassini mascherati invitandolo a risparmiare almeno donne e ragazzi, ma il bandito gli rispose facendosi consegnare l’orologio d’oro che teneva al polso. Morirà l’8 luglio 1945 all’ospedale di Schio |
| 36. | Ponzo Vito, anni 58, commerciante, originario di M. San Giuliano (Trapani) e residente a Schio |
| 37. | Pozzolo Giuseppe, anni 46, impiegato, di Torrebelvicino. Lasciò la moglie e tre figli in tenera età |
| 38. | Rinacchia Giselda, anni 25, operaia, di Schio. Il padre era deceduto in stato di detenzione presso l’ospedale di Schio, mentre un fratello, ventitreenne ufficiale degli alpini, era stato ucciso in maggio in Val d’Aosta |
| 39. | Rizzoli Ruggero, anni 51, avvocato, di Schio, combattente pluridecorato della Prima e della Seconda Guerra. Già componente la Commissione di armistizio con la Francia e membro della Segreteria di Mussolini, si era più volte battuto per salvare partigiani e sbandati. Per questo, in marzo, era stato arrestato dai tedeschi. Venne liberato il 26 aprile, all’arrivo degli americani. Nuovamente incarcerato in maggio, questa volta a opera dei partigiani, al momento dell’eccidio giaceva presso il presidente del CLN Bolognesi un ordine di scarcerazione emesso dal presidente della Corte d’assise di Vicenza, Ettore Gallo |
| 40. | Rossi Leonetto, anni 20, studente, di Milano, in servizio nella Milizia della strada |
| 41. | Sandonà Carlo, già barbiere a Schio, pensionato ultrasettantenne. Deceduto all’ospedale di Vicenza il 27 luglio 1945 |
| 42. | Sella Antonio, anni 60, farmacista e produttore di specialità medicinali nell’omonima azienda di Schio. Combattente della Grande Guerra, già podestà di Magrè e di Valli del Pasubio. Al momento dell’eccidio era già giunto a Schio l’ordine di scarcerazione da parte della Corte d’assise di Vicenza |
| 43. | Slivar Antonio, anni 65, pensionato, originario di Zara e già impiegato al “Lanificio Rossi”. Incarcerato col figlio ventiquattrenne, riuscì a salvarlo nell’eccidio proteggendolo col proprio corpo |
| 44. | Spinato Luigi, anni 36, di Torrebelvicino, mutilato civile, addetto alla portineria al “Lanificio Rossi”. Al momento dell’eccidio giaceva da due giorni a Schio il suo ordine di scarcerazione emesso dalla Corte d’assise di Vicenza |
| 45. | Stefani Giuseppe, anni 63, impresario, di S. Pietro Valdastico, già podestà e giudice conciliatore in quel paese |
| 43. | Stella Elisa, anni 68, casalinga, di Schio. Era stata incarcerata perché accusata di nutrire sentimenti fascisti da un suo inquilino (moroso nel pagamento dell’affitto) che si era unito ai partigiani |
| 47. | Tadiello Carlo, anni 22, studente universitario, in servizio come ufficiale nella GNR. Nell’eccidio fece scudo al padre col proprio corpo salvandogli la vita |
| 48. | Tomasi Sante, anni 53, impiegato presso la “Società Valbrenta”. Iscritto all’“Azione Cattolica” di Magrè e fondatore della locale “San Vincenzo”, venne richiamato col grado di capitano degli alpini e assegnato al distretto militare di Vicenza dove si prodigò senza sosta per i giovani richiamati alle armi. Era anche stato comandante di un reparto di protezione impianti e pronto soccorso alle vittime dei bombardamenti. Lasciò moglie e cinque figli |
| 49. | Tonti Luigi, anni 48, commerciante di dolciumi. Titolare di un’azienda commerciale che aveva già subìto due rapine a opera di partigiani |
| 50. | Trentin Francesco, anni 56, invalido, operaio tessitore, di Schio |
| 51. | Vescovi Giulio, anni 35, dottore in legge, dirigente del “Lanificio Rossi”. Pluridecorato sul campo nella guerra d’Africa. Dopo la sua nomina, a 34 anni, a commissario prefettizio di Schio, si distinse in più occasioni, contribuendo anche a salvare il “Lanificio Rossi” e il ponte sul Leogra che i guastatori tedeschi avevano avuto ordine di distruggere. Concordò il patto di tregua con il CLN, patto mai rispettato dalla parte avversa. Durante l’eccidio alle carceri si batté coraggiosamente per salvare la vita ai detenuti intervenendo senza risultato presso gli aguzzini. Ferito in modo leggero alle braccia e alle gambe durante la sparatoria, morì il 18 luglio all’ospedale di Schio per un ritardo nella somministrazione dei farmaci. Lasciò moglie e una figlia in tenerissima età |
| 52. | Ziliotto Ultimo-Giulio, anni 38, ragioniere presso il “Lanificio Rossi” di Schio. Animatore del locale Motoclub, era stato l’ideatore del “Raduno internazionale alpinistico del Pasubio”, sorto per ricordare i combattenti della Grande Guerra. Al momento dell’eccidio giaceva da due giorni a Schio il suo ordine di scarcerazione emesso dalla Corte d’assise di Vicenza |
| 53. | Zindolini Adone, anni 47, rappresentante di commercio, di Schio. Era stato incarcerato senza motivazione |
| 54. | Lovise Adone, anni 40, impiegato, residente a Schio |
Oltre a questi, come si legge nella sentenza pronunciata nel 1952 dalla Corte d’assise di Milano, nell’eccidio «altri quindici rimanevano più o meno gravemente feriti:
Luigi Bigon, di anni 42, rappresentante di commercio; Antonio Borghesan, di anni 19, elettricista; Giuseppe Cortiana, di anni 53, impiegato; Maria Dall’Alba, di anni 23, casalinga; Anselmo Dal Zotto, di anni 25, studente; Guido Facchini, di anni 25, muratore; Giuseppe Faggion, di anni 36; Anna Bruna Franco, di anni 17, studentessa; Carlo Gentilini, di anni 38, ingegnere; Emilio Ghezzo, di anni 47, meccanico; Olga Pavesi, di anni 42, casalinga; Calcedonio Pellitteri, di anni 30, impiegato; Arturo Perin, insegnante; Rino Tadiello, di anni 55, insegnante; Rosa Tisato, di anni 35, operaia.
Altri due leggermente feriti: Mario Fantini, di anni 24, ed Emilia Gavasso, di anni 49. Totale dei feriti: diciassette.
Scamparono perché coperti dalla massa dei colpiti o riparatisi in qualche modo: Giovanni Alcaro, Bruno Busato, Pietro Calgaro, Diego Capozzo, Augusto Cecchin, Alessandro Federle, Vittorio Federle, Agostino Micheletto, Umberto Perazzolo, Caterina Sartori, Ferrj Slivar, Alfredo Tomasi, Basilio Trombetta».


