a cura di Cornelio Galas
Fonte: Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Scienze Politiche. Titolo Tesi: “La campagna di Russia (C.S.I.R.- A.R.M.I.R. 1941-1943) nella memorialistica italiana del dopoguerra”. Anno accademico 1999-2000.
Gli ospedali
Anche le descrizioni delle condizioni di vita all’interno degli ospedali di retrovia non forniscono un quadro lusinghiero nei confronti della macchina organizzativa e della moralità presenti nell’esercito italiano.

Non si tratta in questo caso delle infermerie e dei medici che operavano a stretto contatto con le truppe di prima linea, con le quali venivano condivise le sofferenze e le difficoltà della guerra, ma degli ospedali situati alle spalle del fronte, ben lontani dalla guerra sia sotto l’aspetto della distanza che sotto quello della partecipazione emotiva.
Gli ospedali, gli infermieri, i medici, rivestono un ruolo fondamentale per i soldati impegnati in guerra sia sotto l’aspetto prettamente operativo, in quanto a loro è demandata la cura dei feriti, ma anche, e sopratutto, sotto l’aspetto psicologico.
Un combattente ferito è naturalmente costretto, dalla sua condizione, ad affidare la propria sorte nelle mani della grande famiglia dell’esercito, in questo caso l’apparato medico-sanitario, dalla quale si aspetta di essere ripagato con impegno, professionalità e dedizione, in virtù dei sacrifici che fino a quel momento ha dovuto sopportare.

La percezione che invece di un fraterno cameratismo la loro condizione di feriti provocava quasi un fastidio in coloro che erano adibiti alle cure, produceva lo stesso effetto di tradimento e delusione che è stato rilevato nel caso del comportamento della sussistenza.
“Alle 18 raggiungiamo l’ospedale da campo 873. Come entriamo nel cortile, comprendiamo che qui se ne fregano. Fa freddo e piove, e non un cane di infermiere che arrivi a tirar fuori i feriti. Dopo sei ore di autoambulanza siamo stanchi e sbattuti.
Comincio ad urlare, a maltrattare i primi infermieri che incontro. Tutto procede con molta lentezza e menefreghismo. Il capitano medico, un veronese, si disinteressa completamente del nostro arrivo. Degli altri ufficiali medici, nemmeno l’ombra. E pensare che sono arrivati dal fronte ben trentasei feriti…
Queste bestie di infermieri non ne indovinano una giusta: servono il caffelatte con la forchetta, offrono pane e marmellata ad uno operato di appendicite… Mi rivolgo ad un sottufficiale, chiedo del medico di guardia, aggiungo che un ufficiale sta morendo dissanguato. – Non so se venga, bisogna accertarsi che sia proprio grave –, è la sua risposta. Gli metto le mani addosso”.

Naturalmente come per tutti i reparti adibiti alla sussistenza anche per gli ospedali è necessario considerare che tutte le deficienze organizzative che spesso non erano attribuibili in maniera diretta alle loro responsabilità. Ma nonostante questa considerazione bisogna però aggiungere che quello che maggiormente colpiva e feriva i soldati della prima linea non era la disorganizzazione e la mancanza di materiali, ma la mancanza di passione, dedizione e sopratutto di spirito di solidarietà nei loro confronti.

I feriti avevano chiara la sensazione di non essere al primo posto nelle attenzioni e nelle occupazioni dei medici e degli infermieri che sembravano essere più preoccupati dalle questioni formali, dalla burocrazia e spesse volte dai loro piccoli traffici tesi a rendere più comoda e confortevole la loro condizione.
“Sporcizia, sporcizia ovunque. Non parliamo poi dei soldati stesi per terra, in tutti i sensi, così che non potei neppure avvicinarmi a coloro che conoscevo, per non schiacciare gli altri. Ebbene, quei feriti, quando giunsero alla divisione…furono fatti attendere altre tre ore, dalle 3 alle 6 del mattino, stesi su una barella in mezzo alla strada.
E finalmente ammonticchiati su un autocarro e trasportati al più vicino ospedale tedesco. Qui sono stati curati e messi in un lettino pulito: avevano tè, caffè, cognac, pane bianco e burro. Ma il giorno dopo il capo ufficio sanitario, pensando che non fosse decoroso che una divisione celebre facesse curare i suoi feriti dai tedeschi, dà l’ordine di mandarli a prendere, assicurando il generale che la nostra sezione Sanità avrebbe potuto curarli altrettanto bene.

Ma non dice che la nostra sezione Sanità non è ancora giunta…non dice che non poteva disporre di un solo lettino, di un litro di cognac, di un bidone di latte. E così quei disgraziati, per il volere di un delinquente medico, vennero accatastati come porci in un locale sporco e freddo. E da ieri mattina a tutta questa sera non hanno avuto un etto di pane, un dito di brodo. Nulla!…
Non c’è bisogno di fare commenti: ma quei feriti, se torneranno a Milano, avranno l’onore di salire sul palco reale della Scala? Avranno un pacco dono e un pacchetto di sigarette; con le quali cose il P.N.F. crederà di avere saldato il debito di gratitudine della Patria”.
Da queste testimonianze, come da quelle precedenti, traspare come il comportamento scarsamente partecipe e solidale da parte delle retrovie nei confronti dei soldati impegnati al fronte producesse un forte senso di distacco nei confronti dell’autorità.

Crocerossine assistono al passaggio di truppe italiane destinate al fronte orientale russo nell’estate 1942
Con questo non bisogna evidentemente considerare che nelle retrovie si vivesse una vita completamente indifferente alle sofferenze dei combattenti o che non ci fossero istituzioni o singoli individui che non si impegnassero a fondo per migliorarne le condizioni.
Ma è altrettanto evidente come, sopratutto quando le cose cominciarono a mettersi male, si produsse uno scollamento nel livello di solidarietà tra i differenti gruppi presenti all’interno dell’esercito.
Il cameratismo e l’unione presente tra i soldati che combattevano fianco a fianco scompare quando invece deve indirizzarsi verso coloro i quali, nell’ideale collettivo, rivestivano il ruolo di approfittatori e traditori della causa comune.

Inevitabilmente si crea un diffuso senso di rifiuto nei confronti di quell’autorità che non è colpevole solamente dell’imminente disastro, che avrebbe potuto peraltro essere inevitabile, ma, cosa molto più grave, si è colpevolmente disinteressata ed ha speculato sulla pelle di coloro i quali dovevano invece sopportare maggiormente il peso della guerra.
Via via che aumentano le difficoltà e che la situazione diviene più drammatica l’accusa di tradimento passa dalla logistica, dalla sussistenza, dalla sanità, dalle retrovie in genere, fino all’autorità suprema, cioè il partito fascista responsabile di aver prodotto e avallato il degrado morale delle retrovie mentre proclamava una società basata sul valore personale e sull’esaltazione del coraggio.
Si accendono sentimenti di rivalsa che fanno sperare in fantasiose rivoluzioni in patria o che producono desideri di vendetta, mentre contemporaneamente si spengono gli artefatti vincoli della gerarchia basata sul grado anziché sul valore.

Coloro che non rischiavano la vita al fianco dei loro compagni non sono più dei commilitoni, ma dei volgari imboscati alla ricerca di privilegi e di una facile gloria a basso costo.
Gerarchia e disciplina
“Non tutti i generali abbandonarono le truppe, non tutti gli ufficiali si strapparono i gradi; molti colonnelli comandanti di reggimento spartirono la sorte dei loro reparti, molti subalterni stettero sino alla fine con i popolani del loro plotone. Ma questi furono nel complesso episodi isolati, come isolati furono gli episodi di vergognosa viltà e di feroce egoismo […]
Rimane il fatto che su centoventicinquemila uomini dei due corpi di armata e truppe di rinforzo, quarantacinquemila si misero in salvo; su venti generali se ne misero in salvo diciotto, su una cinquantina di ufficiali di stato maggiore non so se ne mancarono cinque. La sproporzione è evidente e le condizioni in cui si sono svolte le operazioni non la giustificano […]

Il momento di dimostrare con i fatti la loro buona fede era giunto: restando sul posto, eseguendo per primi gli ordini che trasmettevano ai loro inferiori, non avrebbero fatto niente di più del loro dovere. Ed era l’unico modo per essere assolti dall’errore e salvare l’onore… Gli innocenti muoiono ed i colpevoli si salvano”.
Queste parole di Tolloy riassumono in maniera chiara ed efficace l’immagine dei comandi e degli ufficiali superiori che traspare dalla lettura delle memorie di guerra. Esprimere un giudizio complessivo ed univoco sul rapporto tra ufficiali e soldati all’interno del contingente italiano e sul comportamento dei comandi in genere risulta cosa assai difficile dato il gran numero di episodi individuali, in un senso od in un altro, presenti nella memorialistica.

Il disastro della ritirata, con tutte le sue tragiche conseguenze ed il desiderio di individuare colpevoli e responsabili, influiscono poi in maniera decisiva sul giudizio che i reduci danno del comportamento tenuto dai loro superiori.
Il primo aspetto che bisogna mettere in luce è costituito dalla subordinazione dell’operato dei Comandi alle direttive ed alle esigenze dell’alleato tedesco spesso incurante delle esigenze italiane.
Il ruolo del contingente italiano in Russia era sicuramente marginale rispetto all’immane sforzo bellico che stava compiendo la Wehrmacht nel tentativo di piegare la resistenza sovietica. Appare naturale quindi che le operazioni ed i compiti dell’esercito italiano dovessero essere subordinati alle esigenze delle strategie tedesche.

Purtuttavia la prima responsabilità del comando è rivolta verso i propri uomini e verso le loro possibilità, che non dovrebbero essere sottoposte al desiderio di compiacere un pur così potente alleato.
Drammaticamente eclatante in questo senso la decisione, o forse si dovrebbe dire l’indecisione, di far restare per un mese le unità alpine a fronteggiare un nemico che aveva già sfondato in più punti il fronte, e che già operava alle sue spalle, solamente per permettere alle truppe tedesche di ritirarsi in buon ordine. E d’altronde anche precedentemente era accaduto che i soldati italiani fossero stati sacrificati alle esigenze tedesche.

“I quali (tedeschi), Stalino, come tutto il resto, l’hanno voluto solo per loro. E noi, come al solito, abbiamo fatto la figura dei fessi… E’ stato pure interessato S.E. Messe ma i tedeschi non hanno mollato…Sono tre giorni che non mangiano. Non mangiano e combattono. E’ un mese che non si riceve posta da casa, un mese che non si fuma una sigaretta vera… Gente che prega di poter raccogliere le briciole che rimangono nelle cassette di gallette…
E così i nostri Comandi mandano in linea una divisione!…Non ho paura di dire che chi manda avanti una divisione nello stato in cui si trova la nostra, senza mangiare, colle scarpe rotte, le uniformi a brandelli, senza munizioni… quel tale è un assassino.
I tedeschi, arrivati a Stalino, e arrivati con tutti i mezzi e tutti i servizi hanno fatto tuttavia un alt per ricomporsi e riposarsi. Noi: avanti! Avanti coi fianchi scoperti; avanti affamati, laceri, senza munizioni… Questi sono i delitti che si commettono impuniti. Che anzi, quelli che li commettono… diventeranno commendatori dell’ordine militare di Savoia o simili”.

La testimonianza del sottotenente Mauro Taccini:
“Una circolare del comando generale tedesco, a firma Hitler, imponeva a tutti i combattenti di non muoversi di un metro dalle posizioni assegnate… C’era da ridere, se non si fosse trattato della nostra pelle, a pensare a un caposaldo come il nostro che resiste anche superato da una avanzata russa…
I nostri comandi non furono da meno e disposero con diverse circolari che si completassero le recinzioni dei capisaldi con reticolati, che non c’erano, che si facessero nuove fortificazioni, con attrezzi, uomini e armi che non c’erano, e che infine si procedesse a un infittimento del fronte, immettendovi le truppe tenute in retrovia. Quest’ultima era la più grande corbelleria del repertorio”.

Oltre alla subordinazione all’alleato nazista, che spesso pregiudicava anche le esigenze basilare e primarie delle truppe italiane, anche lo stato di impreparazione, sopratutto sotto l’aspetto del materiale e della tecnologia, produsse un forte senso di scoraggiamento tra i soldati.
Il paragone con l’apparato bellico altrui poneva le unità italiane in una condizione di netta inferiorità nei confronti tanto dell’alleato tedesco quanto dell’avversario sovietico. I tragici effetti dell’approssimazione nella preparazione della spedizione da parte delle autorità italiane divennero sempre più evidenti mano a mano che l’esercito sovietico cominciava a riconquistare l’iniziativa delle operazioni.

Il costo dei sacrifici necessari per tenere testa ad un nemico sempre più intraprendente divenivano ogni giorno più alti, e conseguentemente cresceva il disappunto dei combattenti nei confronti della superficialità con la quale erano state organizzate prima, e venivano gestite ora, le unità italiane.
Oramai era divenuto evidente che la facile crociata antibolscevica promossa e promessa dal fascismo per questioni di prestigio nazionale si stava tramutando in un disastro dalle proporzioni preoccupanti, e all’entusiasmo della vigilia cominciava a subentrare il rancore verso la colpevole superficialità delle autorità italiane.
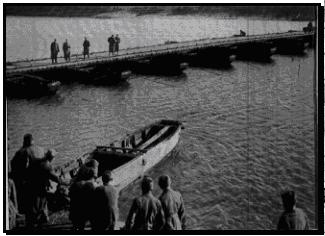
“La constatazione di tale realtà alleata, ed il confronto inevitabile con la nostra miseria, costituirono un secondo vero shock per tutti, poiché il primo era stata la presa di coscienza dell’immensità della Russia…
Di fronte a questi scoraggianti elementi di fatto, fra gli ufficiali, che peraltro non si erano ancora potuti rendere conto ben a fondo del formidabile armamento e del numero infinito dei sovietici, insorsero, prepotenti, un palese rancore e aperti desideri di rivalsa nei riguardi di chi aveva mandato a simile sbaraglio loro e i loro subordinati”.

Parole ancora più dure le esprime Eugenio Corti ormai spossato dalla fatica e dal gelo:
“E il vento non cessava, e ci esplorava assiduamente per tutta la superficie del corpo, instancabile nel suo tentativo di strapparci la vita…
Mi venne fatto di pensare ai nostri capi, che avevano dichiarata la guerra: in questo momento erano a Roma al caldo, nel loro lusso abituale; forse stavano dormendo in soffici letti. E avevano mandato i soldati in questo clima, con queste scarpe, equipaggiati a questo modo! – Porci! Figli di cane! –
… Tutti noi, ciascuno in modo più o meno chiaro, a seconda delle sue possibilità d’intuizione, avvertivamo questo…Non era possibile, noi lo sentivamo, che cose enormi come quelle che stavamo vivendo, dipendessero dall’arbìtrio di pochi, piccoli uomini”.

Se il risentimento nei confronti delle autorità politiche e militari di Roma è riscontrabile in maniera diffusa nelle memorie, fino al punto, come vedremo più avanti, di travolgere le convinzioni sul regime fascista, differente è il discorso per quanto riguarda il rapporto con gli ufficiali ed i superiori che parteciparono in prima persona alla campagna.
In questo caso il giudizio dei reduci sul comportamento tenuto dagli ufficiali è più variegato, essendo legato indissolubilmente alle vicende e alle esperienze vissute individualmente ed al valore dei singoli ufficiali. L’attenzione degli autori si concentra in maniera particolare sulle vicende vissute durante la ritirata, che, data l’asprezza e la durezza del contesto, diviene una sorta di cartina tornasole del valore individuale.

Innanzitutto bisogna rilevare come il ruolo di ufficiale avrebbe dovuto comportare un maggior carico di responsabilità nei confronti dei subalterni, responsabilità derivante sia dal grado che dalle aspettative che i soldati riponevano nella sua figura.
Nella realtà invece emerge come una parte di coloro che avevano il compito di evitare che la ritirata si trasformasse in una disastrosa e scomposta fuga, si preoccuparono sostanzialmente e fin dall’inizio della loro sorte senza adoperarsi per quella altrui.
“Salvare il salvabile. Anche questa teoria non regge più. Nessuno distingue i sacrifici inutili dai necessari. Disordine, indisciplina, incoscienza, insubordinazione, diserzione. E’ il disastro, la fuga pazzesca di una massa senza reparto, senza armi!”.

Gli episodi di vigliaccheria e di egoismo compiuti dagli ufficiali risultano agli occhi dei soldati ancora più gravi e meritevoli di condanna proprio per il ruolo di punto di riferimento che essi rivestivano nelle dinamiche relazionali dei reparti, delle unità e dei singoli gruppi.
Lo spettacolo di ufficiali che si strappavano i gradi per paura di essere riconosciuti dal nemico, o che fuggivano abbandonando le proprie unità alla loro sorte contribuirono in maniera determinante allo sfaldamento della solidarietà e dell’omogeneità organizzativa dell’esercito.

La cosa che feriva maggiormente, e alimentava il rancore prodotto dal senso di abbandono percepito dai soldati, era che un tale riprovevole comportamento raramente era motivato dalla situazione contingente, ma più spesso dai più bassi istinti dettati dall’egoismo, dall’avidità e dalla paura.
“L’ufficiale postale, un tenente anziano, abitava in una casetta poco distante: presi con lui gli accordi per il carico dell’autocarro, consigliandolo di non portarsi dietro il bagaglio personale per non rubare il posto a qualche soldato…quando ritornai, mi accorsi che non solo tutto lo spazio disponibile del cassone era stato occupato da oggetti che nulla avevano a che fare con la vita militare ma che i miei stessi uomini erano rimasti a terra…

Mi ricordo che su quell’enorme catasta di cianfrusaglie facevano mostra di se un orologio a pendolo, una balalaika e una gabbia per canarini… Poi avvenne un episodio sconcertante…un gruppo di scritturali del Comando, frettolosamente armati, era stato distaccato per dare l’allarme in caso di attacco da parte del nemico; naturalmente nessuno si era preoccupato o aveva voluto avvertire della partenza quei poveri soldati ed ora questi, urlando come ossessi, correvano giù per raggiungere la colonna.
Vidi gli ufficiali superiori sbiancare dalla paura: quando uno di essi gridò ordini per accelerare il movimento degli automezzi, capii subito che non la paura del nemico ma la prevedibile reazione di quei soldati, abbandonati al loro destino, consigliava di affrettare quella fuga ignominiosa”.

Certamente non tutti gli ufficiali, di alto o basso grado che fossero, si comportarono in questa maniera, rifiutandosi in ogni modo e con ogni mezzo di condividere la loro sorte con quella dei soldati che per lungo tempo avevano comandato ed ai quali avevano spesso richiesto grandi sacrifici, molti continuarono a combattere accanto ai loro uomini dando loro l’esempio che il grado che portavano gli imponeva di dare.
Valga per tutti il comportamento del generale Martinat, la cui morte viene ricordata con grande commozione in più di un testo, quando volle condividere la sorte dei suoi alpini nella commovente carica per sfondare l’accerchiamento di Nikolajevka.

In quel luogo si svolse uno dei più drammatici episodi di tutta la ritirata di Russia: era uno degli ultimi posti di blocco predisposti dall’esercito sovietico prima che fosse possibile ricongiungersi con le forze tedesche.
Gli uomini della colonna erano arrivati allo stremo delle forze e tutti gli attacchi erano fino a quel momento stati vani di fronte alla forza del nemico. L’accerchiamento fu rotto solo alla fine quando ormai si disperava di poter raggiungere la salvezza con un assalto condotto alla disperata da tutti coloro che erano in grado di muoversi: un’orda di soldati, molti anche senza armi, e di sbandati che senza timore della morte e con la forza della disperazione si riversarono sul nemico costringendolo alla ritirata.

Il Generale di Stato Maggiore Alpino Martinat ebbe la volontà e la forza di condividere la sorte dei suoi uomini in quest’epico assalto finale, dal cui esito dipendeva la sorte di tutta la colonna, e nel quale trovò la morte mentre incitava i soldati all’avanzata.
Il suo coraggio ed il suo valore trovano riscontro nell’impressione, testimoniata da molti autori, che la sua morte suscitò in tutti coloro che lo conoscevano, dagli alti Comandi ai soldati semplici. Il comportamento di Martinat non fu un episodio ne unico ne isolato tra gli ufficiali del contingente italiano in Russia, e molti altri compirono il loro dovere fino alla fine.
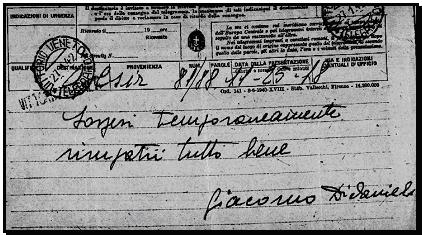
Resta il fatto però che dopo gli avvenimenti della ritirata si produsse una frattura insanabile ed un distacco irreversibile nei confronti di tutte quelle forme di autorità, sia politiche che militari, che si erano rese colpevoli, agli occhi dei sopravvissuti, tanto dello sfacelo organizzativo quanto dell’incurante abbandono dei soldati alla loro sorte.
Il risentimento si manifestò sopratutto quando, dopo la fine della ritirata, si cercarono di ricostituire tutte quelle dinamiche relazionali e gerarchiche presenti prima di quei drammatici avvenimenti. A quel punto però qualcosa si era modificato nell’animo dei reduci che rigettavano ormai un’autorità che non sentivano più di condividere.
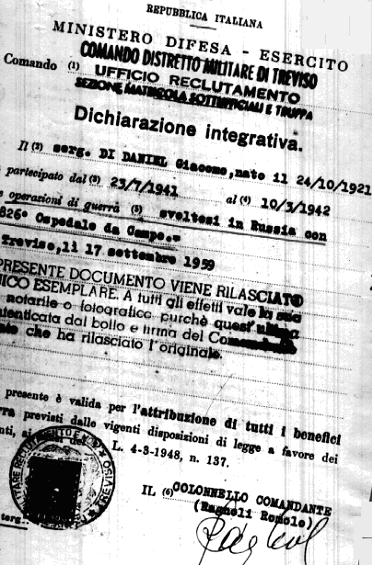
“Gli onesti, i generosi, hanno salvato l’onore del soldato italiano. Gli alti comandi continuano a scandalizzarsi perché molti soldati hanno venduto le armi, materiali e corredo. Ma Dio santo, non capiscono che questa gente ha fame? Date loro da mangiare, e sopratutto non rubate sulle già povere razioni, poi vedrete che lo scandalo cesserà: non dovrete più minacciare con le pene di morte!
E non traditevi con le divise fuori ordinanza, chi non indossa i panni della ritirata ha salvato i propri bagagli: ogni bagaglio salvato vuol dire un ferito abbandonato, vuol dire vergogna e vigliaccheria”.

Ancora dal diario di Nuto Revelli le considerazioni dei reduci di fronte al ripristino delle formalità cerimoniali alle quali furono sottoposti i reduci:
“ – Ricordare e raccontare –, parole d’ordine che cominciano a diventare false, perché ognuno le adopera per tirare l’acqua al proprio mulino. Manaresi ha portato il saluto personale del duce. Cialtroni!
Più nessuno crede alle vostre falsità, ci fate schifo: così la pensano i superstiti dell’immensa tragedia che avete voluto. Le vostre tronfie parole vuote non sono che l’ultimo saluto ai nostri morti. Raccontatela a chi la pensa come voi: chi ha fatto la ritirata non crede più ai gradi e vi dice: – Mai tardi… a farvi fuori!–”.

Questo stato di aperto rancore nei confronti delle autorità ritenute responsabili della tragedia dell’A.R.M.I.R. giunse inevitabilmente fino alle sfere politiche di Roma che si affrettarono a predisporre un piano per il rimpatrio dei soldati che non permettesse al loro stato umorale di trasmettersi alla popolazione civile ancora ignara delle modalità e dell’entità del disastro avvenuto in Russia.
Le unità militari vennero disgregate e disarmate, furono immediatamente nascoste all’opinione pubblica con la scusa di una necessaria pausa in dei campi di disinfezione, non gli fu permesso di sfilare in parata come se non fossero meritevoli del ringraziamento della patria.

“Si ignora a chi e a che si debba imputare tanta insensibilità morale, se ad un incredibile cinismo o ad una pidocchiosa volontà di appiattimento generale.
Forse ad un po’ di tutto questo, ma più probabilmente alla paura, alla responsabilità e all’invidia di un alta direzione politica… e della paritetica direzione militare… che forse paventavano giustamente reazioni armate da parte dei più validi reduci, che speravano di celare con questi mezzi la loro irresponsabilità”


