a cura di Cornelio Galas
Concludiamo oggi, con analisi non solo storiografiche, la prima serie di puntate dedicate al negazionismo. In coda una ricca bibliografia per chi volesse approfondire l’argomento.

LE STRATEGIE DISCORSIVE
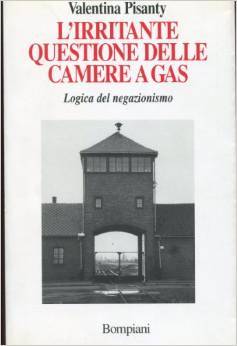
di Valentina Pisanty
Pur sapendo che il passato può solo essere riesumato in modo parziale e impreciso, lo storico moderno non rinuncia ad avanzare ipotesi su come si sono svolti gli eventi trascorsi (“ecco cosa accadde il 14 luglio 1789”), a scommettere sulla loro verità, e a cercare di convincere il resto della comunità degli interpreti che la sua versione dei fatti è quella giusta. Finora mi sono occupata del rapporto dell’interprete con le sue fonti. Tuttavia, il lavoro dello storico non si esaurisce qui. L’altro aspetto da considerare è il modo in cui egli espone le sue argomentazioni, cercando di renderle il più convincenti possibile, magari occultando a fini retorici tutto il lavoro investigativo che ha preceduto la formulazione dell’ipotesi finale.

Valentina Pisanty
Il discorso storico
Lungi dall’essere un veicolo trasparente di verità di per sé evidenti, il discorso storico è disseminato di artifici retorici il cui obiettivo è di influenzare l’atteggiamento interpretativo di un lettore spesso ignaro di essere manipolato. Come il romanzo, anche il testo storico è una narrazione e, come tale, esso “seleziona, semplifica, organizza, fa si che un secolo entri in una pagina”. Se il materiale documentario di partenza fornisce allo storico l’ossatura del suo racconto, le lacune e le contraddizioni di cui i documenti brulicano richiedono il suo intervento creativo per “animare i frantumi che sono sparsi davanti a lui”.
Gli inevitabili interstizi tra i frammenti fattuali vengono dunque riempiti grazie a una pratica affabulatoria: come per la narrazione di storie inventate, anche qui si tratta di ordire un intreccio secondo le regole riconosciute di una logica del racconto.
La presenza di un apparato narrativo è proprio ciò che distingue il discorso storico dalla pura cronaca, la quale introduce gli eventi selezionati in ordine cronologico secondo la struttura aperta e indefinita dell’elenco. Mentre le informazioni veicolate dalla cronaca appartengono tutte a un medesimo piano di pertinenza (quello della registrazione dei fatti secondo la loro successione temporale), la trasformazione della cronaca in storia “si effettua caratterizzando alcuni eventi della cronaca come motivi inaugurali, altri come motivi terminali, e altri ancora come motivi di transizione”.

Si stabiliscono perciò dei rapporti di causa ed effetto tra i vari eventi ritagliati dallo storico come materiale di partenza del suo discorso. Calando gli eventi in una struttura narrativa lo storico offre al lettore un racconto compiuto in cui certi elementi assumono un valore funzionale dominante, laddove altri giocano un ruolo ausiliario e vanno perciò a stagliarsi sullo sfondo, a seconda delle esigenze compositive dettate dall’intreccio.
La consapevolezza dell’aspetto fortemente narrativo del discorso storico ha indotto vari studiosi a occuparsi dei punti in comune tra narrative dichiaratamente immaginarie e racconti che ambiscono a riflettere una realtà che li trascende e li precede. Si è scoperto ad esempio che il saggio scientifico presenta una struttura riconoscibilmente narrativa, imperniata sulla lotta tra un eroe (il ricercatore) e un antagonista (le scuole avversarie) per conquistare un oggetto conteso da entrambi (la Verità), esattamente come accade nella fiaba, dove il principe e il drago lottano per conquistare la principessa.

E’ stato inoltre osservato che talvolta risulta molto difficile decidere se ci si trova di fronte a un testo di finzione o a un resoconto storico a partire dalla semplice superficie linguistica dei testi. Un incipit come “Il 16 agosto 1968 mi fu messo tra le mani un libro dovuto alla penna di tale Abate Vallet…” sembra l’inizio di un saggio o di un articolo giornalistico, mentre si tratta dell’avvio del Nome della rosa.
Tutto ciò ci fa capire che non esiste un segnale incontrovertibile di finzionalità (o di storicità), e perciò il lettore deve combinare insieme una serie di indizi testuali per giungere alla formulazione di un’ipotesi circa il genere di appartenenza del testo. Prendere atto del fatto che la distinzione tra racconto storico e racconto di finzione non è sempre così nitida o immediata come ci piacerebbe pensare, tuttavia, non significa asserire che tra i due generi di discorso non sussiste alcuna differenza significativa.
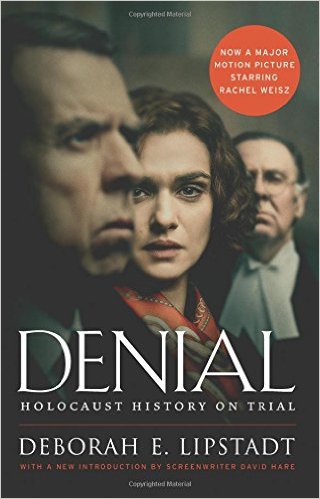
L’odierna corrente del Nuovo Storicismo tende per l’appunto ad annullare ogni specificità del discorso storico, il quale viene considerato come “solo un altro ‘tipo di scrittura’”: visto che la Verità è inattingibile, e che nessuno studioso può pretendere di aver capito una volta per tutte come sono andate veramente le cose”, allora tanto vale considerare il saggio storico alla stregua di un racconto come un altro. Sugli effetti di un simile modello teorico tornerò nell’ultimo capitolo, quando cercherò di delineare il contesto culturale che ha favorito l’emergere delle varie correnti negazioniste negli ultimi decenni.
Per il momento vorrei sottolineare che, checché ne dicano i teorizzatori dell’insussistenza della distinzione tra fatto e finzione, noi siamo quotidianamente chiamati a compiere una scelta tra questi due generi di discorso e, generalmente, tale operazione ci riesce piuttosto bene.
A seconda che riconosciamo di trovarci di fronte a un saggio o a un romanzo, ci accingiamo ad assumere determinati comportamenti di lettura. Il saggio ci esorta a credere che ciò che ci viene raccontato sia effettivamente avvenuto nel mondo dell’esperienza reale e di conseguenza ci invita a verificare da noi (se riteniamo opportuno farlo) la verità dei contenuti espressi (donde l’importanza della bibliografia e della citazione delle fonti originarie nei saggi storici).

Una volta che decidiamo che il saggio è affidabile, siamo disposti ad accettare che tutto ciò che esso ci racconta sia realmente accaduto. Al contrario, leggendo un romanzo sappiamo benissimo che gli eventi narrati non appartengono alla sfera del mondo reale, ma possono essere ricondotti a un mondo narrativo alternativo, e in certi casi incompatibile, rispetto a quello dell’esperienza attuale. Ciò nonostante, fino a quando ci troviamo all’interno di questo mondo (ovvero, finché non finiamo di leggere il romanzo), siamo tenuti a “sospendere la nostra incredulità” per far finta di credere che ciò che ci viene raccontato sia vero.
Solitamente un testo ha ogni interesse a farsi riconoscere subito per ciò che è: a tale scopo, esso è disseminato di segnali di genere (marche di storicità o di finzionalità) volti a incanalare l’attività interpretativa del lettore nel senso voluto. Vediamo ora di capire quali siano le “marche di storicità” grazie alle quali il lettore di un saggio storico identifica il genere di appartenenza del testo.
![]()
Innanzi tutto, un saggio storico è spesso caratterizzato dalla presenza di alcuni artifici grafici – mappe. citazioni con riferimento alle fonti, grafici, tabelle e fotografie che contribuiscono a gettare un ponte tra il discorso e il mondo esterno di cui si suppone esso sia un riflesso fedele. In altre parole, la presenza di una fotografia che accompagni il testo scritto, confermandone i contenuti, conferisce al saggio un effetto di realtà perché funge da efficace “punto di cerniera” tra il discorso storico e la realtà esterna: “vi ho parlato di Eva Braun; ecco la sua foto (visto che non mentivo?)”.
Altre marche di storicità riguardano il paratesto (la cornice che circonda il testo vero e proprio, dalla copertina alle note a piè di pagina) in cui è inserito il discorso fattuale: la presenza di intertitoli e di capitoli a numerazione analitica, l’uso diffuso di note esplicative dal carattere riconoscibilmente scientifico, l’inserimento di una bibliografia finale, ecc., sono tutti dispositivi formali tipici della saggistica. Sembrerebbe cosi possibile individuare alcuni artifici discorsivi che caratterizzano la scrittura storica, distinguendola dalla fiction.

SCRITTE ANTISEMITE A ROMA, “OLOCAUSTO UNA MENZOGNA”- Scritte antisemite sotto il ponte di Batteria Nomentana. Stanotte a Roma, sono comparse scritte antisemite recanti la firma Militia, e accompagnati da svastiche. Proprio ieri ricorreva il 65/mo anniversario della razzia al ghetto
Tale riconoscimento immediato di genere è tuttavia ostacolato dal fatto che sempre più spesso la fiction ha preso ad appropriarsi delle marche generiche tipiche della scrittura fattuale. Non c’è limite alle capacità mimetiche della letteratura di finzione, e per ogni caratteristica formale attribuibile al genere della scrittura storica vengono in mente innumerevoli controesempi letterari che annullano l’efficacia distintiva di ciascuna marca presa singolarmente.
Si può allora procedere in senso inverso e indicare le marche di finzione grazie alla cui azione combinata possiamo, se non altro, escludere di trovarci di fronte a un saggio storico. A parte i più evidenti tratti della letteratura di finzione, quali i segnali paratestuali (appartenenza a una collana, titolo, prière d’insérer, ecc.), l’uso di formule introduttive che invitano il lettore a sospendere ogni controllo sulla veridicità dei fatti narrati (l’esempio più ovvio è il “c’era una volta” fiabesco) e la costruzione di un mondo narrativo chiaramente incompatibile con il mondo dell’esperienza attuale del lettore (ad esempio, un mondo in cui i lupi siano in grado di parlare), le marche di finzione coinvolgono:
(i) il trattamento del tempo
Nei romanzi immaginari – questo è molto più sganciato dal tempo “reale” di quanto non avvenga nei saggi storici, dai quall esigiamo la ligia adesione a una cronologia storiograficamente documentata (si pensi ai problemi di datazione che abbiamo avuto nella lettura delle memorie di Rudolf Höss). Preso singolarmente, tale segnale di genere non è pero sufficiente per il riconoscimento di un testo di finzione: basti pensare ai romanzi storici, i quali possono imporsi le medesime costrizioni temporali del saggio storiografico;
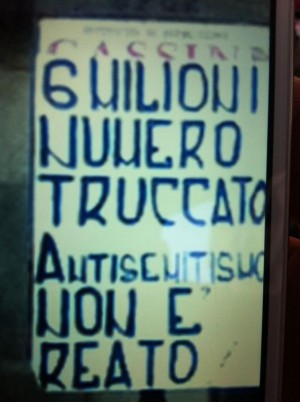
(ii) il rapporto tra la storia raccontata e il materiale di partenza
Nella fiction tale rapporto non è vincolante come lo è nel saggio, dove l’esigenza di rispettare le fonti impone grandi limitazioni all’intreccio. Perfino il romanzo storico, nel momento in cui passa a occuparsi delle vicende di personaggi minori di cui non esistono attestazioni storiche, riacquista la libertà di sganciarsi dal materiale documentario;
(iii) la completezza del mondo testuale evocato
Solo i racconti di finzione possono permettersi di costruire un mondo testuale completo e internamente coerente, in cui la sequenza delle azioni possa essere considerata definitivamente conclusa a scrittura (e lettura) terminata. Al contrario, il mondo di cui tratta il saggio storico – dal momento che si identifica con il mondo dell’esperienza attuale – trascende i confini del testo con la conseguenza che quest’ultimo non puo che ammettere la parzialità della propria ricostruzione.

Così, mentre nei piccoli mondi della narratività vige una logica stringente che fa sì che, una volta poste le coordinate e le regole del gioco testuale, si possano individuare al loro interno verità incontestabili (non c’è dubbio che Otello uccida Desdemona per gelosia), nel mondo evocato dal discorso storico non è possibile ricostruire delle catene causali isolate non soggette a revisioni. Infatti, queste ultime si troverebbero sempre a fare i conti con l’interferenza di insondabili fattori esterni – concause, ipotesi alternative, ecc. – che rendono vano ogni tentativo di ridurre il mondo reale a un modello definitivamente posto di mondo possibile testuale.
L’ipotesi di genere richiede dunque una complessa attività inferenziale grazie alla quale il lettore, dopo aver soppesato accuratamente l’apporto combinato dell’insieme dei segnali testuali, si predispone ad assumere l’atteggiamento fruitivo che giudica adeguato al tipo di testo di fronte al quale crede di trovarsi.

Va comunque sottolineato che, con la possibile eccezione di casi-limite di mancato riconoscimento di genere (di cui La guerra dei mondi di Orson Welles costituisce un caso paradigmatico), i testi sono strutturati in modo tale che – sia pure attraverso una serie di tentennamenti iniziali – alla fine il lettore sia messo in grado di operare la sua scelta in maniera inequivoca.
Nei rari casi in cui tale scelta sia ostacolata dalla struttura stessa del testo (ad esempio, romanzi camuffati da libri di storia), ci troviamo di fronte a tranelli calcolati per indurre in errore il lettore; ma, si badi bene, la strategia comunicativa adottata da simili testi funziona proprio grazie al fatto che il Lettore Modello, dopo aver riconosciuto in essi segnali di genere ingannevoli, ha la possibilità di ricollocarli adeguatamente nell’ambito del sistema dei generi e di apprezzare l’effetto di sorpresa causato dal suo iniziale spaesamento.
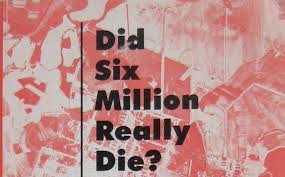
Indagine storiografica e testi divulgativi
Al lettore del saggio storico è richiesto un atto di fiducia basato sul riconoscimento dell’autorità dello scrittore in quanto soggetto competente nella materia di cui il saggio tratta. Solo così è possibile arrestare momentaneamente la continua richiesta di prove supplementari (tipica di un’interpretazione sospettosa) che inibirebbe lo svolgersi della narrazione storica.
Tale riconoscimento di una competenza autoriale è accompagnato dalla possibilità, offerta al lettore, di verificare da sé se la sua fiducia sia stata saggiamente riposta: grazie alla citazione delle fonti documentarie, infatti, egli puo ricostruire il percorso interpretativo intrapreso dallo storico per valutarne l’appropriatezza, ovvero l’adesione o meno a principi epistemologici generalmente accettati.

Ne consegue che un testo di vera e propria ricerca storiografica tenderà a non occultare –
ma semmai a mettere in rilievo – i punti in cui lo storico, trovandosi di fronte a un ventaglio di possibili ipotesi suggerite da un medesimo frammento documentario, abbia scelto un’opzione di lettura piuttosto che le altre. Si veda, a titolo d’esempio, questo brano tratto da un saggio di Robert Darnton:
“ho cercato, dunque, di farmi strada con la lettura attraverso il Settecento e ho aggiunto in appendice i testi relativi alle mie interpretazioni, in modo che il mio lettore possa interpretarli e non essere d’accordo con me”. (Darnton, 1984)
Al contrario, un testo storico di tipo divulgativo appianerà tali increspature esegetiche, riassorbendole in un’unica narrazione dal tono impersonale e inevitabile. Ad esempio, in un enunciato come “Giulio Cesare fu assassinato il 15 aprile del 44 a.C.”, dato il carattere non problematico dell’asserzione (che viene data per pienamente assodata), non vi è alcun bisogno di farla apparire come il frutto delle ricerche di un singolo storico.

A seconda dell’obiettivo comunicativo che un saggio si pone (ricercare o divulgare), esso impiegherà strategie discorsive diverse. In generale, possiamo riconoscere l’esistenza di due procedure comunicative di segno opposto, il cui scopo comune è di ottenere l’ “adesione fiduciaria” del lettore:
(a) la strategia del “mascheramento soggettivante” consiste nel fare leva sull’autorità già accettata dell’autore per far passare la sua argomentazione senza esitazioni. In questo caso, la sua presenza nel testo verrà accentuata: egli parla in prima persona, si rivolge direttamente al lettore, gli espone sinceramente la sua posizione. Alla fine il lettore non può che accettare la versione proposta dall’autore, a meno di non voler mettere apertamente in dubbio la sua autorevolezza in merito alla materia trattata.

(b) d’altra parte, il testo può cercare di apparire come il riflesso inevitabile di una realtà già formata
prima della sua azione su di essa. Esso può allora ostentare la sua neutralità rispetto agli eventi raccontati, per non dare adito al sospetto che esso abbia in qualche modo manipolato questa realtà, interpretandola in modo parziale. Questa strategia (nota come “mascheramento oggettivante”) consiste nella cancellazione dal testo di tutti quei segnali che possano far pensare a una parzialità del punto di vista proposto.
L’autore si nasconde dietro ai fatti narrati e non appare mai in prima persona; di conseguenza, i fatti sembrano raccontarsi da soli. Rientrano in questo procedimento le forme impersonali (“si dice”, “si prendano due grammi di cloruro di sodio”, “si osserverà che…”), l’uso del “noi” nei discorsi scientifici (l’autore si mescola con il resto della comunità scientifica, come se ne fosse il portavoce) e il presente di definizione.

Riprendendo la distinzione tra rivoluzione scientifica e scienza normale, diremo allora che l’opera di vera e propria ricerca storiografica – compiuta sui confini frastagliati e controversi del paradigma – sarà caratterizzata da un maggiore uso di espressioni come “forse”, “probabilmente” o “secondo me” (che segnalano l’atteggiamento del parlante rispetto al proprio discorso) e di tutti quegli artifici discorsivi che portano bene impresso il
marchio soggettivo del ricercatore.
Spesso accade inoltre che i testi di ricerca storiografica assumano un tono apertamente polemico nei confronti del paradigma storiografico ufficiale o di altri contendenti allo statuto di paradigma accettato, i quali si frappongono tra l’eroe-ricercatore e la consacrazione della sua conquista della verità. La ricerca della verità storica apparirà allora come la storia di un tortuoso itinerario conoscitivo, irto di insidie e ostacoli vari ma coronato alla fine da una vittoria sugli antagonisti.

Mentre i saggi di ricerca storiografica mirano spesso a rimettere in discussione qualche aspetto del paradigma dominante, i lavori compiuti all’interno del paradigma ufficiale possono avere il duplice obiettivo di scavare nei dettagli di una ricostruzione storica già precedentemente abbozzata nei suoi contorni principali (soluzione di rompicapo tipica della scienza normale) e di rendere note a un pubblico di non addetti ai lavori le acquisizioni accettate dalla comunità storiografica.
In entrambi i casi, è interesse dell’enunciatore di “moderare le divergenze della valutazione di gruppo”, fornendo un’impressione di compattezza e di consenso generale all’interno della comunità scientifica. Una simile visione conciliante dell’attività storiografica si combina naturalmente con l’adozione di uno stile espositivo semplice e chiaro allo scopo di far risaltare il contenuto veicolato dal discorso, a discapito della visibilità dell’atto stesso del discorso.

I contenuti di un saggio divulgativo non vengono presentati come il frutto della ricerca di uno o più studiosi, bensi come il riflesso di una realtà accertata. Il registro adottato in questo caso sarà percio il più possibile impersonale e trasparente, e difficilmente farà uso di inutili orpelli stilistici, di scarti ironici, di commenti sarcastici o di implicature polemiche.
Il racconto della scienza normale e quello delle piccole rivoluzioni scientifiche che si verificano occasionalmente in campo storiografico impiegano dunque strategie discorsive diverse, funzionali agli obiettivi comunicativi perseguiti rispettivamente da ciascuno dei due tipi di testo (rafforzare oppure scuotere il consenso generale).

Il problema insorge quando un lavoro appartenente a una delle due sfere della scienza (scienza norma le e rivoluzione scientifica) fa uso delle procedure discorsive appartenenti all’altra sfera: ad esempio, quando un’indagine storica che mira a sovvertire le verità accettate dalla storiografia ufficiale assume un tono di ovvietà e di assoluta obiettività che non le è proprio, o al contrario quando un insieme di affermazioni date per scontate dalla comunità scientifica viene presentato come una scoperta sensazionale da parte di un ricercatore che si appropria indebitamente della sua paternità. I negazionisti sfruttano appieno la confusione generata da entrambe le interferenze strategiche appena delineate.
La scrittura della Shoah
Gli studi storici sulla Shoah possono essere distinti nelle due categorie, appena introdotte, di testi divulgativi e testi di ricerca storiografica. Complessivamente, come abbiamo visto, le opere di pura divulgazione tendono ad appianare le divergenze esegetiche tra i singoli interpreti per diffondere la conoscenza generalmente accettata dalla comunità scientifica su un certo argomento: tramite la divulgazione, infatti, si genera il consenso necessario per perpetuare la memoria storica degli avvenimenti. Come esempio di questa prima categoria di testi si prenda l’incipit dell’opera di Otto Friederich su Auschwitz:
“Nell’estate del 1940 Heinrich Himmler pianificò la costruzione di un nuovo campo di prigionia in un angolo sperduto della Polonia meridionale, nella valle paludosa dove la Sola confluisce nella Vistola, una cinquantina di chilometri ad ovest di Cracovia. Il luogo scelto dai suoi collaboratori era ben lungi dall’essere ideale. Nei pressi della cittadina di Oswiecim si trovava una caserma abbandonata dell’artiglieria austriaca, un agglomerato di circa venti costruzioni in mattoni a un solo piano, per la maggior parte sporche e malconce.

L’ambiente circostante, ai piedi dei primi contrafforti collinari dei Carpazi, era straordinariamente bello, un mosaico di stagni punteggiati di fiori selvatici, ma, secondo il rapporto reso a Berlino da una commissione di stretti collaboratori di Himmler, totalmente inadatto a ospitare un grande campo di prigionia: la falda acquifera era inquinata, le zanzare un incessante tormento e le costruzioni della caserma praticamente inutilizzabili”. (Friederich, 1982)
Come si vede, nel testo non c è traccia del soggetto-ricercatore e della sua attività cognitiva, mentre l’uso del passato remoto e della terza persona, nonché l’inserimento di parentesi descrittive dallo slancio quasi lirico (paragonabili a quelle adottate dalla letteratura di finzione), possono essere ricondotti alla strategia del mascheramento oggettivante. Se a ciò si aggiunge l’assenza di indicazioni bibliografiche precise, risulta evidente che l’obiettivo del libro di Friederich è di rammentare ai meno informati, in un’epoca di potenziale amnesia collettiva, la storia di Auschwitz nelle sue coordinate essenziali, senza necessariamente renderli partecipi del lavoro di ricerca storiografica intrapreso dall’autore.

Al lettore non vengono fornite le informazioni necessarie per proseguire da sé la ricerca, cosi come non è messo nella condizione di contestare le ipotesi avanzate dal testo proprio perché queste non si presentano sotto forma di ipotesi ma di sapere consolidato pronto per l’uso. E non potrebbe essere diversamente: in un testo divulgativo di questo tipo, un riferimento esplicito alle baruffe interpretative che riguardano questo o quell’altro frammento documentario sarebbe del tutto fuori luogo in quanto appesantirebbe inutilmente il discorso oltre i limiti accettabili per il suo Lettore Modello.
Per quanto riguarda i testi storici in cui l’aspetto investigativo è più spiccato, ci sarebbe invece da attendersi un maggior uso di artifici retorici e stilistici di tipo soggettivante. Troviamo elementi di questo tipo in alcune pagine di Reitlinger, di Wormser-Migot, di Vidal–Naquet e di Broszat. Nel seguente frammento, ad esempio, Olga Wormser-Migot (pur facendo uso del “noi” e del “si” impersonale tipici dei discorsi scientifici) espone i propri tentennamenti riguardo all’affidabilità del testimone Kurt Gerstein, rendendo esplicito il carattere congetturale della ricerca storica:
“ci siamo posti una serie di domande a proposito di Gerstein e della sua confessione, senza giungere a chiarire parecchie oscurità. Lasciando da parte i suoi primi anni al N.S.D.A.P., per i quali è impossibile trovare testimoni o prove, ci si può tuttavia stupire che dopo le sue prime esperienze a Belzec e Treblinka Gerstein abbia continuato a svolgere lo stesso lavoro senza speranza… “ (Wormser-Migot)

Analogamente, Reitlinger non nasconde il carattere ipotetico della sua revisione della cronologia ufficiale dello sterminio (si osservi l’uso del condizionale), e di conseguenza si addossa la responsabilità della credibilità o meno di tale ipotesi. Egli accompagna il lettore lungo il suo percorso dimostrativo, mostrandogli i punti di disgiunzione in cui è intervenuta l’attività inferenziale dell’interprete:
“Si avrebbe quindi un Himmler che decide la creazione di Auschwitz sei mesi prima della conferenza di Gross-Wannsee, quando Heydrich non aveva ancora ricevuto da Göring la delega per la “Soluzione finale”.
Ma Höss, pur essendo un testimone molto aperto, confondeva spesso nella memoria episodi diversi; infatti in un altra occasione, disse di essere andato a Treblinka all’epoca in cui vi furono sterminati 80.000 ebrei del ghetto di Varsavia, il che significherebbe nell’agosto 1942, quasi un anno dopo i suoi primi esperimenti con lo Zyklon B.
Questa seconda dichiarazione confermerebbe che fu nell’estate del 1942, e non in quella del 1941, che Himmler decise di fare di Auschwitz il campo di sterminio degli ebrei d’Europa, cioè soltanto dopo la morte di Heydrich”. (Reitlinger, 1953)

Occorre tuttavia aggiungere che simili meccanismi di dimostrazione sono piuttosto rari nell’ambito della letteratura scientifica sullo sterminio e tendono a essere impiegati (con cautela) solo nei casi in cui venga proposta una revisione del paradigma storiografico accettato, come accade nei brani appena citati. In linea di massima prevale lo stile impersonale del tipo impiegato da Hilberg (la cui opera canonica sullo sterminio viene significativamente definita, nell’edizione del 1985, “edizione riveduta e definitiva”), probabilmente perché la vicinanza temporale e l’intensità delle emozioni suscitate dagli eventi studiati rende necessaria un’ostentazione di neutralità scientifica da parte dei ricercatori.
Questi ultimi sono inoltre consapevoli del fatto che ogni ammissione di incertezza da parte loro sarà immediatamente carpita dai negatori della Shoah quale prova della fragilità del paradigma storiografico ufficiale. Di conseguenza, le strategie soggettivanti tendono a essere riservate a spazi paratestuali racchiusi tradizionalmente deputati a questa funzione, quali le note a piè di pagina, le prefazioni e le postfazioni. Vediamo a titolo d’esempio l’avvio autobiografico che Langbein antepone al suo studio sul sistema sociale vigente ad Auschwitz:
“Fui internato ad Auschwitz per due anni soltanto, ma proprio nel periodo più denso di avvenimenti e cioè dall’agosto 1942 all’agosto 1944. Da ultimo fui imprigionato per nove settimane nel Bunker di Auschwitz e li conobbi il livello più basso di prigionia, se si vuole fare eccezione per coloro che erano assegnati al Sonderkommando. Tutte queste esperienze assieme non furono pero sufficienti a darmi fin dall’inizio il coraggio di impegnarmi in una rappresentazione della situazione.
Per lungo tempo ho coltivato questo pensiero – la prima traccia di questo libro risale al 30 gennaio 1962 – ma poi ho sempre temporeggiato. Mi chiedevo se avessi già raggiunto il necessario distacco dalle mie esperienze personali per poter rappresentare oggettivamente i fatti: questo mio dubbio fu definitivamente superato durante il processo su Auschwitz tenutosi a Francoforte”. (Langbein, 1972)

Qui, il riferimento all’esperienza personale dell’autore funge da premessa alla vera e propria indagine storica, la quale adotta un tono ben più distaccato e neutrale. Diverso è il caso di un ricercatore come Pressac (1989) per il quale l’obiettivo della preservazione della memoria storica che muove la maggior parte de gli studi precedentemente trattati è secondario rispetto all’analisi minuziosa del materiale documentario allo scopo di ribattere alle specifiche controversie agitate dai negazionisti.
Il testo di Pressac è disseminato di espressioni quali “secondo l’autore”, di osservazioni metodologiche, di esplicitazioni dei passaggi logici che conducono a una determinata conclusione, di riferimenti precisi alle fonti, di tabelle e di fotocopie del materiale documentario studiato. Tutto ciò, se da un lato sottolinea la meticolosità del lavoro compiuto dal ricercatore, dall’altro rende l’opera di Pressac indigesta a un pubblico di non addetti ai lavori, scarsamente interessato a conoscere ogni risvolto dell’impresa storiografica svolta.
Il discorso negazionista
Come abbiamo visto, le strategie interpretative impiegate dai negazionisti sono vistosamente carenti sul piano della costruzione coerente ed esaustiva di un paradigma alternativo rispetto a quello ufficiale: l’inesistenza della Shoah viene sempre presupposta dagli scritti in questione, ma non viene mai argomentata sulla base di documenti o di testimonianze attendibili che attestino l’esistenza di un complotto di matrice sionista mirato a gabellare l’opinione pubblica circa il vero svolgimento della seconda guerra mondiale. La rivoluzione scientifica auspicata da questi autori è perciò incompleta.

circa 1955: The perimeter fence of the Nazi concentration camp at Auschwitz. (Photo by Keystone/Getty Images)
Mentre il paradigma storiografico ufficiale, nonostante le piccole zone grigie riscontrabili al suo interno, fornisce un quadro sostanzialmente solido e coerente di ciò che accadde agli ebrei durante il regime nazista, l’ipotesi negazionista non sta in piedi senza l’ausilio di una vaga teoria della cospirazione sociale e apre molti più interrogativi di quanti non ne risolva.
In altre parole, per spiegare il divario tra le cifre delle vittime dello sterminio fornite, diciamo, da Höss e da Korherr (statistico SS), i negazionisti introducono decine di altre anomalie ben più gravi: ad esempio, ci si può legittimamente chiedere il motivo per cui migliaia di testimoni, per giunta provenienti da sponde politiche contrapposte, abbiano accettato supinamente di mentire in favore della causa sionista ad essi estranea.

Malgrado le apparenze, dunque, quello proposto dai negazionisti non è un paradigma scientifico, ma è un aborto di paradigma, in cui il tentativo di realizzare una rivoluzione scientifica si limita all’individuazione delle presunte carenze del la storiografia ufficiale. Dopo avere scompaginato le prove documentarie nel tentativo di insinuare dei dubbi nella mente del lettore sprovveduto, gli autori in questione sono incapaci di offrire alcun dato positivo sul quale il lettore stesso possa fondare la sua eventuale adesione alle tesi da essi proposte.
Ne deriva che al destinatario degli scritti dei negazionisti è richiesto un atto di fede per essere ammesso nella cerchia eletta dei detentori della Verità storica. In questo capitolo mi propongo di esaminare la forma con cui i negazionisti presentano le proprie ipotesi allo scopo di aumentarne l’impatto persuasivo. Nel capitolo precedente ho ricordato che ogni testo, inclusi quelli storiografici, si avvale di varie strategie discorsive per incrementare la propria efficacia comunicativa. Tuttavia, i testi a vocazione scientifica tendono a rispettare
un’implicita etica del discorso per consentire la falsificabilità delle ipotesi da essi avanzate.

Tale etica si traduce in una serie di norme espositive del tipo: non fare affermazioni indimostrabili; incoraggia il lettore a controllare da sé la validità delle asserzioni espresse; fornisci solo gli elementi funzionali all’esposizione della tua tesi, ovvero non confondere il lettore con inutili sfoggi di erudizione. Bisogna capire fino a che punto i negazionisti rispettino tale insieme di regole comunicative specifiche dei testi che aspirano allo statuto di scientificità.
Precursori, ricercatori e divulgatori
I negazionisti rappresentano se stessi come una scuola eretica perseguitata dalla storiografia ufficiale. Se avessero letto Kuhn, essi senz’altro sosterrebbero di essere gli ideatori e i divulgatori di un nuovo paradigma scientifico. Le fasi del “riorientamento gestaltico” che accompagna una rivoluzione scientifica sono almeno tre:
1) individuazione delle insufficienze del paradigma accettato e conseguente senso di disagio interpretativo;
2) proposta (pre-paradigmatica) di un coacervo di frammenti esplicativi che rendano conto delle anomalie riscontrate in 1);
3) messa a punto del paradigma: le congetture avanzate nella seconda fase vengono ordinate per formare un sistema internamente coerente. Successivamente, gli sforzi degli adepti della setta eretica saranno tutti tesi verso il tentativo di convertire il resto della comunità degli interpreti alle lusinghe cognitive del nuovo paradigma.

A seconda della fase della rivoluzione (o della guerriglia) scientifica in cui ci si trova, si adotteranno delle strategie discorsive diverse. Nei punti 1) e 2) prevarrà uno spirito polemico nei confronti degli avversari, e le argomentazioni addotte per screditare questi ultimi tenderanno a essere poco organizzate, se non addirittura sgangherate; è presumibile inoltre che in questo primo momento l’autore faccia un uso preponderante di strategie soggettivanti, mirate a personalizzare il conflitto con la scuola ufficiale.
In linea di massima, i testi di Rassinier, di Christophersen e di Bardèche si collocano in questa fase altamente entropica della contestazione a caldo del paradigma storiografico dominante. Giunti al punto 3), gli attacchi sparsi e spesso reciprocamente contraddittori sferrati dai pionieri della nuova teoria si sedimentano per acquisire i tratti apparenti del discorso scientifico tradizionale, con il proprio carattere di obiettiva autoevidenza. Le controversie interne al gruppo vengono appianate a fini persuasivi e prevale la tecnica del “mascheramento oggettivante”.

È qui che si inserisce l’analisi testuale delle fonti, così come la praticano Faurisson, Roques, Stäglich, Butz o Mattogno. Infine, si esce dal dominio della presunta indagine scientifica per entrare in quello, puramente divulgativo, del proselitismo. Gli scritti della maggior parte dei negazionisti statunitensi, più intenti a promuovere concretamente la propria causa che non a individuare argomentazioni acute a favore dell’ipotesi da essi sostenuta, possono essere fatti risalire a questa categoria generale (si vedano gli articoli pubblicati dal Journal of Historical Review o gli opuscoli diffusi da Bradley Smith nelle università americane).
I precursori
Il tratto stilistico che più balza agli occhi negli scritti dei principali negazionisti della prima
generazione è l’uso predominante della prima persona narrante: Rassinier, Christophersen e Bardèche descrivono la propria esperienza personale della seconda guerra mondiale, ponendosi come gli unici garanti della veridicità delle affermazioni avanzate – quindi l’assenza di annotazioni bibliografiche precise per confortare la propria versione dei fatti.
La forma assunta da questi scritti non è quella del saggio storiografico, ma è quella dell’autobiografia o della testimonianza di prima mano. Ciò è particolarmente evidente nel caso dei primi due autori, i quali parteciparono attivamente agli eventi descritti (Rassinier come detenuto politico a Dora e a Buchenwald, Christophersen come tecnico del caucciù ad Auschwitz III), laddove Bardèche combina la sua esperienza di vichyista sconfitto con considerazioni più generali circa gli esiti giuridici della guerra, con il risultato che i suoi volumi appartengono piuttosto al genere del pamphlet politico che a quello del memoriale. A ogni modo, i testi stesi dagli autori appena citati non presentano la forma sistematica e “oggettiva” che ci si aspetta di trovare in un’opera storiografica.
È piuttosto evidente che simili testi si rivolgono a un lettore, se non proprio convertito alle
tesi negazioniste, almeno già sulla buona strada per subire tale conversione. Infatti, data la linearità delle strategie discorsive da essi attivate, al lettore non simpatizzante è sufficiente individuare il movente ideologico che spinge gli autori a mettere in discussione l’esistenza del genocidio per rifiutarsi di cooperare con essi e per bollare le loro affermazioni come pure e semplici menzogne.
Di per sé, gli scritti “appassionati” di Rassinier, di Christophersen e di Bardèche sono pressoché innocui, nel senso che hanno un raggio d’azione molto limitato: essi diventano insidiosi solo nell’istante in cui i negazionisti della seconda generazione se ne appropriano per avvalorare le proprie ipotesi, occultando il punto di vista dichiaratamente parziale assunto da questi pionieri del negazionismo.
I ricercatori
Col passaggio dalla lase pre-paradigmatica a quella almeno apparentemente paradigmatica del negazionismo (ma abbiamo visto che in questo caso è improprio parlare di paradigma scientifico), i contrasti di opinione che dividono lo sparuto gruppuscolo di negatori della Shoah vengono sanati in vario modo: c’è chi, come Butz, prende le distanze dalla scarsa serietà scientifica dimostrata dai suoi predecessori e, con un guizzo d’orgoglio professionale, propone il proprio libro come l’unica opera negazionista che, fino al momento della sua stesura, possa essere ritenuta rispettabile dal punto di vista storiografico (nel 1976 Butz non ha ancora incontrato Faurisson).
Gli altri negazionisti, con Faurisson in testa, preferiscono creare un’impressione di unanimità di vedute in seno al gruppo, fornendo agli epigoni le direttive principali circa le tesi da sostenere e avvalendosi di autori come Rassinier (ex internato nonché uomo di sinistra) come di un biglietto da visita per incrementare la rispettabilità della cosiddetta scuola revisionista.
Il coordinamento interno del movimento è facilitato dalla formazione dell’Institute of Historical Review verso la fine degli anni Settanta. Da questo momento in poi i vari contributi acquistano una coerenza reciproca che in precedenza era assente. Vengono insomma elaborate alcune risposte standard alle diverse obiezioni che comunemente vengono opposte ai negazionisti: quello Zyklon B? serviva alla disinfestazione; le testimonianze? sono tutte truccate; la ‘soluzione finale” di cui parlano i documenti nazisti? l’espatrio degli ebrei.
I negatori della Shoah di tutto il mondo cominciano a formare un fronte compatto, dotato perfino di una propria pubblicazione ufficiale (che non a caso viene inaugurata nel 1980, poco dopo l’esplosione del caso Faurisson). La strategia comune è semplice: a forza di ribadire gli stessi concetti in occasioni diverse, si creerà un tessuto coerente di citazioni e di rimandi che alla fine potrà dare ai meno informati l’impressione che ci sia qualche cosa di vero in ciò che viene detto, perché “non c’è fumo senza arrosto”.
I saggi dei maggiori esponenti del negazionismo “maturo” — Faurisson in Francia, Butz negli Stati Uniti, Stäglich in Germania, Mattogno in Italia — assumono le sembianze del discorso scientifico. Tale caratteristica è particolarmente accentuata in autori come Mattogno o Roques, che prendono in prestito l’apparato discorsivo delle pubblicazioni accademiche, corredando i propri scritti di articolate bibliografie, di note esplicative e di fotocopie dei documenti originali. Faurisson, che tenta (talvolta con successo) di farsi pubblicare sui quotidiani nazionali. annacqua l’aspetto ostentatamente erudito presente nei testi di questi suoi epigoni e non rinuncia a fare qualche fugace apparizione in prima persona nei suoi scritti.
A tale proposito, osservo che molti dei testi appartenenti a questa seconda categoria, pur facendo un uso prevalente di strategie oggettivanti, dedicano una parte (spesso la prefazione) al racconto autobiografico della conversione dell’autore alle tesi del negazionismo. Come vedremo fra povo, il meccanismo retorico attivato qui è, banalmente, quello sineddochico tipico del testimonial pubblicitario.
I divulgatori
Dopo che i capiscuola hanno elaborato le direttive da impartire al resto del gruppo, i discepoli si prendono carico della missione divulgativa del movimento e fanno proseliti nelle riviste, nelle scuole e nelle università. Tale tendenza, riscontrabile in particolare negli Stati Uniti, è caratterizzata dall’estrema grossolanità delle strategie discorsive impiegate, mentre l’eventuale scaltrezza dei divulgatori si concentra esclusivamente sull’elaborazione di strategie extratestuali adatte ad allargare il proprio uditorio, come dimostra il loro sfruttamento de gli organi studenteschi come rampe di lancio per raggiungere il pubblico dei grandi quotidiani nazionali.
Abbandonato il registro pacato del saggio storiografico, gli agitatori della propaganda negazionista impiegano un gergo fortemente ideologico rivolgendosi direttamente al lettore per esortarlo ad abbandonare le sue certezze in campo storiografico. In certi casi, inoltre l’antisemitismo che muove questi autori (e che solitamente viene tenuto celato) emerge con sconcertante immediatezza. Dal punto di vista delle strategie discorsive impiegate, quest ultimo gruppo di testi presenta pochi spunti interessanti e può agevolmente essere riassunto con l’etichetta di hate publications.
Dato il carattere manifestamente propagandistico (nel senso deteriore del termine) degli scritti in questione, possiamo dire che dal punto di vista retorico essi si ricongiungono alle pubblicazioni dei primi negazionisti, rivelando percio l’autentica vocazione — ideologica piuttosto che scientifica — di questo movimento.
Dopo aver suddiviso i testi negazionisti in tre categorie principali, intendo analizzare trasversalmente alcuni aspetti salienti delle strategie discorsive da essi impiegate, cercando di individuare i tratti stilistici che caratterizzano ciascuno dei tre tipi di testi.
Il paratesto
Abbiamo visto che molti dei segnali di genere, grazie ai quali il lettore è messo in grado di riconoscere il tipo di testo che ha di fronte, si concentrano nel paratesto, e cioè nell’insieme di informazioni che contornano e accompagnano il testo vero e proprio, fornendo al lettore una serie di istruzioni per l’uso dell’opera: la letteratura negazionista non fa eccezione a questa tendenza generale.
Un primo indizio circa l’appartenenza di un testo a un dato genere di discorso (saggio, romanzo, raccolta di poesie, ecc.), nonché circa il suo eventuale contenuto ideologico, é dato dal nome della casa editrice posto in copertina, sebbene si tratti di un segnale che non tutti i lettori sono in grado di cogliere: oltrettutto, nel caso delle pubblicazioni negazioniste, abbiamo constatato una singolare convergenza di interessi tra editori di estrema destra (ad esempio Les Sept Couleurs, La Sfinge, Le Rune, ecc.) e di estrema sinistra (il caso più vistoso è dato dalla Vieille Taupe).
Il nome dell’autore fornisce qualche ulteriore indicazione di genere solo qualora il lettore sia già a conoscenza di altre opere del medesimo autore. Ad esempio, un nome come Faurisson crea aspettative piuttosto univoche circa il tipo di tesi che verranno trattate nel corso del volume o dell’articolo che reca tale firma. Per rafforzare la riconoscibilità del nome dell’autore, i negazionisti possono talvolta contare sulla cooperazione involontaria dei media che, nel creare un caso nazionale attorno alla figura di questo o di quell’altro negazionista (come è accaduto in Francia a Faurisson e a Notin), lo riscattano dall’anonimato iniziale per trasformarlo in personaggio di cui tutti parlano.
Spesso, i negazionisti fanno ricorso all’anonimato e allo pseudoanonimato. Piuttosto diffuse nell’ambito della letteratura di finzione, queste pratiche sono pressoché assenti nel caso di opere di tipo storico o documentario, in cui ci si aspetta che l’autore si esponga in prima persona per garantire la veridicità delle proprie asserzioni, o almeno per dimostrare la sua disponibilità a pagare le conseguenze (scientifiche, se non addirittura giuridiche) di un’eventuale deviazione dall’etica del discorso fattuale, la quale gli proibisce di dire ciò per cui non ha prove adeguate.
La relativa frequenza con la quale i negazionisti nascondono la propria identità anagrafica tramite le pratiche sopracitate (nonostante aspirino al riconoscimento della comunità scientifica) è, se non altro, indice della loro scarsa volontà di sottostare alle regole implicite del discorso storiografico.
Titoli
Il luogo al quale è canonicamente affidato il compito di consentire l’identificazione di un’opera è il titolo che, soprattutto nel caso dei saggi scientifici, tende a fornire delle istruzioni inequivoche per la lettura del testo. Come si vede da una breve rassegna di alcuni titoli di volumi scritti da negazionisti, essi giocano molto sull’opposizione tra verità e falsità, e sulle dimensioni complementari del segreto e della menzogna: Le mensonge d’Ulysse, Die Auschwitz Lüge; The Hoax of the XXth Century, Nuremberg II ou les Faux Monnayeurs; Vérité historique ou vérité politique ? Le Véritable Procès Eichmann; Did Six Million Really Die ? The Myth of the Six Million; Auschwitz: due false testimonianze, ecc. (vedi Riferimenti bibliografici).
L’insistenza posta su termini come verità, falsità, segreto e menzogna (e affini) persegue un evidente intento polemico: un normale saggio storico non ha bisogno di sottolineare il fatto che le informazioni in esso riportate sono autentiche (o aspirano a esserlo), in quanto ciò è dato per scontato dall’appartenenza stessa del testo al genere storiografico. Già dai titoli si capisce perciò che i negazionisti puntano a definirsi in negativo (ossia, in contrasto rispetto alla storiografia accettata), mentre senza l’elemento antagonistico la loro identità di gruppo finirebbe per essere sgretolata.
Tale rapporto parassitario nei confronti del paradigma ufficiale emerge chiara mente dal titolo dell’articolo con cui Faurisson debutta sulla stampa nazionale francese nel 1978: “Il problema delle camere a gas” o “la diceria di Auschwitz”.
Il titolo è composto da due citazioni: “Il problema delle camere a gas” rimanda a un articolo scritto da Olga Wormser-Migot nel 1968 in cui viene affrontata la questione dell’esistenza o meno delle camere a gas in alcuni campi di concentramento in territorio tedesco. In nessun punto del suo articolo l’autrice mette in dubbio l’esistenza delle stesse in altri campi, come Auschwitz o Treblinka.
Come abbiamo già avuto modo di constatare, Faurisson tende a sradicare le citazioni dal loro contesto originario, senza preoccuparsi di ricostruirlo o di riassumerlo quando trapianta le citazioni in altri contesti. “La diceria di Auschwitz” riecheggia provocatoriamente La diceria di Orléans di Edgar Morin (1969) in cui viene proposta un’analisi sociologica del meccanismo per il quale, nel maggio 1968, emerge e si diffonde la diceria secondo cui sei negozi di abbigliamento femminile di Orléans, cinque dei quali sono gestiti da ebrei, sono coinvolti nella Tratta delle Bianche.
Nel ricordare questa diceria affiancandola alla presunta “diceria di Auschwitz”, Faurisson suggerisce la chiave di lettura da applicare al testo che segue: come nel caso di Orléans, anche con Auschwitz ci troveremmo di fronte a un fenomeno di inganno collettivo, forse architettato da qualche responsabile occulto e comunque accettato acriticamente dalla maggioranza. La sparizione degli ebrei nei lager nazisti, così come quella delle ragazze date per scomparse a Orléans, sarebbe dunque una frottola.
La provocazione è accentuata dal fatto che chi nel testo di Morin appariva come la vittima della diceria ora diventa il colpevole. Con una sorta di ricatto tacito il lettore viene invitato ad applicare i medesimi criteri valutativi a entrambi i casi descritti per evitare di cadere nel meccanismo dei “due pesi e due misure”: si verifica perciò quello spostamento di 180 gradi descritto da Chevalier (1988) come tipico della logica del capro espiatorio, per cui la vittima reale viene colpevolizzata mentre il colpevole è rappresentato come il vero perseguitato.
Non tutti i titoli degli scritti negazionisti raggiungono simili vette di ricercatezza. Quelli di
Bardèche e dei primi libri di Rassinier sono ancora estranei alla tradizione onomastica negazionista e percio, quando rimandano ad altri testi, scelgono dei referenti estranei alla storiografia concentrazionaria, come OmerO (Le mensonge d’Ulysse) o la Bibbia (Nuremberg ou la Terre Promise).
Prevedibilmente i testi della seconda categoria (quelli dei ricercatori), aspirando alla rispettabilità scientifica, tendono a impiegare titoli in cui si faccia un riferimento diretto alle fonti documentarie utilizzate, sebbene già in questo elemento paratestuale venga comunicato l’atteggiamento diffidente dell’autore nei confronti dei testi citati. Qualche esempio: Les “confessions” de Kurt Gerstein. Étude comparative des différentes versions (Roques); Auschwitz Notebook. Certain Impossibilities of the “Gerstein Statement” (Felderer), Mon analyse du “Journal de Kremer” (J.-G. Cohn-Bendit); Il rapporto Gerstein: anatomia di un falso e Auschwitz: le “confessioni” di Höss (Mattogno).
Gli esponenti della propaganda negazionista più dozzinale fanno invece uso di titoli adeguati alla scarsa preparazione culturale del Lettore Modello da essi previsto. Per agevolare l’immediata identificazione dell’argomento trattato dal proprio discorso, questi autori fanno leva sugli unici appigli culturali di cui si suppone che il lettore possa disporre, quindi la ripetitività dei titoli in questione: The Myth of the Six Million; Did Six Million Really Die ?; The Six Million Reconsidered, ecc.
Oltre a consentire un facile riconoscimento tematico, l’accento posto sulla cifra ufficiale delle vittime della Shoah pone le basi per quella che sarà la successiva linea argomentativa adottata. Abbiamo infatti visto che, anche da parte della storiografia ufficiale, non vi è certezza assoluta sugli aspetti statistici del genocidio: focalizzando l’attenzione del lettore sulla cifra dei sei milioni, i negazionisti vogliono predisporlo ad assumere l’atteggiamento sospettoso adatto alla lettura preferenziale del testo.
Epigrafi
Poste ai confini del testo, le epigrafi sono citazioni che godono di uno statuto privilegiato nell’economia complessiva dell’opera. L’epigrafatore (colui che seleziona la citazione da anteporre al testo) è solitamente l’autore del testo, sebbene talvolta questo ruolo venga assolto dall’editore (presumibilmente con il consenso dell’autore, qualora questi sia ancora in vita). Partendo dalla constatazione dell’abbondanza di epigrafi riscontrabili negli scritti dei negazionisti (in particolare francesi) può essere interessante analizzare il ruolo che esse giocano nell’ambito delle strategie discorsive impiegate da questi autori.
“Epigrafare è sempre un gesto silenzioso la cui interpretazione rimane una responsabilità del lettore”: di conseguenza, l’epigrafe non adempie ad alcun compito esplicito e le funzioni che essa ricopre sono materia di inferenza da parte del destinatario del testo. In linea di massima, le mansioni principali ottemperate da questo elemento liminale del paratesto sono quattro:
(i) commento o chiarimento del titolo dell’opera;
(ii) commento del testo allo scopo di fornire una chiave di lettura preferenziale all’interprete;
(iii) effetto di cauzione determinato dalla presenza dell’epigrafato (l’autore del testo citato) nell’opera, “cauzione meno costosa in genere di quella di una prefazione, o anche di una dedica, poiché può essere ottenuta senza sollecitarne l’autorizzazione”;
(iv) effetto epigrafe: l’epigrafe è in sé un indice di cultura, ovvero “una parola d’ordine di
intellettualità”.
Non è indispensabile che una data epigrafe svolga contemporaneamente tutte le funzioni appena citate. Ritengo tuttavia che il quarto obiettivo sia sempre perseguito dagli epigrafatori negazionisti, i quali con questo artificio discorsivo mirano a conferire ai propri testi una patina di rispettabilità intellettuale che la cultura ufficiale non è disposta a concedere loro.
La scelta degli autori citati indica la volontà dei negazionisti di servirsi di figure investite di
indiscutibile prestigio culturale per accreditare i propri scritti (terza funzione). Si pensi alla tripla epigrafe che gli editori della Vieille Taupe antepongono alla traduzione francese del libro di Stäglich:
Spesso, sembra che lo spirito si dimentichi, si perda ma, all’interno, è sempre in opposizione con se stesso. È progresso interiore come dice Amleto allo spirito di suo padre: “Ben fatto, vecchia talpa! HEGEL
Riconosciamo il nostro vecchio amico, la nostra vecchia talpa, che sa lavorare così bene sotto terra per apparire bruscamente: la Rivoluzione. MARX
Quello che è terribile quando si cerca la verità, è che la si trova.
Oltre a informare il lettore circa il retaggio culturale rivendicato da questa casa editrice di estrema sinistra (che però pubblica autori di estrema destra), il trittico di epigrafi fornisce le indicazioni necessarie per comprendere il significato del “marchio” editoriale La Vieille Taupe, rappresentato metaforicamente come motore di “progresso interiore” che, lavorando al di sotto delle superfici apparenti, crea il terreno idoneo per l’insorgere della rivoluzione.
Nella terza citazione anonima prevale l’elemento polemico che descrive il percorso cognitivo dell’eroe solitario alla ricerca della verità, topos ricorrente nei testi dei negazionisti. Dunque, l’epigrafe fornisce una chiave di lettura del testo a seguire, predisponendo il lettore a diffidare di coloro (chiunque essi siano) che hanno un interesse a ostacolare l’inesorabile progresso conoscitivo.
Nelle edizioni di estrema destra si osserva invece una sorprendente assenza di epigrafi che riconducano direttamente alle radici ideologiche degli scritti pubblicati, nonostante gli editori riaffermino la propria eredità culturale in altre zone del paratesto: ad esempio, l’edizione italiana della Menzogna di Ulisse di Rassinier, pubblicata dalle Rune, è dedicata “A GIOVANNI PREZIOSI, eroe e martire della VERITÀ”.
Ciò nonostante, è difficile che gli autori epigrafati in questi volumi siano tacciabili di simpatie fasciste o xenofobe: perfino uno scrittore che, come Bardèche, non si è mai preoccupato di nascondere la propria provenienza politica evita accuratamente di esporsi troppo in questo spazio paratestuale strategicamente caldo.
In Nuremberg ou la Terre Promise, l’epigrafe biblica funge da commento (un pò sibillino) del titolo e del testo stesso:
“Salomone contò tutti gli stranieri che si trovavano nella terra d’lsraele e il cui censimento era stato fatto da David e suo padre. Se ne trovarono centocinquantatremila e seicento. E ne prese settantamila per portare i carichi, ottantamila per tagliare le pietre nella montagna, e tremilaseicento per sorvegliare e far lavorare il popolo”. (Bardèche, 1948)
Già dal titolo il lettore è avvertito della tesi sostenuta dall’autore, per il quale vi è un nesso diretto tra i processi contro i crimini nazisti e la formazione dello Stato d’Israele, sebbene l’esatta natura di tale rapporto venga chiarita solo nel corso della lettura del testo. L’iscrizione epigrafata crea un ulteriore effetto di senso che, interferendo con l’accostamento tra Norimberga e Israele posto nel titolo, sembra indicare che i giudici di oggi non sono altro che i carnefici di ieri. Il brano citato suggerisce inoltre che i famigerati lager nazisti, non diversamente dalle miniere salomoniche, fossero dei campi di lavoro forzato (e non di sterminio).
Tale ipotesi interpretativa, solo ventilata dall’epigrafe (che per sua natura è aperta a una pluralità di letture), viene poi confermata esplicitamente dal testo di Bardèche. Giova però osservare che in questa zona franca del paratesto le intenzioni dell’autore sono ancora protette dal velo dell’implicito, grazie al quale è possibile “suggerire, insinuare, far intendere qualcosa all’interlocutore, senza assumersene in modo esplicito la diretta responsabilità”.
L’autore comincia cautamente a istituire la competenza ideologica del lettore, contando sul fatto che in caso di successo comunicativo a lettura ultimata – questi potrà ritornare sui suoi passi per apprezzare retrospettivamente tutte le chiavi interpretative attivate dall’epigrafe.
La citazione posta in testa alla seconda opera negazionista di Bardèche (Nuremberg ou les Faux Monnayeurs) è strategicamente meno complessa, in quanto si limita a riproporre l’immagine eroica e disinteressata che questo autore (come gran parte dei suoi successori) ama dare di sé e della propria missione:
“Coloro che maneggiano o la spada o la penna per il loro paese non devono pensare che a far bene, dicevano i nostri padri, e non accettare nulla, neppure la gloria, se non come un felice caso”. (Honoré de Balzac, Les Paysans)
L’epigrafe in questo caso va intesa come una dichiarazione di metodo. Un simile intento autoapologetico sta alla radice di molti altri aforismi (tratti da Voltaire, da Orwell, da Chesterton, da W. James, ecc.) che i negazionisti sventolano a mo’ di slogan programmatici.
Il massimo della provocazione è pero raggiunto da Serge Thion che, nell’epigrafe anteposta
alla raccolta di scritti di Faurisson da lui curata, aggiunge una nota maliziosa al tradizionale motivo della ricerca spassionata della Verità:
«In materia di verità, non esistono fonti impure». (Pierre Vidal-Naquet, Bollettino d’informazione sulla Cambogia, giugno 1978)
Scegliendo Vidal-Naquet come autore epigrafato, Thion vuole dare l’impressione di avere colto in flagrante contraddizione il principale detrattore di Faurisson, laddove in realtà la citazione di Vidal-Naquet non è per nulla incompatibile con la sua stimata attività di storico.
Prefazioni
Mentre gli autori epigrafati solitamente non hanno la possibilità di opporsi al fatto di venire associati a un certo testo, lo stesso non vale per coloro che scrivono una prefazione. Questi ultimi sanno benissimo che, a meno di non segnalare a chiare lettere la propria disapprovazione (come fa Primo Levi nella prefazione alle memorie di Höss), l’affiancamento del loro nome a quello dell’autore del testo verrà inteso come un’ammissione di complicità, di consenso o di comunanza di vedute.
La più celebre prefazione di un testo negazionista è quella redatta da Noam Chomsky per Mémoire en défense, il libro in cui Faurisson si lamenta della persecuzione giuridica che ritiene di aver subito in occasione della sua espulsione dall’Università di Lione. Data l’autorevolezza del prefatore, i negazionisti si sono avvalsi di questo scritto come di una patente per legittimare il proprio lavoro.
Laddove l’atteggiamento generalmente assunto dalla cultura ufficiale nei confronti dei negazionisti è sempre stato un ostentato distacco (secondo il principio per cui “ascoltare qualcuno significa mostrarsi disposti ad ammettere eventualmente il suo punto di vista”), con l’intervento di Chomsky per la prima volta questi autori ottengono il riconoscimento culturale a lungo agognato.
Chomsky è un sostenitore a oltranza della libertà di espressione. È in ossequio a questo principio che, tirando in ballo Voltaire, Chomsky giustifica il proprio supporto dato a Faurisson:
“Per coloro che hanno imparato qualcosa dal XVIII secolo (vedi Voltaire), è ovvio, senza nemmeno sognarsi di discuterne, che la difesa del diritto alla libera espressione non si limita alle idee che si approvano, ma che è proprio nel caso di idee che si ritengono più urtanti che questo diritto dev’essere più vigorosamente sostenuto”. (Chomsky, in Faurisson, 1980)
Chomsky inizialmente afferma di conoscere poco gli scritti di Faurisson e di non voler entrare nel merito delle tesi in essi sostenute — il che poi non gli impedisce di manifestare il proprio scetticismo nei confronti del “preteso ‘antisemitismo’ di Faurisson”“, autore che secondo lui “è una specie di liberal relativamente apolitico”. Al di là della discutibilità della diagnosi proposta da Chomsky circa le ascendenze politiche del negazionista francese, colpisce l’ingenuità del prefatore nel pensare di potersi dissociare del tutto dai contenuti del testo presentato.
È vero che, tra le funzioni specifiche svolte dalle prefazioni, vi è anche quella di fornire un pretesto al prefatore per parlare di ciò che gli sta più a cuore, ignorando completamente l’opera che sta presentando — e infatti Chomsky impiega cinque pagine su sei per giustificare la propria controversa adesione alla petizione per la difesa di espressione di Robert Faurisson. Ma è vero altresi che il gesto prefativo comporta un’implicita raccomandazione alla lettura e, in assenza di esplicite indicazioni contrarie, ciò si traduce in un tacito assenso verso le tesi esposte nel testo.
A nulla vale la scusa preventiva di non aver nemmeno letto lo scritto in questione, poiché tale ammissione della propria ignoranza, lungi dall’assolvere il prefatore, invita le accuse di superficialità e di irresponsabilità che si possono legittimamente rivolgere a Chomsky. Quando il prefatore è l’autore stesso del libro, puo darsi che egli sfrutti lo spazio prefativo per raccontare le varie fasi della sua “avventura cognitiva”.
La parabola dell’agnizione dell’eroenegazionista trova la propria espressione paradigmatica nella prefazione del volume di Butz. Il percorso cognitivo narrato dal negazionista è scandito in alcune tappe principali, a cominciare dall’originario stato di beata ignoranza, attraverso i primi sospetti nutriti nei confronti della storia ufficiale e ai tentativi falliti di fondare un nuovo paradigma, per giungere all’esperienza traumatica (ma gratificante) della conversione.
1 – situazione iniziale: l’accettazione del paradigma dominante
Come pressoché tutti gli americani le cui opinioni sono state formate a partire dal secondo dopoguerra, fino a poco tempo fa anche io davo per scontato che durante la seconda guerra mondiale la Germania avesse inferto al mondo un colpo particolarmente micidiale. Questa visione ha dominato l’opinione mondiale fin dal 1945, se non da prima, e io non costituivo un eccezione nell’accettarne le linee essenziali.
È importante qualificare il termine “essenziale”, in quanto la raccolta di crimini di cui i tedeschi si sarebbero macchiati durante la seconda guerra mondiale si riduce rapidamente se si esaminano le prove e le argomentazioni raccolte negli accessibilissimi libri “revisionisti ” Un esame critico elementare rivela che la maggior parte dei crimini che anche gli “intellettuali” considerano reali (ad es., paralumi fabbricati da alcuni tedeschi adoperando la pelle di esseri umani uccisi nei campi di concentramento a questo scopo) sono ovviamente privi di fondamento. […]
2 – la domanda: l’insorgere dei primi sospetti
Tuttavia, tale indagine non sfata la leggenda dell'”olocausto”, e i “sei milioni” di ebrei assassinati, principalmente nelle camere a gas, possono apparire come un fatto irremovibile. […]
Osservando il modo in cui oggi questa leggenda viene sfruttata nella politica contemporanea, in particolare per ciò che riguarda l’appoggio assolutamente illogico prestato dagli Stati Uniti a Israele, da tempo covavo dubbi persistenti sull’argomento, e poi c’era anche il fatto che esisteva un numero ristretto di osservatori rispettati le cui opinioni non si erano formate esclusivamente nel dopoguerra i quali, nei limiti dei pochissimi canali ad essi accessibili, e in modo più o meno esplicito, negavano perfino la verità approssimativa della leggenda. […]
3 – racconto dello scacco: i tentativi falliti di dar corpo a un nuovo paradigma
Un’analisi superficiale della questione, del tipo che un non-storico normalmente compie, non mi condusse da nessuna parte. Lo scarso numero di pubblicazioni in lingua inglese nelle quali si nega la verità della leggenda non solo era poco convincente; era anche talmente inaffidabile e scorretto nell’uso delle fonti, quando le fonti venivano usate che ebbe un effetto negativo, di modo che la tesi della verità delle linee essenziali della leggenda (a prescindere dai problemi quantitativi, ad esempio se i milioni fossero sei, o quattro, o solo tre) sembrava uscirne rafforzata. […]
4- il racconto della vittoria: il “brusco risveglio”
Conservando i miei dubbi persistenti, all’inizio del 1972 cominciai a leggere parte della letteratura sull'”olocausto” un po’ più sistematicamente di quanto non avessi fatto fino ad allora, per vedere esattamente quali fossero le rivendicazioni in merito e su quali prove fossero fondate.
Fortunatamente, una delle mie prime scelte fu La distruzione degli ebrei europei di Raul Hilberg. L’esperienza fu uno shock e un brusco risveglio, perché il libro di Hilberg fece ciò che gli scritti della letteratura avversaria non avrebbero mai potuto fare. Non solo mi convinsi che la leggenda dei diversi milioni di ebrei gassati dovesse essere un impostura, ma ne derivai ciò che si rivelo essere una “sensibilità” piuttosto affidabile per la notevole mentalità cabalistica che aveva prestato alla menzogna la sua forma specifica. (Butz, 1976)
Ogni storia in cui si narrano le gesta di un eroe ribelle esordisce con il motivo dell’abbandono della casa paterna da parte del protagonista. Analogamente, le avventure del narratore-Butz cominciano con la decisione, a suo dire sofferta, di allontanarsi dalla tradizione storiografica accettata per inoltrarsi nei meandri della ricerca scientifica. Nel descrivere il proprio passato conformismo Butz vuole favorire l’identificazionè del lettore con l’immagine che egli proietta di sé, realizzando il “contatto intellettuale” che è la premessa indispensabile di ogni argomentazione.
La tecnica adottata da Butz non è dissimile da quella impiegata dai predicatori quando ammettono di aver condotto una vita dissoluta prima di aver visto la luce, oppure dai testimonial pubblicitari quando confessano la propria precedente incredulità nei confronti delle proprietà miracolose del prodotto reclamizzato.
Si osservi il “cambio di marcia” (dalla prima alla terza persona) che segna il passaggio dal primo al secondo paragrafo della prima parte: con questo cambiamento di prospettiva vengono introdotte — in veste di impedimenti oggettivamente presenti — le prime riserve circa l’adeguatezza del paradigma accettato. Attraverso l’impiego della forma impersonale per parlare delle presunte insufficienze della storiografia ufficiale, il narratore ostenta la propria estraneità nei confronti delle anomalie, che in questa fase introduttiva del racconto sono mascherate da indesiderabili elementi di disturbo.
I fermenti pre-rivoluzionari descritti nella seconda parte della prefazione sono attribuiti alla pressione esercitata dall’evidenza esterna sulle originarie credenze dell’autore, il quale nega che il proprio distacco dal paradigma ufficiale sia imputabile ai suoi pregiudizi ideologici. Tuttavia, una lettura un pò meno indulgente del testo in esame rivela che la ribellione epistemica precede l’insorgere di anomalie sufficientemente gravi da spingere l’interprete ad abbandonare il paradigma dominante: l’accenno ai “dubbi persistenti” che assalivano l’eroe ben prima di affrontare la storia della Shoah in modo sistematico è un’eloquente spia del contegno diffidente assunto dall’autore fin dall’inizio.
Nella terza parte Butz dà una forma narrativa al caos pre-paradigmatico che precede l’adesione a una nuova ipotesi. Riconoscendo lo scarso valore delle opere dei suoi predecessori egli ritiene di poter conquistare la fiducia del lettore (cfr. “guardi, signora, li ho provati tutti, ma le macchie proprio non sparivano”): in effetti, il racconto dello scacco serve a dare più rilievo — e più credibilità — al racconto della vittoria finale.
Infine, il racconto della vittoria adotta in pieno il regime del mascheramento soggettivante, come rivelano l’uso della forma personale e l’appello diretto ai lettori. Il successo del nuovo paradigma è rappresentato come una conquista individuale del ricercatore, paradossalmente aiutato dall’opera del principale esponente della storiografia concentrazionaria ufficiale.
Lungo tutta la prefazione, Butz abbozza un nucleo narrativo imperniato sull’opposizione tra il soggetto (l’eroe solitario che combatte per raggiungere la Verità) e l’antagonista (la storiografia ufficiale). Nell’inquadrare il conflitto di opinione nello schema narrativo tradizionale, raffigurandolo come una lotta impari tra il gigante e il piccolo eroe, è evidente l’intento di conquistare la simpatia del lettore che, come dimostra la letteratura popolare, si identifica più facilmente con l’avversario meno avvantaggiato della contesa.
Nella prefazione di Butz manca la parte finale della parabola negazionista, e cioè il racconto delle persecuzioni che questi autori ritengono di aver subito per mano delle istituzioni culturali. Ciò è facilmente spiegabile: negli Stati Uniti Butz può scrivere quello che gli pare senza il rischio di incorrere in sanzioni. Diverso è il caso degli autori europei (in particolare francesi e tedeschi) i quali dedicano gran parte dello spazio prefativo al racconto del mancato riconoscimento del proprio presunto valore scientifico da parte della cultura ufficiale.
Talvolta, il discorso negazionista sembra perdere di vista i propri propositi iniziali (fornire un’interpretazione alternativa della storia della seconda guerra mondiale) e si ripiega totalmente su se stesso, alternando il resoconto “martirologico” delle sventure personali dell’autore con l’enunciazione di principi astratti generalmente accettati (come quello della libertà di espressione).
Fotografie
Nell’ambito dei saggi storici, l’immagine fotografica deve la propria efficacia retorica al fatto di essere fisicamente e causalmente connessa all’oggetto fotografato: l’immagine fotografica sta per l’oggetto rappresentato in virtù delle radiazioni di luce che l’oggetto proietta sulla pellicola fotosensibile. Ne deriva che la presenza attuale della fotografia ci informa sulla presenza passata del modello di fronte all’obiettivo. Tale nesso fisico originario ci induce ad attribuire agli oggetti fotografati uno statuto ontologico “reale” che non siamo disposti a concedere con altrettanta sicurezza, agli oggetti raffigurati da un’illustrazione, per quanto realisticamente tratteggiati.
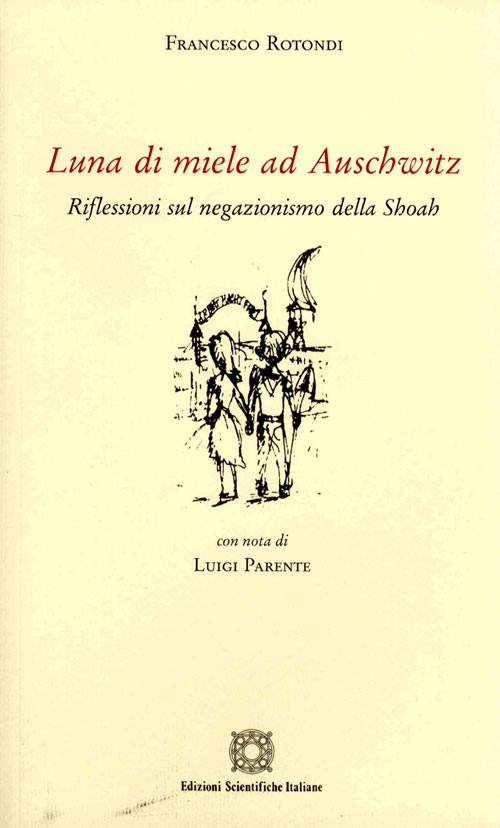
A tale proposito André Bazin osserva che
l’oggettività della fotografia le conferisce un potere di credibilità assente da qualsiasi opera pittorica. Quali che siano le obiezioni del nostro spirito critico siamo obbligati a credere nell’esistenza dell’oggetto rappresentato…
L’entusiasmo per le capacità documentarie della fotografia va tuttavia smussato dalla consapevolezza che, come ogni altro segno, anche la fotografia può essere menzognera.
Testimone che qualcosa c’era a impressionare la lastra (sovente usata come prova), essa [la fotografia] tuttavia genera sempre il sospetto che quel qualcosa non ci fosse. Sappiamo che qualcuno, o per messa in scena, o per truccaggio ottico, o per misteriosi giochi di emulsione, solarizzazione, et similia, può aver fatto apparire l’immagine di qualcosa che non era, che non è mai stato, che non sarà mai il caso.

La foto può mentire. Lo sappiamo persino quando assumiamo, ingenuamente, quasi fideisticamente, che essa non menta. Il referente oggettivo è congetturato, ma rischia di dissolversi ad ogni istante in puro contenuto. (Eco, 1985)
Così come un dito puntato verso il vuoto, accompagnato all’enunciato “guarda quel gatto”,
può essere usato per trarre in inganno il destinatario del gesto, una fotografia puo essere impiegata per suggerire l’esistenza di oggetti che non sussistono nel mondo dell’esperienza reale. A parte la possibilità di intervenire direttamente sulla pellicola (tramite montaggi, cancellature, piccole aggiunte, ecc.), il formato necessariamente ristretto della fotografia ci impedisce di conoscere ciò che stava oltre i confini dell’immagine “congelata” dal fotografo.
Ne deriva che, anche ammesso che essa riproduca un segmento inalterato di mondo reale, una fotografia non possiede alcun valore argomentativo prima che intervenga l’interprete a inquadrarla in un contesto. Senza un discorso più ampio che ne fornisca una chiave di lettura preferenziale, la fotografia come tale si adatta a una serie indefinita di possibili interpretazioni.

La fotografia acquista un senso solo quando venga inserita in un contesto più ampio, ad esempio grazie all’accostamento di una didascalia che ne sviluppi il contenuto virtuale. Così, l’immagine di un baraccone industriale dotato di ciminiera assume un significato ben diverso a seconda che sia accompagnata dalla didascalia “fabbrica di caucciù, Monowitz” oppure “Crematorio II, Auschwitz-Birkenau”.
I negazionisti sfruttano l’ambiguità che abbiamo riconosciuto essere tipica di ogni fotografia per attribuirla solo alle fotografie che riguardano lo sterminio ebraico. È per questo motivo che essi dedicano molto più spazio alla demolizione delle interpretazioni ufficiali delle immagini di archivio che non alla costruzione di interpretazioni alternative circa il loro significato.
Pressoché assenti nelle pubblicazioni dei negazionisti della prima generazione, le fotografie cominciano a essere impiegate da alcuni membri del secondo gruppo (in particolare da Butz) per conferire ai loro testi un’aria di scientificità. Nelle pubblicazioni divulgative, le fotografie svolgono invece una funzione fortemente polemica, giocata sullo scarto tra il commento in calce e l’interpretazione solitamente attribuita all’immagine riportata.
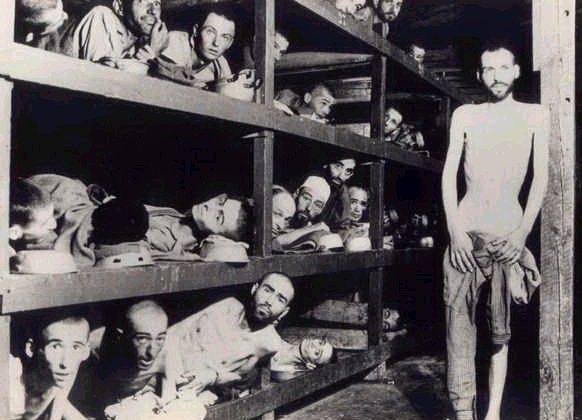
Ad esempio, Udo Walendy sostiene che le fotografie scattate nei campi durante (o subito dopo) la guerra non dimostrano alcunché, in quanto
“la foto di una catasta di occhiali, o di protesi dentarie, o di pennelli da barba, potrebbe facilmente essere stata scattata in una fabbrica di occhiali o in una fabbrica di protesi dentarie, o in una fabbrica di pennelli da barba”.
Walendy afferma che spesso le stesse fotografie sono state pubblicate con titoli diversi a seconda dell’argomento che dovevano illustrare, che talvolta le immagini sono state rimaneggiate, se non addirittura costruite in studio, e che molte di esse sono di origine comunista. Per giustificare la propria diffidenza, il negazionista evidenzia alcuni cattivi usi che sono stati fatti del materiale fotografico risalente alla seconda guerra mondiale.
Ad esempio, egli mostra due occorrenze di una stessa fotografia raffigurante una catasta di scarpe: la prima, apparsa in un’edizione moscovita del 1944 dedicata al lager di Lublino mostra dei soldati che si fanno largo tra le calzature sparse: la seconda, pubblicata a Francoforte nel 1957, zooma sulla catasta e intitola l’immagine “migliaia di scarpe di prigionieri uccisi ad Auschwitz”.

Walendy ritiene che le due fotografie presentino uno sfondo diverso (spia evidente di un intervento indebito sulla pellicola) e che l’assenza di ombre nella fotografia suggerisca che questa sia stata ritoccata. Infine, egli si sorprende del fatto che le scarpe fotografate non siano allacciate in paia per facilitare la loro successiva raccolta da parte dei nazisti. Data la scarsa qualità delle immagini riprodotte nel testo del negazionista, però, è pressoché impossibile per il lettore accertare se le obiezioni avanzate da Walendy siano fondate.
Il pamphlet antisemita di Richard “Harwood” (1974) è corredato di foto il cui compito è di corroborare le ipotesi sostenute nel testo scritto. Per ottenere tale effetto di mutuo rafforzamento (dal testo scritto alle foto e viceversa), Harwood accompagna le fotografie con didascalie volte a fornire una chiave di lettura univoca del materiale iconografico impiegato. Ad esempio il ritratto di Chaïm Weizmann è associato alla seguente didascalia: “Chaïm Weizmann. Dichiaro guerra alla Germania”, mentre il commento alla foto di Göring è: “Hermann , Goering a Norimberga. Respinse l’accusa dei Sei Milioni in quanto finzione propagandistica”, e quello che accompagna la foto di Anne Frank è: “Anne Frank. Il suo ‘Diario’ è un Falso”.

La struttura delle didascalie è costante: una prima parte si limita a riportare il nome del soggetto fotografato, ed è dunque direttamente associata al contenuto dell’immagine; una seconda parte, commentativa, è solo apparentemente pertinente rispetto al materiale documentario esposto, in quanto nulla, nelle foto, appoggia l’ipotesi negazionista sostenuta nella didascalia. Attraverso il meccanismo della presupposizione (normalmente si dà per scontato che la didascalia illustri ciò che è effettivamente presente nella foto commentata), l’autore tenta di estendere l’effetto di realtà evocato dal le fotografie alla credibilità delle proprie tesi eretiche.
E così che la funzione retorica delle fotografie si maschera da funzione scientifica. Per quanto riguarda le fotografie dei lager, le strategie impiegate da Harwood non sono dissimili da quelle adottate da Walendy e consistono nella ricontestualizzazione delle immagini mostrate per creare un piano di coerenza con le ipotesi proposte dal testo. Una fotografia della liberazione del lager di Dachau, in cui i detenuti appaiono legittimamente esultanti, reca il commento “Detenuti floridi e allegri liberati da Dachau”.

D’altra parte, di tutte le immagini disponibili dei cadaveri ammucchiati nelle fosse comuni, il negazionista include solo quella (utilizzata anche da Walendy) in cui subentra un sospetto di manipolazione da parte della propaganda alleata: la foto — pubblicata in un volume tedesco del 1957 — mostra una fila di detenuti malridotti posti di fronte a una massa di cadaveri scheletriti. Tuttavia, questa immagine è il risultato del montaggio di due fotografie diverse: la prima riguarda uno degli interminabili appelli ai quali venivano sottoposti i detenuti dei lager, mentre la seconda raffigura i corpi esanimi delle vittime.
E’ giusto segnalare l’intervento improprio compiuto sul materiale documentario da parte di storici poco scrupolosi. Nel denunciare la manipolazione, pero, è anche necessario attribuire un senso a ciascuna delle due fotografie prese isolatamente, cosa che il negazionista fa solo parzialmente: Harwood non si sofferma sull’immagine dell’appello, mentre ritiene che i cadaveri della seconda foto non appartengano alle vittime dei nazisti, bensì alla popolazione civile di Dresda dopo il bombardamento alleato del 1945.

Come ho già obiettato, tale ipotesi non rende conto dello stato orribilmente denutrito dei corpi in questione. Sulle fotografie dei cadaveri ammucchiati interviene anche Grimstad (1977) il quale, riagganciandosi a Harwood, sostiene che
fotografie di cittadini tedeschi morti – come le centinaia di migliaia di persone barbaramente uccise nel bombardamento di Dresda sono state ‘riciclate” subdolamente dai prolifici mercanti di Miti che le hanno spacciate per immagini di ebrei assassinati.
La validità dell’ipotesi della falsificazione sarebbe confermata, secondo Grimstad, da una foto delle fosse comuni in cui, tra i cadaveri ammonticchiati, si scorgerebbe un corpo con indosso un’uniforme tedesca. A parte il fatto che, anche se fosse vera, questa osservazione non dimostrerebbe assolutamente nulla (si possono formulare parecchie congetture per giustificare la presenza del cadavere di un soldato tedesco in una fossa comune nazista), al lettore ancora una volta non è fornita la possibilità di verificare da sé l’attendibilità dell’affermazione avanzata dal negazionista, in quanto l’uniforme della Wehrmacht individuata da Grimstad non è distinguibile dalla massa dei cadaveri aggrovigliati: perfino l’autore deve ammettere che la sua osservazione “potrebbe non risultare evidente dalla foto qui riprodotta”.

Infine, Grimstad si riallaccia al tradizionale motivo dell’efficienza nazista: la celebre foto degli ebrei rinchiusi nel convoglio che li avrebbe portati al lager (foto 1) viene dichiarata falsa in quanto il filo spinato che li rinchiude sarebbe “troppo disordinato”; d’altronde, l’immagine del cadavere intrappolato nel filo spinato (foto 2) è accolta con un commento sarcastico (tipico esempio di umorismo negazionista): “Dobbiamo credere che i tedeschi (teoricamente ultraefficienti) abbiano lasciato lo sventurato appeso al recinto — o forse si trattava di uno ‘stuntman’ di Hollywood?”.
Citazioni
Solitamente, quando un autore introduce stralci di discorso altrui nel proprio testo, lo fa perché questi sono rilevanti rispetto all’argomento di cui sta parlando, vuoi perché confermano o sviluppano le sue ipotesi, vuoi perché le contraddicono. Per questo motivo, I’autore assume una posizione inequivoca nei confronti delle affermazioni riportate tra virgolette, distanziandosene polemicamente oppure segnalando la sua approvazione nei confronti delle tesi che esse esprimono.
Nei testi dei negazionisti, tuttavia, accade talvolta che le citazioni non abbiano altro scopo se non quello di dimostrare la meticolosità dell’autore citante. Il lettore è bombardato da un eccesso di informazioni, spesso marginali rispetto alla tesi negazionista, e fatica a cernere i frammenti utili dall’eccesso di citazioni fornitegli dal testo. La strategia perseguita è quella che Schopenhauer descrive come segue:
Quando si vuole trarre una certa conclusione non la si lasci prevedere, ma si faccia in modo che l’avversario ammetta senza accorgersene le premesse una per volta e in ordine sparso, altrimenti tenterà ogni sorta di cavilli; oppure, quando non si è certi che l’avversario le ammetta, si presentino le premesse di queste premesse, si facciano pre-sillogismi, ci si faccia ammettere le premesse di molti di questi pre-sillogismi senza ordine e confusamente, si occulti dunque il proprio gioco finché non è stato ammesso tutto ciò di cui si ha bisogno si arrivi insomma al dunque partendo da lontano. (Schopenhauer, (1991)

Arthur Butz è un maestro di quest’arte di gettare fumo negli occhi del lettore: nel suo libro,
l’uso massiccio di citazioni — tratte dai documenti storici originali — svolge il duplice obiettivo di conferire al testo un’apparenza di serietà storiografica (per certi versi The Hoax of the Twentieth Century colpisce come una caricatura del testo a vocazione scientifica) e di paralizzare il lettore che, stordito dalla vertigine dei rimandi, rinuncia a farsi largo da sé nel guado dei riferimenti ad altri testi e chiede aiuto all’autore il quale, benevolmente, lo prende per mano per accompagnarlo lungo il percorso di lettura da lui prescelto.
Del trattamento al quale vengono sottoposte le citazioni tratte dalle testimonianze mi sono
occupata nella sezione dedicata alle strategie interpretative impiegate dai negazionisti. Rimane da capire in che modo questi autori sfruttino i testi degli storici ufficiali da un lato, e quelli degli altri autori negazionisti dall’altro, per aumentare l’efficacia argomentativa dei propri scritti.
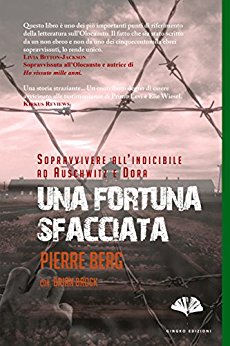
Le citazioni tratte dai discorsi degli avversari vengono spesso decontestualizzate, amputate
selettivamente o accompagnate da espressioni come “sorprendentemente”, “inspiegabilmente’, “sic”, volte a screditare la figura dell’enunciatore. È raro che vengano riprodotti integralmente dei brani tratti dai testi canonici relativi alla storia dello sterminio ebraico (Hilberg, Reitlinger, ecc.). Più spesso, i negazionisti si limitano a riportarne qualche sintagma isolato e sintatticamente incompleto, in modo da essere liberi di imporre sul frammento citato una chiave di lettura preferenziale.
Sganciata dal proprio contesto comunicativo originario (che l’autore negazionista non si preoccupa minimamente di ricostruire), la citazione assume l’aspetto di una particella estranea incapsulata in un corpo ad essa ostile. Le rare volte in cui un autore come Faurisson riporta integralmente le parole dell’altro, si premura di incorniciare la citazione con indicazioni precise circa l’atteggiamento (di totale diffidenza) da assumere nei suoi confronti. Malgrado tutte le precauzioni prese dall’autore, tuttavia, c’è sempre il rischio che il frammento di discorso dell’antagonista conservi un certo grado di coesione interna e di autonomia semantica, cosa che Faurisson tenta di evitare in ogni modo.
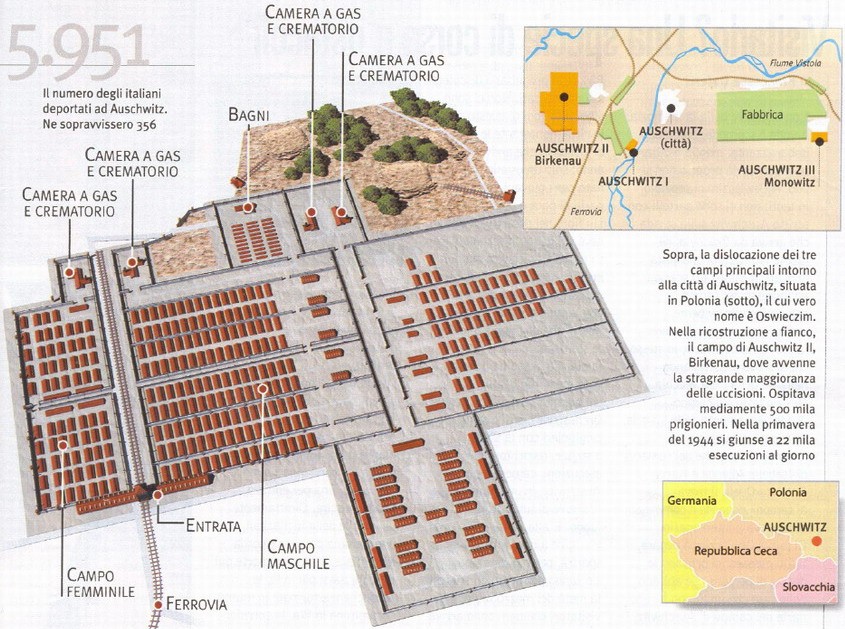
Che si debba rompere qualsiasi innesco di “presa” del discorso dell’altro, è ciò che testimonia l’altro caso di citazione di più di tre parole, in una struttura di discorso indiretto, questa volta “Cinque associazioni … mi accusavano di avere ‘volontariamente falsato la presentazione della storia’ e più precisamente di avere ‘volontariamente troncato certe testimonianze [dell’esistenza delle ‘camere a gas] come quella di Johann Paul Kremer'”.
La parentesi quadra che deve contraddistinguere, per scrupolo di esattezza, in una citazione gli adattamenti sintattici minimi al contesto citante è anzitutto, qui, l’occasione di un intrusione distanziante dell’enunciatore su camere a gas, introducendo così, nel corpo di una citazione esatta, un virgolettato estraneo e distruttivo. (Authier-Revuz – Romeu, 1984)
Attraverso la precisazione racchiusa tra parentesi quadre, posta all’interno del frammento citato, Faurisson colonizza la parola altrui. In breve, l’attacco nei confronti della parola dell’altro avviene su due fronti: dall’esterno, quando Faurisson previene il lettore circa la presunta inaffidabilità dell’autore citato o quando modifica il senso della citazione attraverso una ricontestualizzazione della medesima; dall’interno, quando immette dei segnali di distanziamento polemico nel cuore della citazione stessa.

Quando poi passano a citare i propri compagni di avventura, i negazionisti non perdono l’occasione per conferire agll altri esponenti della propria scuola titoli accademici (spesso spurii) mirati ad attribuire rispettabilità scientifica al gruppo con il quale si identificano: “un professore dell’università francese, il Dottor Robert Faurisson”, “lo storico francese, Professor Paul Rassinier”, “Dott. Udo Walendy”, “lo storico americano prof. David L. Hoggan”, ecc. Evidentemente, essi contano sul rispetto che solitamente si nutre nei confronti degli esperti di ogni genere, e sul fatto che, “all’occorrenza, le autorità si possono non solo distorcere, ma addirittura falsificare o perfino inventare”.
Rappresentazione dell’avversario
Già dal trattamento delle citazioni, si capisce come alcuni negazionisti (tra cui Faurisson) tendano a negare all’Altro il diritto di esporre compiutamente le proprie argomentazioni. A livello più generale, questa mancanza di dialogicità si traduce nel rifiuto di riconoscere agli storici “sterminazionisti” un’identità definita e concreta.
Parallelamente all’estrema individualizzazione degli autori negazionisti (ottenuta mediante la strategia del mascheramento soggettivante), si assiste infatti a una sistematica spersonalizzazione dei sostenitori della storiografia ufficiale, evocati con formule anonime quali “una ben individuata corrente politica”, “alcuni ambienti sionisti americani”, “trentaquattro storici francesi”, “cinque associazioni di antirazzisti”, “i grandi mezzi dell’informazione”, “i fautori della leggenda”, ecc.
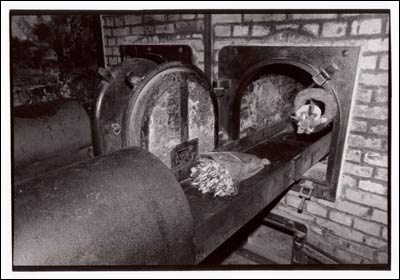
L’obiettivo è, evidentemente, di insinuare nel lettore il sospetto che sia in atto un complotto ordito da potenze occulte e inafferrabili (la lobby ebraica), proponendo una volta di più l’immagine dell’eroe ribelle in lotta contro le istituzioni, avvolte in un alone di sinistra impersonalità. Il seguente brano, tratto da Faurisson, illustra bene questo tentativo di spersonalizzazione degli avversari:
Nel 1945, la scienza storica ufficiale affermava che delle “camere a gas avevano funzionato sia nel vecchio Reich sia in Austria, sia in Alsazia sia in Polonia. Quindici anni dopo, nel 1960, essa rivedeva il suo giudizio: “camere a gas” avevano funzionato “anzi tutto” (?) in Polonia.
Il soggetto del secondo periodo si riaggancia a quello del primo: “la scienza storica ufficiale”. In effetti, Faurisson si riferisce alla lettera di Martin Broszat (direttore dell’Istituto di storia contemporanea di Monaco) intitolata Nessuna gassazione a Dacbau e pubblicata da Die Zeit il 19.8.1960, in cui per la prima volta si sostiene che le gassazioni non ebbero luogo all’interno del territorio dell’ex Reich, bensì in alcuni campi disseminati nel territorio polacco.

Nel testo di Faurisson, Broszat viene identificato integralmente con il paradigma all’interno del quale agisce, mentre, dato il carattere innovativo dell’ipotesi di Broszat rispetto alla storiografia concentrazionaria precedente —sarebbe ragionevole sottolineare l’autonomia di giudizio di questo storico tramite l’esplicitazione, se non altro, del suo nome proprio.
Che cosa ottiene Faurisson attraverso la cancellazione della soggettività degli storici ufficiali? Ottiene un effetto di senso implicito (dunque al riparo dalla contestazione), e cioè l’idea che il paradigma ufficiale sia il frutto di una cospirazione concertata dall’alto. Broszat non è che una pedina all’interno di un gioco più vasto, ed è per questo motivo che non vale nemmeno la pena citare il suo nome.

Tuttavia, l’identificazione del singolo storico con il paradigma dominante conduce a qualche contraddizione nelle argomentazioni di Faurisson. Non si capisce il motivo per cui Broszat, membro a pieno titolo del gruppo denominato “scienza storica ufficiale”, abbia deciso a un certo punto di rompere il silenzio (e per lo più di farlo solo parzialmente). Si potrebbe ipotizzare, seguendo Faurisson sino in fondo nella sua logica, che nel 1960 Broszat non fosse al corrente del piano più generale messo in atto dagli “sterminazionisti” e che abbia rivelato in buona fede una parte della verità occultata, aprendo una falla nella congiura del silenzio.
Ciò presuppone l’esistenza di un gruppo ancora più influente che manovra di nascosto la circolazione delle informazioni. Naturalmente, Faurisson si guarda bene dall’indicare la precisa identità di questo gruppo di cospiratori, limitandosi a vaghe insinuazioni sul suo conto. L’altra possibile interpretazione di questa fuga di notizie è che la verità su Dachau stesse comunque per emergere grazie alle indagini storiche svolte da studiosi indipendenti (categoria alla quale i negazionisti pretendono di appartenere) e che, piuttosto che rischiare di essere esposti pubblicamente come bugiardi, gli esponenti della storiografia ufficiale abbiano preferito anticipare i propri avversari nello svelamento della verità.

Questa è una strategia impiegata spesso dai negazionisti: ogni revisione della storia della seconda guerra mondiale (ad esempio, quando è emerso che l’uso dei cadaveri degli ebrei per produrre saponette era un mito) viene vista non come il risultato dell’attività di chiarificazione compiuta dallo storico onesto, bensì come il tentativo da parte dei cospiratori di prevenire l’accusa di avere occultato per anni la verità dei fatti.
Solo di rado i nomi degli avversari vengono citati esplicitamente. Spesso, essi sono elencati in serie per sottolinearne l’appartenenza a una setta comune: anche in questo caso, dunque, i singoli storici vengono spogliati dei loro attributi accessori individuali, che sono poi quelli che favoriscono l’identificazione del lettore con i personaggi citati.
Infine, vi sono alcuni casi isolati in cui gli storici ufficiali vengono dotati di una identità riconoscibile (con tanto di nomi propri e di titoli). Si tratta di quelle occasioni in cui l’autore negazionista polemizza apertamente con questo o quell’altro esponente del paradigma storiografico dominante: Vidal-Naquet, Wellers, Poliakov, ecc., L’intento è di cogliere in contraddizione lo storico preso di mira per gettare discredito sull’intera categoria degli esponenti della storiografia ufficiale.

Il fatto è che i negazionisti non riescono a concepire la possibilità che, all’interno di una comunità interpretativa, vi sia spazio per la discussione. Che le cronologie fornite da Poliakov e da Reitlinger circa l’inaugurazione delle gassazioni ad Auschwitz siano discordanti è, per loro, sintomo della crisi del paradigma che li accoglie entrambi. Tale tendenza a trasformare ogni “soluzione rompicapo” di in anomalia e ogni dissenso interpretativo in lacerante ammissione di incompatibilità di vedute riflette la visione manicheistica abbracciata dagli autori in questione, secondo i quali il mondo è divisibile nettamente in due categorie: coloro che “cercano mezzogiorno alle dodici” e gli altri, che si rifiutano di guardare in faccia la realtà.
Punteggiatura
Assieme alla spersonalizzazione degli avversari, l’obiettivo perseguito dai negazionisti è lo scollamento dei loro discorsi dal mondo reale. Gli incorporei esponenti del paradigma storiografico ufficiale parlerebbero perciò di cose inesistenti. Uno dei modi adottati per ottenere tale ulteriore cancellazione è un uso molto particolare dell’interpunzione, e in particolare delle virgolette. I negazionisti si servono di questo mezzo per indicare (non troppo sottilmente) il proprio distacco nei confronti del testo virgolettato.
L’uso di un’interpunzione fortemente didascalica per incoraggiare il lettore ad assumere un atteggiamento sospettoso nei confronti della realtà materiale dello sterminio viene introdotto dai negazionisti della seconda generazione (in particolare da Butz, da Faurisson e da Stäglich) e si diffonde poi nei testi dei divulgatori.
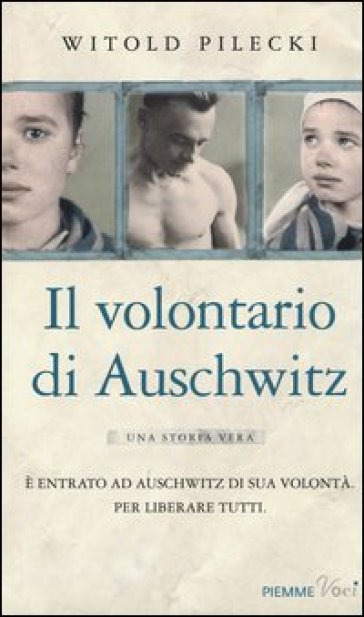
Ad esempio, nell’articolo di Faurisson intitolato ‘“Il problema delle camere a gas” o “la diceria di Auschwitz”, l’espressione “camere a gas” appare nove volte in due pagine, ed è sempre posta tra virgolette. Nadine Fresco osserva che un simile artificio stilistico stimola nel lettore una reazione pavloviana di sospetto. È cosi che viene seminato il dubbio nella mente del lettore circa il reale statuto di queste entità che vengono assimilate nel testo a tutte le creazioni chimeriche della mente umana.
Tutte le parole che si riferiscono a un qualunque aspetto delle procedure di sterminio subiscono un analogo distanziamento polemico: “genocidio”, “olocausto”, “campi di sterminio”, “crimini di guerra”, ecc. Il medesimo effetto è ottenuto mediante altri segni di interpunzione, quali i punti esclamativi o interrogativi posti tra parentesi quadre, i puntini di sospensione, il corsivo e il grassetto. Simili accorgimenti servono a ribadire la tesi dell’inesistenza dello sterminio ebraico a ogni livello (esplicito e implicito) del discorso negazionista.
Presupposizioni
Essendo l’insinuazione uno dei metodi preferiti dai negazionisti per diffondere le proprie ipotesi, non sorprende che essi facciano un uso molto esteso delle presupposizioni. L’efficacia argomentativa della presupposizione consiste nella possibilità di far passare relativamente inosservata una affermazione che se fosse dichiarata apertamente – potrebbe dare adito a una contestazione immediata da parte del destinatario.

Se qualcuno mi dice “ritornero a Bologna”, io capisco due cose. Primo, che egli intende recarsi nel capoluogo emiliano (e questa è l’informazione posta in rilievo); secondo, che in precedenza ci è già stato. Questa seconda informazione, posta sullo sfondo dell’enunciato (come se io già la dovessi possedere), è presupposta dall’uso di un verbo come “ritornare”. Cosa succede se la frase viene negata (“non ritornero a Bologna”)? Accade che mentre la prima informazione viene cancellata (il parlante non intende recarsi a Bologna), la seconda – quella racchiusa nella parola “ritornare” – rimane inalterata: resta il fatto che, qualunque siano i suoi progetti futuri, il parlante a Bologna c’è già stato.
Dunque, si ha un fenomeno presupposizionale quando, nel proferire una certa frase, si trasmettono contemporaneamente due pacchetti di informazione, di cui uno costituisce il rilievo della comunicazione e può, all’occorrenza, essere negato, mentre l’altro ne rappresenta lo sfondo e resta vero anche se la frase viene negata. Il meccanismo diventa interessante ai fini della manipolazione retorica del discorso quando si decide di porre sullo sfondo dell’enunciato proprio le informazioni meno ovvie (e quindi più soggette alle critiche), tentando in questo modo di porle al riparo dalla contestazione.
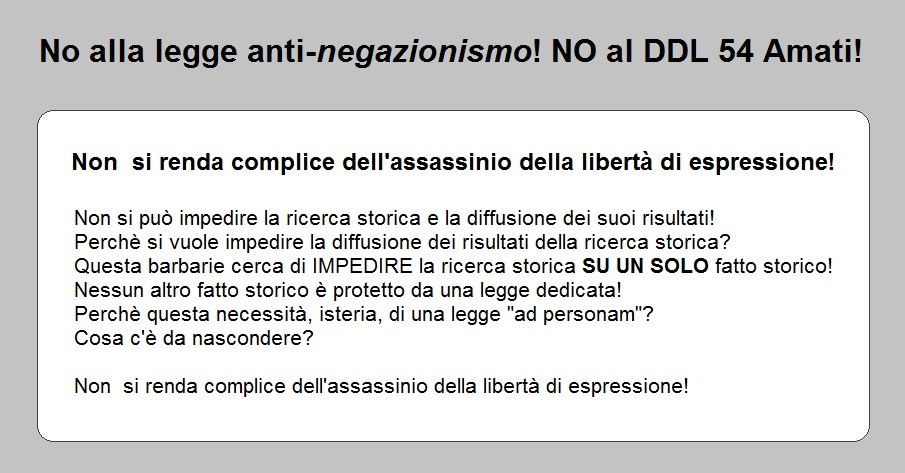
Per negare il contenuto presupposto dall’enunciato il destinatario deve contestare il diritto che l’enunciatore ha di usare quella certa espressione. Prendiamo come esempio il paragrafo finale del già citato articolo di Faurisson (in Thion,1980):
Il nazismo è morto e sepolto, col suo Führer. Oggi rimane la verità. Osiamo proclamarla. L’inesistenza delle “camere a gas” è una buona notizia per la povera umanità. Una buona notizia che si farebbe male a tenere ancora nascosta.
Nella frase evidenziata, Faurisson pone sullo sfondo dell’enunciato proprio la tesi che si propone di dimostrare, e cioè “l’inesistenza delle ‘camere a gas'”. Per contestare la presupposizione, il lettore deve mettere in discussione la struttura stessa della frase, rifiutandosi di dare per scontato ciò che viene posto come incontrovertibile dall’enunciatore. Non basta negare la frase per capovolgerne il senso (“l’inesistenza delle camere a gas non è una buona notizia per la povera umanità”); bisogna polemizzare con il modo stesso in cui Faurisson ha costruito il suo discorso: “e chi ha detto che le camere a gas sono inesistenti?”.

Solo il lettore disinformato, scarsamente motivato ad assumere un contegno ostile nella lettura distratta dell’articolo di Faurisson, può cadere nel tranello testuale ordito dall’autore – ma è per l’appunto a un simile lettore che si rivolge Faurisson.
Quando riportano i pareri degli storici ufficiali, i negazionisti fanno spesso uso di presupposizioni volte a insinuare che i pareri in questione portino acqua al mulino dei negazionisti. Il seguente esempio è tratto da Butz:
Come ha ammesso il dottor Kubovy del Centro di Documentazione Ebraica di Tel Aviv nel 1960 “non esiste alcun documento firmato da Hitler, Himmler o Heydrich che parli dello sterminio degli ebrei e […] la parola ‘sterminio’ non compare nella lettera di Goering a Heydrich riguardante la soluzione finale della questione ebraica”. (Butz, 1976)

Il termine “ammettere” suggerisce una certa riluttanza, da parte di Kubovy a sostenere la sua tesi, il che a sua volta induce a pensare che il contenuto dell’ammissione sia incompatibile con gli assunti della storiografia accettata.
Conclusioni
Riassumendo, le varie strategie discorsive impiegate dai negazionisti svolgono alcune funzioni fondamentali:
(i) conferire ai loro testi l’apparenza di discorsi scientifici attraverso l’introduzione di marche di storicità. Queste ultime sono concentrate prevalentemente nel paratesto, ma possono anche riguardare l’uso del materiale fotografico, l’introduzione di grafici e di tabelle riassuntive, l’ostentazione di dati numerici e di calcoli statistici, oltre che l’adozione di uno stile impersonale e oggettivato in alcune aree del testo.
Naturalmente, tale obiettivo è perseguito principalmente dai testi dei negazionisti “ricercatori”, mentre i precursori e i divulgatori non mirano affatto a confondersi con il resto della comunità scientifica, ma puntano piuttosto a ottenere una maggiore visibilità quali fattori di disturbo dell’ordine prestabilito;
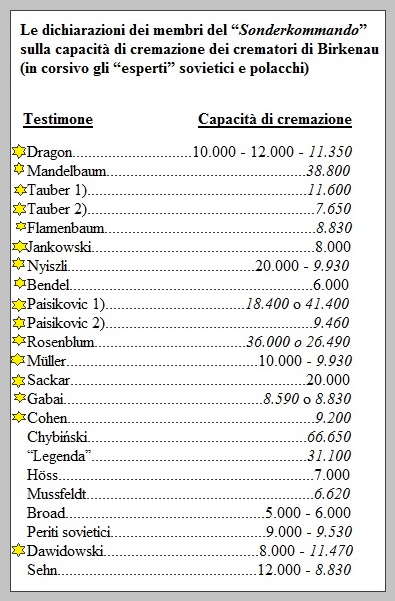
(ii) evidenziare la figura del ricercatore, sottolineandone l’individualità tramite l’uso di varie strategie soggettivanti che facciano leva sul topos dell’eroe solitario e ribelle. Spesso, l’individualizzazione del soggetto-negazionista si concentra nelle prefazioni, ma lungo tutto il testo si avverte pesantemente la sua impronta: interpunzione didascalica, fotografie-ritratto degli autori negazionisti all’interno di ciascun numero del Journal of Historical Review, ecc.;
(iii) trasformare gli antagonisti in massa anonima e inquietante, privando i singoli ricercatori di una propria individualità da contrapporre a quella degli eroi negazionisti: strategia ricorrente in tutti i testi dei negazionisti;
(iv) privare i discorsi degli avversari del loro aggancio con la realtà: questo, in fondo, è l’obiettivo principale perseguito dai negazionisti, per i quali è più importante gettare dei dubbi circa gli assunti della storiografia ufficiale piuttosto che proporre concretamente una rappresentazione alternativa degli eventi della seconda guerra mondiale.
CONCLUSIONI GENERALI
Una domanda che mi sono posta ripetutamente nel corso di questa ricerca è: perché, dopo
tanti anni in cui i negazionisti sono stati sistematicamente ignorati dalla cultura ufficiale, ultimamente i media hanno dedicato tanto spazio alle loro argomentazioni? Già dall’immediato dopoguerra vi sono stati individui isolati che hanno sostenuto l’inesistenza dei crimini contro l’umanità imputati ai nazisti.

Tuttavia, fino alla fine degli anni Settanta, nessuno ha mai prestato troppa attenzione a simili eretici solitari. Solo con Faurisson e con i suoi seguaci la tesi negazionista ha cominciato a farsi largo sui giornali e, di rimbalzo, nell’agenda collettiva. Vi sono alcune risposte piuttosto ovvie al quesito. In primo luogo, la vicinanza temporale rispetto agli eventi della seconda guerra mondiale rendeva inimmaginabile la loro negazione, laddove a distanza di decenni il senso di sgomento che cirvondava la ricezione collettiva della Shoah si è attenuato, lasciando un certo margine di manovra a chi avesse interesse a riabilitare il regime nazista.
A questa amnesia fisiologica, che fa si che ogni fatto storico, per quanto sconvolgente, assuma prima o poi tinte più sbiadite, si aggiungono alcuni motivi contingenti. In Francia, ad esempio, la tentazione di esorcizzare la sindrome di Vichy, e i sensi di colpa ad essa connessi, ha creato l’humus ideale per l’affacciarsi di un dibattito circa le reali responsabilità della guerra.
Tale dibattito, promosso dai quotidiani nazionali, ha reso attuali le ipotesi dei revisionisti e dei negazionisti vari. Sebbene gli scritti di questi autori siano stati pubblicati con grandi cautele da parte dei giornali, la maggiore visibilità da essi conquistata ha allargato notevolmente l’udienza dei negazionisti.

Una simile amplificazione è stata favorita, in Italia, dalle scelte editoriali compiute dai media dopo le elezioni del 1994: l’avvento al potere delle destre ha dato luogo a una proliferazione di trasmissioni televisive, documentari, articoli giornalistici, ecc., circa il Ventennio e le sue successive interpretazioni.
In Germania, d’altra parte, il timore suscitato dalle nuove manifestazioni di xenofobia ha riattualizzato lo scomodo passato nazista con il quale l’intera popolazione tedesca deve fare i conti per costruire la propria identità nazionale post-bellica.
Il clima di revival è stato inoltre accentuato dalla ricorrenza del cinquantenario della guerra (i giornali non resistono alla tentazione di commemorare un anniversario), nonché da alcune iniziative documentarie dalle dimensioni imponenti, come il film di Lanzmann e il recente progetto, annunciato da Spielberg, di formare un archivio dalle proporzioni immense per raccogliere gli ultimi brandelli di memoria concentrazionaria.

Nessuna di queste iniziative è mossa da intenti apologetici nei confronti del regime nazista: al contrario, esse sono per lo più destinate a mantenere viva la memoria storica, “per non dimenticare”. Eppure, accade che proprio tali rievocazioni acuiscano il senso di attualità dei discorsi dei negazionisti, concedendo ad essi quella rilevanza che in precedenza era’stata loro negata.
In un sistema democratico questo è in larga parte inevitabile, poiché nessuna autorità può
sindacare ciò che viene risucchiato nel vortice delle comunicazioni di massa. La responsabilità dei media nell’incremento di percettibilità dei negazionisti è pertanto colposa. È significativo, a questo proposito, il commento rilasciato da Zeffirelli al Corriere della Sera all’indomani dell’ordine di scarcerazione di Priebke (2.8.1996): “è giusto mettere una pietra su un passato così lontano e poco chiaro”.

Certamente si può deplorare il modo in cui alcuni quotidiani banalizzano la memoria della Shoah, sfruttando questo evento come veicolo metaforico per parlare di altri episodi, sicuramente tragici, ma comunque diversi dal genocidio nazista. Alain Finkielkraut critica questa “incontinenza verbale”, per effetto della quale i media, ad esempio, definiscono “genocidio” il bombardamento israeliano della base palestinese di Beirut del luglio 1981 (400 morti).
Ora, cosa accade quando si descrive un bombardamento in termini di soluzione finale? Si esagera il primo crimine, e si minimizza il secondo, in breve si mente due volte. In un primo tempo è l’azione mortifera che acquisisce un carattere di gravità eccezionale ma, successivamente, è l’idea stessa di genocidio che si banalizza, perde la sua realtà propria e può servire a qualificare tutte le operazioni militari senza distinzione […]. Questa stanchezza del senso facilita il lavoro agli operai della negazione. (Finkielkraut, 1982)
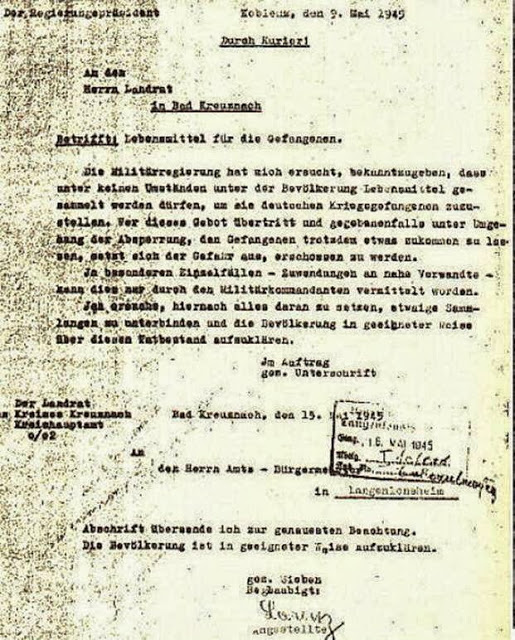
Tuttavia, ritengo che tale irresponsabile abuso del lessico dello sterminio vada inquadrato in un contesto culturale più ampio, per capire in che modo quest’ultimo favorisca l’operazione del diniego storico. Normalmente, si attribuisce al relativismo imperante la colpa del rinnovato impatto acquisito dalle tesi negazioniste. Così, almeno, afferma Deborah Lipstadt, quando ricorda che,
“sebbene il negazionismo non sia un fenomeno nuovo, a partire dalla metà degli anni settanta esso è cresciuto in estensione e in intensità. Bisogna rendersi conto che i negazionisti non lavorano in un vuoto. Parte del loro successo puo essere fatto risalire ad un certo clima intellettuale che si è affermato nel mondo accademico durante l’ultimo ventennio. I negazionisti svolgono il loro mestiere in un epoca in cui gran parte della storia sembra essere messa all’asta e gli attacchi contro la tradizione razionalistica occidentale sono divenuti un luogo comune”. (Lipstadt, 1993)

I maggiori responsabili di tale “clima intellettuale” sono, secondo Lipstadt, i sostenitori delle tesi testualiste forti (Fish, Rorty, i decostruzionisti, ecc.) i quali, ponendo una grande enfasi sulla libera iniziativa del lettore nella costruzione del significato di un testo qualsiasi, “hanno creato un’atmosfera di lassismo verso l’interrogazione del significato degli eventi storici e hanno reso molto difficile asserire che vi sia qualcosa di ‘off limits’ rispetto a questo approccio scettico”.
Strappato dal proprio contesto accademico originario, il relativismo teorizzato dal readeroriented criticism è dilagato (secondo Lipstadt) nella mentalità collettiva, sgretolando la base consensuale che circonda i grandi avvenimenti storici e sfociando in un atteggiamento di diffidenza diffusa.
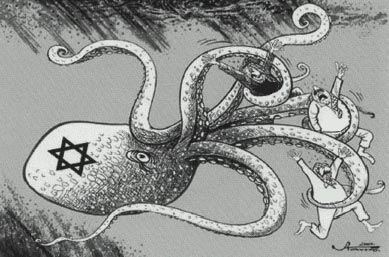
Dunque, il tipo di lettura sospettosa che i negazionisti praticano è in sintonia con la crisi di
veridizione (è cosi che la chiama Greimas) di cui soffre la cultura occidentale odierna, e che fa si che noi oggi leggiamo la storia con lo stesso velato scetticismo che applichiamo alla lettura dei racconti di finzione. In questa prospettiva va inquadrata l’attuale moltiplicazione di controversie storiografiche che, con la complicità del sensazionalismo dei media, porta alla ribalta le tesi di chiunque decida di rovesciare una qualsivoglia “verità” storica precedentemente accettata, dai viaggi di Marco Polo ai massacri di Pol Pot, dall’uccisione di Remo da parte di Romolo alla paternità delle opere shakespeariane.
Evidentemente, non pretendo di andare a fondo delle cause della crisi del concetto di verità nella società contemporanea. Ritengo tuttavia che la sfiducia generalizzata da molti denunciata sia la fonte, piuttosto che l’effetto, delle pratiche di lettura sospettosa condannate da Lipstadt. In altre parole, credo che la decostruzione, il Nuovo Storicismo e le teorizzazioni sul “pensiero debole” siano altrettanti sintomi significativi (e non certo delle cause) del disagio epistemico avvertito, in modo più o meno consapevole, dai membri della nostra cultura.

La “sospensione della credulità” fa dunque parte dell’episteme odierna. Non si tratta semplicemente di una lamentevole perdita dei valori poiché – bisogna rammentarlo – lo stesso spirito scientifico è imbevuto di relativismo e di cultura del sospetto. È stato più volte ricordato che è sospettoso non solo chi sostiene che l’economia mondiale sia in mano agli ebrei e ai massoni, ma anche lo scienziato che si sorprende di fronte a certi fatti che per secoli sono passati inosservati.
Da qualche parte, perciò, esistono dei criteri grazie ai quali noi distinguiamo tra un sospetto paranoide e un sospetto produttivo. La decisione di dare credito a un’interpretazione eterodossa piuttosto che a un’altra non è necessariamente dettata da fattori razionalmente formalizzabili.

Talvolta, la scommessa interpretativa sembra essere vinta proprio dalle tesi che a prima vista apparivano più eretiche e quindi più improbabili. Inoltre, se si abbraccia una posizione moderatamente pragmatista, non si puo ammettere che vi siano alcune zone dell’enciclopedia “off limits” rispetto all azione potenzialmente erosiva della reinterpretazione, poiché cio significherebbe introdurre un principio di autorità a salvaguardia di qualche area privilegiata del sapere.”
Insomma, non vi sono motivi epistemologicamente fondati per porre al riparo dalle contestazioni la storia degli ebrei sotto il regime nazista e non la storia degli antichi romani. Eppure nessuno si turba più di tanto quando T. P. Wiseman afferma che Remo fu ucciso dalla plebe romana, oppure quando alcuni storici italiani reinterpretano la storia del Risorgimento, sostenendo che la spedizione dei Mille fu finanziata da Rubattino (in quanto rappresentante della classe imprenditoriale) per favorire l’unificazione delle reti di trasporto lungo la penisola.

In un capitolo precedente ho sostenuto che, prima di dubitare della validità del paradigma
ufficiale, l’interprete debba avere buoni motivi per farlo: deve avere constatato anomalie o fatti sorprendenti che si dimostrino chiaramente incompatibili con il complesso di ipotesi che fonda il paradigma stesso. Tuttavia, nell’effettiva pratica scientifica può anche accadere che – abbandonandosi al libero gioco della fantasia – l’interprete ceda temporaneamente al fascino della lettura eretica ancor prima di avere trovato buoni motivi per gettare via il paradigma assodato.
A meno che non sia completamente privo di immaginazione, chiunque lavori all’interno di un certo paradigma prima o poi si interroga circa l’effettiva validità del medesimo, e gioca con la possibilità di applicare ipotesi alternative al materiale esperienziale di cui dispone, secondo la logica fantascientifica del “what if…?”. L’importante è che, dopo aver passeggiato al di fuori del paradigma alla ricerca di strade non ancora battute, l’interprete sappia ritornare sui propri passi, a meno di non avere, nel frattempo, scoperto qualche indizio forte a sfavore della tradizione ortodossa.

Altrimenti si slitta dalla dimensione della ricerca scientifica a quella della fiction romanzesca, il cui “privilegio aletico” consiste nel non avere l’obbligo di fornire dei “riscontri oggettivi” (nel senso di extratestuali) a sostegno delle proprie costruzioni fattuali. Si configura perciò una nuova ipotesi: non nella lettura sospettosa, bensì nella rigida proposta di una lettura alternativa (che comporta una chiusura del dialogo) risiede lo scandalo negazionista.
Nell’istante in cui i negazionisti pongono in dubbio l’esistenza della Shoah, la reazione di repulsione che essi generano in noi è dettata non da motivi scientifici, bensì da (giustificatissimi) fattori morali ed emotivi. Si può agevolmente immaginare un futuro remoto in cui la negazione dello sterminio ebraico non susciterà indignazione, bensì il divertito distacco con cui noi oggi accogliamo la tesi dell’inesistenza di Napoleone.

Quando i figli dei figli delle vittime dei lager saranno scomparsi, la messa in discussione del genocidio avrà lo stesso impatto emotivo che potrebbe avere l’incredulità rispetto a, diciamo, la strage erodiana degli innocenti. Propongo perciò di separare temporaneamente, a fini analitici, l’aspetto morale da quello epistemologico della nostra valutazione dell’operazione negazionista.
Moralmente, la negazione della Shoah appare intollerabile perché è evidente che chiunque si premuri di falsificare un evento come la Shoah è spinto da un movente poco edificante: per quale motivo, altrimenti, perdere il proprio tempo a tentare di sfatare un episodio, storicamente accettato, che vede contrapposti un partito di aguzzini e una massa di vittime innocenti? L’unica possibile spiegazione è che l’interprete eretico, lungi dal perseguire un neutrale progetto di “ricerca della verità”, si prefigga di riabilitare i nazisti e di ripiombare nel paradigma dell’antisemitismo storico.”

Bisogna infatti ricordare che nemmeno i negazionisti più incalliti negano che le deportazioni degli ebrei ebbero luogo e che un certo numero di persone perse la vita durante queste operazioni. Dal punto di vista epistemologico, invece, la reprensibilità del negazionismo si colloca nella seconda fase della conversione epistemica da essi auspicata: quella che incoraggia il passaggio dal dubbio generalizzato (non potremo mai essere certi dell’esistenza del genocidio, così come di qualunque altro avvenimento storico) alla proposta tassativa di una tesi alternativa (la Shoah è un’invenzione sionista).
La prima fase della conversione coincide dunque con il passaggio dalla tesi dello sterminio
alla sua messa in discussione. Se i negazionisti si limitassero a ciò, potremmo semplicemente accusarli di nascondere le proprie reali convinzioni politiche sotto un apparente zelo scientifico.
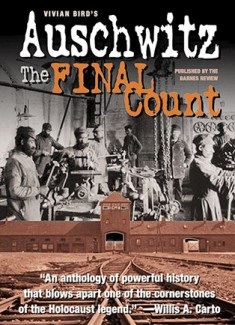
Infatti, lo spostamento da un termine al suo termine contraddittorio (sterminio —> nonsterminio) è oscillatorio, nel senso che non esclude la possibilità di ritornare al punto di partenza dopo aver flirtato con l’eventualità della sua negazione. Un autore come Pressac, ad esempio, dopo aver considerato l’opzione del non-sterminio, si è convinto con rinnovato vigore della veridicità dello sterminio.
La momentanea sospensione del consenso nei confronti della tesi solitamente accettata in fondo non è altro che l’applicazione del principio della falsificabilità delle ipotesi scientifiche. Per scrupolo epistemologico, lo scienziato mette tra parentesi le proprie credenze e si interroga sul loro
reale statuto di verità.
La seconda fase del processo è invece segnata da un cambiamento strategico: non ci si accontenta più di negare in senso vago la tesi ufficiale, ma si afferma una nuova ipotesi. Tranne che, come ho osservato nei capitoli precedenti, i negazionisti si limitano a enunciare la propria tesi, la quale non è mai argomentata sulla base di solidi documenti storiografici.
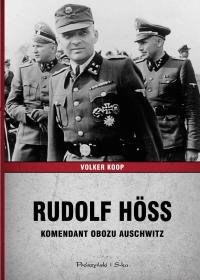
Attraverso la tecnica dell’insinuazione, essi si chiamano fuori dal gioco dei controlli incrociati, impedendo al resto della comunità scientifica di applicare all’ipotesi del complotto sionista i medesimi criteri di sanzione cognitiva che i negazionisti stessi pretendono di impiegare ai danni.del paradigma dominante.
Nel gioco delle parti incoraggiato dai negazionisti, i sostenitori della storiografia ufficiale si
trovano costretti a difendere la propria versione dei fatti la quale, essendo enunciata in positivo, offre facilmente il fianco alle critiche. I negazionisti, dal canto loro, concentrano tutti i loro sforzi sulla demolizione della tesi dominante, senza assumersi la responsabilità di dimostrare concretamente che la Shoah è il prodotto di una colossale contraffazione storica. Difatti, sarebbe fin troppo facile da parte della comunità degli storici falsificare questa tesi a dir poco esile.

Del resto, questa stessa tecnica è riscontrabile anche nei primi scritti critici di Faurisson, in cui l’ermetismo con il quale viene rifiutata la tradizione interpretativa ortodossa si accompagna al fondamentalismo con cui la chiave di lettura proposta dall’autore è presentata come l’unica possibile. In sé, l’ermetismo (o il nichilismo) non è pericoloso: è semplicemente poco produttivo. È per questo che l’inconcludenza del pensiero ermetico puro (del segreto perennemente differito) viene spesso “corretta” con la profferta di un’interpretazione a tenuta stagna, attorno alla quale non è ammesso alcun margine di discussione.
A livello discorsivo, ciò si traduce nell’adozione di quelle tecniche di mascheramento soggettivante volte ad accrescere l’autorevolezza quasi-sacerdotale dell’enunciatore. La fase distruttiva del negazionismo sfrutta, più o meno inconsapevolmente, il clima di relativismo e di incertezza che permea l’universo comunicativo, in virtù del quale le credenze collettive hanno perduto gran parte del proprio carattere “assiomatico”. Tuttavia, lo stato di perenne tensione interrogativa è logorante per i più, donde la tentazione di ricorrere a soluzioni cognitivamente meno dispendiose.

È cosi che, semplificando oltremodo la tesi avanzata nella fase propositiva delle loro argomentazioni, i negazionisti sperano di conquistare la riconoscenza di quei lettori che, stanchi di colpi di scena, si affidano a chi offre loro risposte elementari e intese come inconfutabili, le quali hanno inoltre il vantaggio di riposare su una secolare tradizione di antisemitismo.
A ben vedere, il negazionismo non è che il capitolo più aggiornato della storia della teoria della cospirazione ebraica. Secondo questo mito, esiste un governo ebraico segreto che, avvalendosi di una rete mondiale di organizzazioni, nonché del supporto di vari esponenti del potere politico, controlla i governi, la stampa (dunque l’opinione pubblica) e l’economia mondiale allo scopo di ottenere la dominazione universale. Il mito ha origini remote, ma si cristallizza nella sua forma “matura” (la cui espressione più completa è costituita dai Protocolli dei Savi Anziani di Sion) verso la fine dell’Ottocento.

Ripercorriamone brevemente le tappe principali. L’atteggiamento ostile verso gli ebrei – che ritroviamo anche nell’antico Egitto (vedi sommossa a Elefantina nel 410 a.C.) – non è sempre indice di antisemitismo, se con questo termine intendiamo riferirci a “una forma di ostilità contro un gruppo di cui ci si fa una certa rappresentazione astratta e che è dunque definito ideologicamente”. Yves Chevalier distingue l’antisemitismo (che secondo lui è imperniato sul meccanismo dell’espiazione) dall’antigiudaismo cristiano, una forma di opposizione religiosa e filosofica contro l’ebraismo in quanto dottrina.
Inizialmente dettato dalla competizione tra le due religioni, l’antigiudaismo – nella misura in cui elabora e diffonde stereotipi calunniosi circa gli ebrei – è la condizione necessaria all’insorgere dell’antisemitismo vero e proprio. Infatti, l’accusa di deicidio rivolta agli ebrei, unita alla loro demonizzazione (che si fa sempre più comune nel corso del Medioevo) e alla progressiva emarginazione a cui sono sottoposti, trasforma questo gruppo in una vittima ideale del meccanismo del sacrificio espiatorio: è ben visibile (dotato di segni distintivi: l’aspetto, l’abbigliamento, la residenza, la professione esercitata, ecc.), vulnerabile (in quanto poco tutelato dalla legge), e le accuse che gli si rivolgono appaiono credibili proprio perché coincidono con gli stereotipi più diffusi e radicati che lo riguardano (l’ebreo infido, perfido, empio – l’accusa di rapacità economica subentrerà più avanti).

Così, quando nel 1150 a Norwich gli ebrei vengono accusati dell’assassinio rituale di un adolescente, la diceria viene creduta perché conferma le aspettative comuni circa la loro vera natura, anche dopo che le inchieste ordinate per far luce su questo fatto dimostrano la
totale innocenza degli imputati. Nel Medioevo si comincia a parlare della cospirazione giudaica per conquistare il mondo e sovvertire silenziosamente l’ordine esistente. Questo mito si riaffaccia prepotentemente durante il periodo della Grande Peste del 1348-52, quando gli ebrei vengono accusati di inquinare i pozzi con il veleno e di servirsi dei lebbrosi per spargere le malattie. L’ebreo viene assimilato alla figura di Satana e a quella della strega.
Dopo la Rivoluzione francese, la rappresentazione demonologica dell’ebreo si amalgama con le inquietudini ingenerate dai capovolgimenti sociali in atto. Vaste porzioni della popolazione europea assistono con sgomento ai grandi mutamenti che investono l’Occidente (urbanizzazione, industrializzazione nascita della borghesia capitalistica, liberalismo, laicismo, democrazia, ecc.), ed è in questo clima di trasformazione che taluni tra i più accaniti avversari delle riforme sociali incriminano gli ebrei della rovina del mondo moderno.

È a questo punto che sull’antica ostilità verso gli ebrei si innesta un’altra configurazione mitica: quella che attribuisce un potere occulto e onnipervasivo alle sette massoniche. L’occasione per l’innesto è fornita dalla pubblicazione del Mémoire pour servir à l’histoire du jacobinisme (1797) dell’abate Barruel, in cui la Rivoluzione francese è descritta come il punto culminante della cospirazione dei Templari per distruggere tutte le monarchie e il papato al fine di ottenere la dominazione mondiale.
Barruel non parla ancora degli ebrei, ma nel 1806 egli riceve una lettera da un certo capitano Simonini, il quale sostiene di essere stato informato da un gruppo di influenti ebrei torinesi che da secoli la “setta giudaica” (che sta a capo di tutte le sette anticristiane) agisce oscuramente per annientare il cristianesimo e per conquistare il mondo. La lettera, probabilmente scritta dagli agenti di Fouché per screditare la comunità ebraica francese con la quale Napoleone ha stretto legami di collaborazione, racchiude il nocciolo del mito della cospirazione giudaico-massonica.

Quest’ultimo assumerà caratteri di volta in volta diversi, che variano dai toni apocalittici assunti da Gougenot des Mo[u]sseaux (1869) nel profetizzare l’imminente avvento al potere dell’Anticristo e dei suoi accoliti (gli “ebrei cabalisti”), a quelli più fattivi impiegati da Osman-Bey nella Conquête du monde par les Juifs in cui, mentre attacca l’Alliance Israélite Universelle (istituzione fondata a Parigi nel 1860 per fornire assistenza agli ebrei
russi perseguitati), prefigura la soluzione finale nazista quale unico rimedio contro la cospirazione ebraica.
I diffusori della teoria del complotto giudaico-massonico si avvalgono con molta disinvoltura di tutti gli scritti che confermino la loro ipotesi (comprese le opere di finzione) e, all’occorrenza, non esitano a fabbricare da sé i documenti di cui necessitano per infamare gli ebrei. A questo proposito è significativo l’intreccio di realtà e finzione che sta alla base della genesi dei Protocolli.
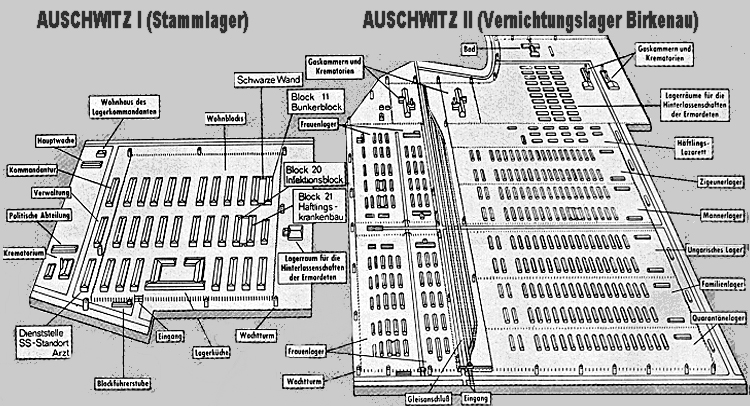
Al di sotto di questo testo è infatti possibile ricostruire una stratificazione di fonti: I misteri del popolo di Sue, un capitolo del Biarritz di Goedsche, a sua volta tratto da una scena del Giuseppe Balsamo di Dumas, un libello scritto da Maurice Joly contro Napoleone III, una riscrittura del medesimo libello da parte di Elie de Cyon ai danni del conte russo Sergej Witte e, infine, un terzo adattamento del testo in questione a opera di Rachovskij in cui le idee deprecabili ivi contenute sono attribuite ai Savi di Sion.
Sebbene vengano pubblicamente riconosciuti come falsi nel 1921, i Protocolli riscuotono un grande successo editoriale nel corso del secolo: diffusi in Russia dai pogromtciki (gli istigatori professionali dei pogrom) e tradotti in varie lingue a partire dagli anni Venti, essi vengono invocati dai nazisti per giustificare la persecuzione degli ebrei e, a tutt’oggi, sono largamente sfruttati da parte della propaganda antisionista (in alcuni paesi arabi i Protocolli sono considerati un bestseller).

I discorsi dei negazionisti possono essere agevolmente collocati in questo filone dell’antisemitismo storico. Lo scheletro delle loro argomentazioni rimane la logora trama della cospirazione ebraica, a dispetto delle cautele adottate dai più scaltri negatori della Shoah per rinnegare le proprie ascendenze ideologiche. Come ho ripetutamente osservato, infatti, l’idea che gli ebrei si siano inventati il genocidio nazista per promuovere la causa sionista non regge senza l’appoggio di una teoria del complotto.
Anche la maggior parte degli assunti impiegati dai negazionisti a sostegno della loro tesi risalgono a scritti anteriori: le illazioni sullo strapotere economico dei Rothschild e della loro stirpe risalgono all’antisemitismo di sinistra di fine Ottocento; l’equazione ebraismo — comunismo si ritrova in Vinberg (pogromtcik affiliato alle Centurie Nere) e negli scritti di Rosenberg (l’ideologo del nazismo); l’idea che gli ebrei detengano il potere dell’industria culturale (stampa, cinema, ecc.) — e che pertanto siano nella posizione ideale per falsificare i documenti storici — è già enunciata nei Protocolli.

L”ipotesi che Roosevelt fosse un complice degli ebrei riecheggia analoghe accuse rivolte a innumerevoli uomini politici, da Napoleone (nel 1806 correva voce che fosse amico degli ebrei, se non ebreo egli stesso) a Wilson, Clemenceau e Lloyd George (questa tesi è sostenuta da Giovanni Preziosi nella rivista La vita italiana), da Chiangkai-shek (che nel 1938 viene additato dalla propaganda giapponese come un rappresentante della massoneria giudeo-bolscevica) a Roosevelt stesso (negli anni Trenta alcuni gruppi antisemiti statunitensi sostengono che il New Deal sia un regno del terrore imposto dagli ebrei).
Perfino la denuncia della presunta responsabilità ebraica per la conflagrazione del secondo
conflitto mondiale vanta precedenti illustri: ad esempio, nel testamento politico di Hitler (dettato nella notte tra il 28 e il 29 aprile 1945) si legge che non fu affatto la Germania a far scoppiare la guerra del 1939, ma che questa fu voluta e provocata dai finanzieri internazionali ebrei e dai loro complici.

Alla stessa stregua, in uno dei suoi pamphlet antisemiti pubblicati tra il 1919 e il 1923, Rosenberg attribuisce agli ebrei la responsabilità dei pogrom in Russia: secondo lui, infatti, la Russia zarista si era attirata l’ostilità della popolazione ebraica (e aveva perciò reagito con i pogrom) non come conseguenza delle persecuzioni, ma perché si rifiutava di finanziare il capitalismo. Come nella favola del Lupo e l’agnello, le vittime delle persecuzioni vengono accusate di avere attaccato per prime.
Così come i contenuti delle loro argomentazioni, anche le strategie espositive e retoriche impiegate dai negazionisti rivelano il loro pedigree l’uso selettivo e spregiudicato delle fonti è una costante della manipolazione ideologica; il ricorso a metodi di autoconferma, per cui attraverso la reciproca citazione i testi dei sobillatori tentano di accrescere la rispettiva credibilità, è ampiamente utilizzato dai libellisti ottocenteschi; lo sfruttamento degli stereotipi circa la natura infida, scellerata e depravata degli ebrei è ereditato dalla tradizione antisemita, che in certi casi (come negli scritti di Rosenberg e di Nesta Webster) attribuisce l’immoralità levantina all’influenza della Cabala sulla mentalità ebraica.

Dunque, i negazionisti raccolgono il testimone dell’antisemitismo storico. Il compito che si
autoassegnano (che lo dichiarino o meno) è di anestetizzare il trauma della Shoah per mantenere viva la diffidenza nei confronti degli ebrei. Per fare ciò essi sono costretti a ripudiare il paradigma antisemita che li accoglie: in un’epoca di maggiore sensibilità verso i rischi del razzismo, non basta più asserire che gli ebrei si sono meritati la loro sorte (come invece fanno tranquillamente molti neonazisti dichiarati), ma occorre dimostrare che i crimini di cui essi sostengono di essere stati vittime non sono mai esistiti.

A questo punto non manca che di individuare l’artefice della menzogna, ed ecco che i negazionisti introducono un elemento di novità nella teoria della cospirazione giudaica: questa volta, i presunti colpevoli sono le vittime stesse. Questa tesi venne sviluppata da Eichmann durante il processo a Gerusalemme del 1961: in quell’occasione, egli sostenne che Hitler stesso era una marionetta in mano ai finanzieri ebrei.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
AA.VV.
1989 L’imperatore inesistente, Palermo, Sellerio
AA.VV.
1991 Relations internationales n. 65
AA.VV.
1993 Peirce in Italia, Napoli, Liguori
ADORNO, THEODOR W.
1994 Contro l’antisemitismo, Roma, manifestolibri
ANTI-DEFAMATION LEAGUE
1993 Hitler’s Apologists: the Anti-Semitic Propaganda of Holocaust “Revisionism”
1994 Researcb Report. Uncommon Ground: Tbe Black African Holocaust Council and Other Links between Black and White Extremists
ARAD, YITZHAK
1989 “Operation Reinhard”: Extermination Camps of Belzec, Sobibor and Treblinka”, in Tbe Nazi Holocaust, Meckler, Westport London
ARENDT, HANNAH
1963 Eichmann in Jerusalem, New York, Viking Penguin
AUTHIER-REVUTZ, JACQUELINE—ROMEAU, LYDIA
1984 “La place de l’autre dans un discours de falSification de l’histoire”, in Mots, 8
BARNOUW, DAVID—VAN DER STROOM, GERROLD (ed. crit. a cura di)
1986 De Dagboeten van Anne Frank (tr. fr. 1990, Les journaux d’Anne Frank, Paris, Calmann- Lévy)
BARTHES, ROLAND
1967 “Le discours de l’histoire”, in Information sur les sciences sociales, VI, 4
BASTIAN, TILL
1994 Auschwitz und die «Auschwitz-Lüge», Munchen, C.H. Beck’sche
Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck) (tr. it. 1995, Auschwitz e la «menzogna su Auschwitz», Torino, Bollati Boringhieri)
BASTIDE, FRANÇOISE
1981 “La démonstration: analyse de la structure actantielle du faire-croire ‘. in Actes sémiotiques, III, 28, 1981
BAZIN, ANDRÉ
1958 Qu’est-ce que le cinéma, Paris, Cerf (tr. it. 1986, Che cosa è il cinema ?, Milano, Garzanti)
BENVENISTE, ÉMILE
1966 Problèmes de linguistique générale, Paris Gallimard (tr.it 1994, Problemi di linguistica generale, Milano, Il Saggiatore)
BLASI, GIULIO
1990 “Bakespeare. Paradoxical Operations on the Concept of Author”, in VS 57, Milano, Bompiani
BONOMI, ANDREA
1994 Lo spirito della narrazione, Milano, Bompiani
BRAYARD, FLORENT
1996 Comment l’idée vint à M. Rassinier, Paris, Fayard
CARR, EDWARD HALLETT
1961 What Is History ?, New York, Knopf
CHARTIER, ROGER
1995 “‘Fare storia’ vent’anni dopo”, in La Rivista dei libri, n. 6
CHERSOVANI, LICIA
1990 “Le pretese scientifiche del razzismo”, in Qualestoria, n. 2-3
CHEVALIER, YVES
1988 L ‘Antisémitisme – Le Juif comme bouc émissaire, Paris, Cerf
CIUFFOLETTI, ZEFFIRO
1993 Retorica del complotto, Milano, ll Saggiatore
COHN, NORMAN
1967 Warrant for Genocide the Myth of the Jewish World-Conspiracy and the Protocols of the Elders of Sion, London, Eyre & Spottiswoode (tr. it. 1969, Licenza per un genocidio, Torino, Einaudi)
CORNI, GUSTAVO
1990 “L’antisemitismo in Europa fra Ottocento e Novecento. L’antisemitismo in Germania nel primo dopoguerra, il nazismo e lo sterminio”, in Qualestoria, n. 2-3
DARNTON, ROBERT
1985 The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History, New York, Basic Books (tr. it. 1988, Il grande massacro dei gatti, Milano, Adelphi)
DE CERTEAU, MICHEL
1975 L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard (tr. it. 1977, La scrittura della storia, Roma, Pensiero scientifico)
DUBY, GEORGES
1995 “Scrivere storia”, in La scrittura e la storia, Firenze, La Nuova Italia
ECO, UMBERTO
1975 Trattato di semiotica generale, Milano, Bompiani
1979 Lector in fabula, Milano, Bompiani
1985 Sugli specchi e altri saggi, Milano, Bompiani
1990 I limiti dell’interpretazione, Milano, Bompiani
1994 Sei passeggiate nei boscbi narrativi, Milano, Bompiani
Eco, UMBERTO—SEBEOK, THOMAS (a cura di)
1983 The sign of Three – Dupin, Holmes, Peirce. Bloomington, Indiana University Press (tr. it. 1983, Il segno dei tre, Milano, Bompiani)
FINKIELKRAUT, ALAIN
1982 L’Avenir d’une négation. Réflexion sur la question du génocide, Paris, Seuil
FRANK, ANNE
1993 Diario, Torino, Einaudi
FRESCO, NADINE
1980 “Les Redresseurs de Morts”, in Les Temps Modernes, n. 407
1988 “Parcours du Ressentiment”, in Lignes, n. 2
1990 voce “Révisionnisme”, in Encyclopédia Universalis, vol. 19
FRIEDLÄNDER, SAUL
1967 Kurt Gerstein ou l’ambiguïté du bien, Paris, Casterman
FRIEDRICH, OTTO
1982 “The Kingdom of Auschwitz 1940-45”, in The End of the World (tr. it. 1994, Auschwitz. Storia del lager 1940-45, Milano, Baldini & Castoldi)
GADAMER, HANS GEORG
1960 Wahrheit und Method, Tübingen, Mohr (tr. it. 1983, Verità e metodo, Milano, Bompiani)
GENETTE, GÉRARD
1987 Seuils, Paris, Seuil (tr. it. 1989, Soglie, Torino, Einaudi)
GINZBURG, CARLO
1979 “Spie. Radici di un paradigma indiziario”, in Gargani (a cura di), Crisi della ragione, Torino, Einaudi
GIORELLO, GIULIO
1994 Introduzione alla filosofia della scienza, Milano, Bompiani
GIRARD, RENÉ
1982 Le bouc émissaire, Paris, Grasset & Fasquelle
GREIMAS, ALGIRDAS JULIEN
1983 Du Sens II – Essais sémiotiques, Paris, Seuil (tr. it. 1984, Del Senso II, Milano, Bompiani)
GREIMAS, A. J. – COURTÉS, JOSEPH
1979 Sémiotique, Paris, Hachette
GRICE, H. PAUL
1967 Logic and Conversation, The William James Lectures at Harvard University (non pubbl.) (tr. it. in Sbisà [a cura di] 1978, Gli atti linguistici Milano, Feltrinelli)
HARTMAN, GEOFFREY (a cura di)
1994 Holocaust Remembrance, Cambridge (Mass.), Basil Blackwell Ltd
HAUPT, PETER I.
1991 “A Universe of Lies: Holocaust Revisionism and the Myth of a Jewish World-Conspiracy”, in Patterns of Prejudice, n. 1, London
HlLBERG, RAUL
1985 The Destruction of the European Jews 3 voll., New York and London, Holmes & Meier (tr. it. 1995, La distruzione degli Ebrei d’Europa, Torino, Einaudi)
HÖSS, RUDOLF
1958 Kommandant in Auschwitz, Stuttgart, Deutsche Verlag-Anstalt (tr. it. 1960, Comandante ad Auschwitz, Torino, Einaudi, ed. 1985)
HUTCHEON, LINDA
1988 A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, London, Routledge
JOFFROY, PIERRE
1972 L ‘Espion de Dieu, Paris, Grasset
KREMER, JOHANN PAUL
1971 Hefte von Auschwitz, Oswiecim, Staatliches Auschwitz-Museum
KUHN, THOMAS S.
1962 The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press (tr. it. 1969, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino. Einaudi)
LANGBEIN, HERMANN
1972 Menschen in Auschwitz, Wien, Europa Verlag GmhH (tr. it. 1984, Uomini ad Auschwitz, Milano, Mursia)
LAVAGNETTO, MARIO
1995 “Bugia/storia/finzione/verità”, in La scrittura e la storia, Firenze, La Nuova Italia
LE GOFF, JACQUES
1982a “Documento/Monumento”, Enciclopedia Einaudi, vol. V
1982b “Storia”, Enciclopedia Einaudi
LEJEUNE, PHILIPPE
1975 Le pacte autobiographique, Paris, Seuil (tr. it. 1986, ll patto autobiografico, Bologna, Il Mulino)
LÉVI-STRAUSS, CLAUDE
1962 La pensée sauvage, Paris, Plon (tr. it. 1979, Il Pensiero selvaggio, Milano, Il Saggiatore)
LIPSTSTADT, DEBORAH
1993 Denying the Holocaust, New York, Macmillan
LORAUX, PATRICE
1990 “Consentir”, in Le consensus. nouvel opium ?, Le Genre Humain,
n. 22, Paris, Seuil
LOTMAN, JURIJ—USPENSKIJ, BORIS
1975 Tipologba della cultura, Milano, Bompiani (ed. 1987)
LOZANO, JORGE
1991 Il discorso storico, Palermo, Sellerio
LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS
1983 Le différend, Paris, Les Éditions de Minuit (tr. it. 1985, Il dissidio. Milano, Feltrinelli)
MARCHESE, ANGELO
1978 Dizionano di retorica e stilistica, Milano, Mondadori
NORRIS, CHRISTOPHER
1994 Truth and the Ethics of Criticism, Manchester University Press
OLENDER, MAURICE
1993 “Usi ‘politici’ della preistoria indoeuropea”, in Radici e frontiere, Marx Centouno
PEIRCE, CHARLES S.
1901 “On the Logic of Drawing History from Ancient Documents Especially Testimonies” (tr. it. in Le leggi dell’ipotesi, 1984, Milano, Bompiani)
PERELMAN, CHAIM—OLBRECHTS-TYTECA, LUCIE
1958 Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, Paris, Presses Universitaires de France (tr. it. 1966 e 1989, Trattato dell’argomentazione, Torino, Einaudi)
PICCIOTTO FARGION, LILIANA
1991 Il libro della memoria, Milano, Mursia
PISANTY, VALENTINA
1993 Leggere la fiaba, Milano, Bompiani
POLIAKOV, LÉON
1951 Le Bréviaire de la Haine, Paris, Calmann-Lévy
1964 “Le dossier Gerstein”, in Le Monde Juif, janvier/mars 1964
POMIAN, KRYSTOFF
1982 “Natura, storia, conoscenza”, in Enciclopedia Einaudi
POPPER, K. R .
1934 Logik der Forschung, Vienna (tr. it . 1970, Logica della scoperta scientifica, Torino, Einaudi)
1972 Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Bologna, Il Mulino
POZZATO, MARIA PIA (a cura di)
1989 L’idea deforme. Interpretazioni esoteriche di Dante, Milano, Bompiani
PRESSAC, JEAN-CLAUDE
1989 Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers, New York, The Beate Klarsfeld Foundation
1993 Les crématoires d’Auschwitz. La machinerie du meurtre de masse Paris, CNRS
REITLINGER, GERALD
1953 The Final Solution London, Vallentine, Mitchell and Co. (tr. it. 1962 Milano, Il Saggiatore)
RIOUX, JEAN-PIERRE
1987 “Pas Révisionnistes mais négateurs”, in Information Juive, n 69
ROBERTS, I. M.
1972 The Mythology of Secret Societies, London, Secker & Warburg
ROMANO, SERGIO
1992 I Falsi Protocolli, Milano, Corbaccio
SCHOPENHAUER, ARTHUR
1864 “Dialektik”, in Arthur Schopenhauers handschriftlicher Nachlasss Leipzig, Brockhaus (tr. it. 1991, L’arte di ottenere ragione, Milanos Adelphi)
TODOROV, TZVETAN
1991 Les morales de l’histoire, Paris, Grasset & Fasquelle (tr. it. 1995, Le morali della storia, Torino, Einaudi)
TODOROV, TZVETAN (a cura di)
1965 Théorie de la littérature, Paris, Seuil (tr. it. 1968, I formalisti russi, Torino, Einaudi)
TOPOLSKI, JERZY
1973 Metodologia historii, Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe (tr. it 1975, Metodologia della ricerca storica, Bologna, Il Mulino)
TREGENZA, MICHAEL
1989 “Belzec Death Camp”, in The Nazi Holocaust, Meckler, Westport London
VANNONI, GIANNI
1985 Le società segrete dal Seicento al Novecento, Firenze, Sansoni
VATTIMO, GIANNI—ROVATTI, PIER ALDO (a cura di)
1983 Il pensiero debole, Milano, Feltrinelli
VIDAL-NAQUET, PIERRE
1987 Les assassins de la mémoire, Paris, La Découverte
VIOLI, PATRIZIA—MANETTI, GIOVANNI
1979 L’analisi del discorso, Milano, L’Espresso strumenti
WEBSTER, NESTA
1924 Secret Societies and Subversive Movements, London, Boswell Printing & Publishing Co. Ltd
WELLERS, GEORGES
1977 “La ‘solution finale de la question juive’ et la mythomanie néo-nazie”, in Le Monde Juif n 177,
avril/juin 1977
WHITE, HAYDEN
1973 Metahistory, Baltimore, Johns Hopkins University Press (tr. it. Retorica e storia, Napoli, Guida)
WORMSER-MIGOT OLGA
1968 Le Système concentrationnaire nazi (1933-1945), Paris, Presses Universitaires de France
Testi dei negazionisti
ANONIMO (Hoggan)
1968 The Myth of theSix Million, Torrance, The Noontide Press
ANONIMO
1987 “L’affaire de la thèse de Nantes”, in Annales d’Histoire Révisionniste, n. 1
APP, AUSTIN J.
1978 “The ‘Holocaust’ Put in Perspective”, in JHR, n 1
BARDÈCHE, MAURICE
1948 Nuremberg ou la Terre Promise, Paris, Les Sept Couleurs
1950 Nuremberg II ou les Faux Monnayeurs, Paris, Les Sept Couleurs
BUTZ, ARTHUR
1976 The Hoax of the XXth Century, Torrance, Institute for Historical Review
1978 “The Faurisson Affair”, in JHR, n. 1
CHRISTOPHERSEN, THIES
1973 Die Auschwitz Lüge (tr. it. 1984, La fandonia di Auschwitz, Parma, La Sfinge)
COHN-BENDIT, J -G
1985 “Mon analyse du ‘Journal de Kremer”‘, Saint-Nazaire
FAURISSON, ROBERT
1962 “A-t-on lu Rimbaud?”, Bizarre, n 21-22
1972 A-t-on lu Lautréamont?, Paris, Gallimard
1977a La Clé des Chimères et Autres Chimères de Nerval, Paris, J.-J. Pauvert
1977b “Je cherche midi à midi”, in Les Nouvelles Littéraires, 10-17/2
1980 Mémoire en défense, Paris, La Vieille Taupe
1982 Réponse à Pierre Vidal-Naquet, Paris, La Vieille Taupe
FELDERER, DITLIEB
1980 “Auschwitz Notebook. Certain Impossibilities of the ‘Gerstein Statement”‘, Journal of
Historical Review, vol. 1
GARAUDY, ROGER
1995 Les mythes fondateurs de la politique israélienne, Paris, La Vieille Taupe
GILLOT, JACQUES
1987 “À propos de ‘Shoah'”, in Annales d’Histoire Révisionniste, n. 3
GRIMSTAD, WILLIAM N. (ed.)
1977 The SixMillion Reconsidered. Torrance,The Noontide Press
HARWOOD, RICHARD
1974 Did SixMillion Really Die ?, Richmond, Historical Review Press
MATTOGNO, CARLO
s.d. Auschwitz: le “confessioni” di Höss, Parma La Sfinge
1985 Il rapporto Gerstein: anatomia di un falso, Monfalcone, Sentinella d’ltalia
1986 Auschwitz: un caso di plagio, Parma, La Sfinge
NOI (Nation of Islam)
1991 The Secret Relationship between Blacks and Jews Boston, Latimer Associates
RASSINIER, PAUL
1950 Le mensonge d’Ulysse, Éditions Bressanes (tr it 1966, La Menzogna di Ulisse, Milano, Le Rune)
1967 Les Responsables de la seconde guerre mondiale, Paris, Nouvelles Éditions Latines
ROQUES, HENRI
Pisanty : L’irritante questione delle camere a gas
1985 Les “confessions ” de Kurt Gerstein. Étude comparative des différentes versions, Nantes (tesi di dottorato)
1987 “De l’affaire Gerstein à l’affaire Roques”, in Annales d’Histoire Révisionniste, n. 3
STÄGLICH, WILHELM
1986 Le Mythe d’Auschwitz, Paris, La Viellie Taupe (tr. dal ted., 1979, Tübingen, Grabert-Verlag)
THION, SERGE
1980 Vérité historique ou Vérité politique ? La Vieille Taupe (tr. it. Il caso Faurisson)
WALENDY, UDO
1978 “The Fake Photograph Problem”, in JHR, n. 1
1988 Der Leuchter-Bericht. Ein Ingenieursbericht über die angebliche Gaskammern in Auschwitz,
Birkenau und Majdanek, Polen, Vlotho /Weser


