a cura di Cornelio Galas
Fonte: “Nikolajewka: c’ero anch’io”. Giulio Bedeschi. Testimonianze fra cronaca e storia

Sergente maggiore Roberto Fantaguzzi
Battaglione Sciatori Monte Cervino
Verso la fine del gennaio ’43 durante la ritirata ci siamo ritrovati, ormai sbandati, cinque alpini del Battaglione Sciatori Monte Cervino e precisamente Roberto Fantaguzzi, il caporale Mario Poncaz (morto durante la spedizione italiana al K 2 del ’54) il caporale Grossi, l’alpino Bosetti e l’alpino Silvestri.
Mentre si attraversava un paese abbiamo visto in una casa colonica tipo fattoria una slitta e nella stalla un cavallo. Siamo andati dalla proprietaria o meglio gerente dell’azienda per chiedere chi fosse il proprietario della slitta e del cavallo. La donna ci comunica che un gruppo di tedeschi avevano requisito tutto e si trovavano nella casa a mangiare. La donna inoltre ci fa capire di non essere d’accordo con i tedeschi e ben contenta di favorire gli italiani. Basta un’occhiata e subito ci si mette all’opera per il recupero della slitta.

Io sto di guardia vicino ai tedeschi per controllare le loro mosse, tre s’affannano al ricupero della slitta, uno bada al cavallo, appena tutto è pronto un fischio e via verso Karkow. Molte volte durante la ritirata la popolazione russa ha portato aiuto a tutti i soldati. Una volta ho chiesto ad una donna perché trattasse così bene il nemico; mi ha risposto che aveva il marito in guerra e trattava bene me con la speranza che lo stesso trattamento fosse riservato anche a suo marito trovandosi nelle stesse mie condizioni.
DIVISIONE CUNEENSE
di Giulio Bedeschi
Dopo aver tenuto la linea sul Don fino al 17 gennaio 1943 dando man forte alla Julia ogni qual volta gli attacchi russi impegnavano anche il proprio settore, la Cuneense ripiegò su Popowka marciando fino al 18, in terribili condizioni di clima e di stanchezza. Il 19, lasciata a sera Popowka, la Cuneense mosse verso Nowo Postojalowka che raggiunse a notte inoltrata, dopo varie vicissitudini e scontri con i russi.

Di concerto coi Comandi della Julia raggiunti a Nowo Postojalowka, la Cuneense all’alba del 20 gennaio attaccò con il Battaglione Ceva e con l’appoggio del Gruppo Mondovì, e più tardi con il Battaglione Mondovì, inserendosi con gravissime perdite ma con strenuo valore nello svolgersi di quella sanguinosa battaglia offensiva, protrattasi poi per tutta questa seconda giornata nell’intento di aprire un varco, con le forze della disperazione più ancora che con le armi inadeguate, e sfondare la sacca che gli alpini ritenevano circoscritta e delimitata a quella località.
Si unì in combattimento con i reparti della Julia già impegnati dal giorno precedente, di fronte all’accresciuta resistenza russa sempre alimentata dal sopraggiungere di nuove forze; vennero impiegati i sopraggiunti battaglioni del 2^ Alpini Saluzzo e Borgo San Dalmazzo, e infine il Dronero, appoggiati dai Gruppi Pinerolo e Val Po. Tutte le forze disponibili a Nowo Postojalowka delle due divisioni alpine venivano così gettate nella fornace, senza però che riuscissero a sfondare, nonostante l’indescrivibile valore dispiegato.

Soltanto a notte, operando una diversione che rappresentava l’ultimo tentativo di sorprendere la vigilanza russa visto che era caduta ogni speranza di sopraffare la forza nemica, muovendo in perfetto silenzio nel fondo di alcune balke, alle colonne della Cuneense e della Julia nonostante l’appesantimento causato dalle lunghe teorie di muli e di slitte riuscì di sfilare attraverso le maglie dello schieramento nemico: probabilmente i russi, pure in forze sovrabbondanti, non ritenevano quelle provatissime truppe italiane, reduci da due giorni di strenui combattimenti, ancora capaci di un trasferimento militare, ma ormai vinte dai sanguinosissimi combattimenti e dall’estremo rigore del clima notturno.
Durante la stessa notte però la colonna si imbatté in ingenti forze russe, contro le quali il Battaglione Mondovì impegnò combattimento, che valse a favore degli alpini a prezzo di forti perdite, allora la colonna della Cuneense risultò frammentata in nuclei che marciando nella steppa ad ore diverse e ben spesso su itinerari diversi, ebbero vicende e storia dissimili.

Sempre assottigliandosi strada facendo, ora per ora decimati dalle battaglie dal gelo e dalla fame, i reparti della Cuneense procedettero inflessibilmente lungo le strade della ritirata. Non avendo più ricevuto alcun ordine superiore che li distogliesse dalla meta finale, Waluiki, verso quella città sempre tesero, talvolta incrociando l’itinerario della Tridentina, quasi sempre marciando su itinerario proprio, esposti pertanto a ogni iniziativa del nemico e ad ogni sorpresa della sorte.
Sempre spezzando le resistenze nemiche, specie a Krawzowka, a Nowo Dmitrowka (ove il IV Battaglione Genio si impegnò con grande valore in combattimento, tanto da uscirne vittorioso ma semidistrutto); a Garbusowo a Shukowo, a Malakijewa, dove il 25 gennaio si impegnarono a fondo i Battaglioni Dronero e Mondovì assieme ad un reparto misto di formazione, costituito da alpini e artiglieri alpini. Per giorni e giorni i tronconi della Cuneense marciarono sulla neve, senza altro collegamento che la comune volontà di resistere e combattere fino a superare tutte le estreme avversità della situazione. Solontzy, Woronowka.

Il 26 gennaio, mentre la Tridentina era impegnata nella battaglia di Nikolajewka, non molti chilometri a sud la Cuneense ancora ostinatamente combatteva nonostante lo sgomento di procedere isolata nel vuoto, sempre col passo sbarrato dalla invisibile rete distesa sulla neve dai russi. All’alba del 27 gennaio le avanguardie della Cuneense raggiunsero i pressi di Waluiki, la meta agognata verso cui si erano tese le speranze e le volontà di tanti alpini. Ma la presenza di aerei russi che mitragliano e bombardano gli alpini, e gli attacchi di reparti di cavalleria russa che infieriscono sulle schiere tolgono ogni dubbio: Waluiki è saldamente tenuta dai russi.
Nonostante lo scoramento disarmante, durante la giornata a Roshdestweno e dinnanzi a
Waluiki i vari reparti ingaggiano gli ultimi strenui combattimenti finché, esaurite le munizioni, dal Comando della Cuneense viene dato l’ordine di resa. Rimaneva ancora, attardato in servizio di retroguardia, il battaglione Mondovì che giunto dinnanzi a Waluiki impegnava combattimento, e lo proseguiva fino a notte protraendo la eroica resistenza sino all’alba dell’indomani, rifiutando la intimazione di resa fatta dai russi.
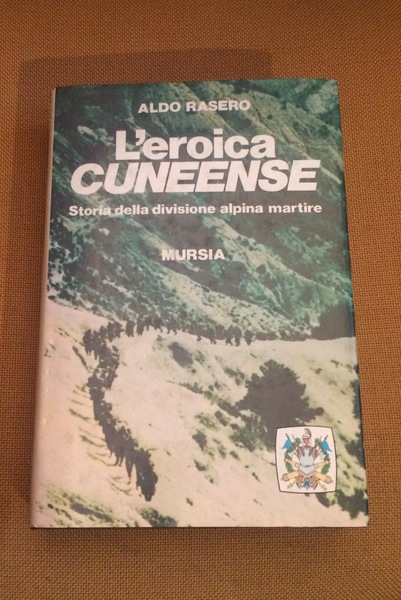
Poi, nel corso del 28 gennaio, sul campo dell’ultima battaglia della Cuneense in terra di Russia si stendeva il silenzio, e per i superstiti si apriva l’atroce vicenda della prigionia. Dalla sacca, al termine della ritirata uscirono vivi 1300 alpini, sui circa 20.000 che componevano la Cuneense.
Capitano Alberto Penzo
Comando Divisione Cuneense
Il 25 gennaio, con Colturi e Gianasso discutiamo perché alla mattina presto bisogna assolutamente partire insieme agli altri; purtroppo i conducenti hanno una mentalità loro propria, mancano della precauzione del combattente; quando arrivano si cavano le scarpe incuranti dell’allarme che può capitare ad ogni istante e per cui bisogna assolutamente partire all’improvviso. Colturi questa mattina stava colpendone uno con una fune tanto era arrabbiato.
Di buona lena ci avviammo cercando di sorpassare la colonna e raggiungere i reparti della Tridentina; ad un certo punto la slitta di testa s’incaglia contro un crepaccio, i muli naturalmente danno uno strappo e quella si sfascia. Gianasso e Matteis, seduti imperterriti sopra, non si muovono: Colturi li investe con male parole per farli scendere; scarichiamo, grattiamo la neve e scorgendo il ponte rotto, Colturi è preso da subitaneo sconforto, si mette a piangere dicendomi: “E” finita, Penzo, non arriviamo più a casa”.

Ha i nervi che non resistono più, continuamente tesi come sono e con lo spirito che egli mette in ogni cosa. Gli dico di avere pazienza, di star calmo, penso a tutto io, non l’abbandono di certo. Così dopo un lavoro di un’ora riusciamo a mettere a posto alla meglio ogni cosa e si riparte con Colturi rianimato e di nuovo fiducioso. Nel pomeriggio riusciamo ad arrivare alla testa della colonna, di fianco al Gruppo Bergamo, i cui conducenti si sono stretti uno all’altro per non essere separati dalla massa di sbandati che incalza.
Arriviamo così in una vallata che si presenta piena di isbe, tutto un villaggio, una zona ridente, nella quale gli alpini trovano ogni bene di Dio, galline, uova, miele, capre, crauti, patate; perfino delle mele conservate in salamoia, che per quanto invitanti (sembrano le rosse mantovane!) sono perfide e non riusciamo a mangiarle. Purtroppo anche qui i camini sono spenti, brutto segno!

Riusciamo ad occupare due isbe, una per i feriti e gli ammalati, l’altra per il comando; perché qualcuno ha detto di avere visto il generale Battisti e lo aspettiamo: non si vede né lui né alcun altro del comando. Ma la notte non è tranquilla, pur essendo ben sistemati: prima brucia una coperta sulla stufa, poi allarmi continui; alle due vengono a dirci che tutti se ne sono andati…
Gianasso spaventato se ne esce; vado a vedere, nelle isbe c’è ancora l’Edolo, mentre il Bergamo sta preparandosi a partire dovendo raggiungere la posizione. Torno a dire di stare calmi e di riposare, alle cinque si comincia a sentire qualche sparo lontano, si affretta la partenza. Arriva un soldato dalle isbe fiancheggianti il paese, un po’ discoste, dicendo di essere scampato a tempo, vi sono i partigiani che stanno facendo fuori tutti quelli che trovano!
Ci muoviamo che comincia la sparatoria; si vedono ombre muoversi e correre in distanza, non siamo sicuri se russi o nostri che scappano; si percorre circa duecento metri fra le isbe, poi la strada gira a sinistra, sale su un argine intasato di soldati e slitte: si deve attraversare un ponte dove la sparatoria è più fitta; vedo il generale Tamassia e ‘ il generale De Filippi che su una slitta gridano per fare un po’ di ordine; nell’intasamento nessuno si muove, è come paralizzato dalla sparatoria sulla sinistra; tutti si precipitano sulla scarpata destra dove naturalmente le slitte si rovesciano, per mettere l’argine a protezione.

Con Colturi prendiamo, lui i cavalli, io il mulo di testa alla destra, con il moschetto pronto, dobbiamo passare ad ogni costo per non perdere le preziose slitte: ordiniamo di serrare sotto e di seguirci: sparano, non si vede nessuno, i russi sono ben nascosti nel terreno cespuglioso e dietro muretti di neve; non abbiamo bombe a mano per difenderci e nella confusione nessuno pensa più ad un’azione logica: è una massa sbandata e disorganizzata senza più armi.
Prendiamo d’infilata il ponte, poi appena passati si può scendere agevolmente sulla destra; passiamo incolumi; a Colturi dico, appena giù: “Adesso per spararci devono muoversi, salire sull’argine; quando ne scorgo uno lo inzucco”; e invece mi accorgo che le frasche sopra le nostre teste cadono come falciate dalla sparatoria sono infernali, non se ne scorge uno!

Procediamo guardinghi, per timore che la slitta s’impianti contro qualche cespuglio, girando per il terreno paludoso finché ci arrampichiamo di nuovo verso la strada sempre seguiti dagli altri; ritrovo prima Gianasso e poi Matteis; arriva l’attendente di Colturi annunciando che uno dei mensieri è stato ferito ad un braccio e l’ha affidato ad un capitano su una slitta lo ritroveremo alla sera. Incontriamo sempre più numerosi cadaveri di russi, specie dietro a muretti di neve, e purtroppo anche di alpini.
Più avanti ci si ferma: c’è uno sbarramento di carabinieri armati per impedire alla massa degli sbandati di disturbare; cercano a viva voce il Val Chiese che deve andare all’assalto, ma non può arrivare per la massa che fa muro, per la confusione enorme; devono anche sparare in aria per farsi strada. Diciamo che siamo del Ceva e che vogliamo andare a combattere anche noi; passiamo ma dopo qualche chilometro troviamo un secondo sbarramento, e quando sentono che siamo del Ceva non vorrebbero lasciarci passare; mi faccio riconoscere, capisco che la situazione dev’essere particolarmente preoccupante e difficile, qualcosa faremo, anche se siamo pochi i combattenti rispetto alla massa di feriti; ci lasciano andare e così capitiamo nel mezzo della mischia.
Siamo proprio davanti a Nikolajewka, arrivano moltissimi colpi di mortaio e di artiglieria, anche i nostri rispondono; c’è un momento di sosta, avanzano due semoventi, un carro blindato e un 88, seguiti da quattro NW 150; li seguiamo subito a contatto; infatti cominciano a sparare e subito la massa dei nostri con un urlo avanza, accolta da un formidabile tiro di mortai; ci buttiamo sulla sinistra sparpagliandoci. Arrivano aeroplani tedeschi che lanciano munizioni e viveri con i paracadute: troviamo solo carta che avvolgeva cioccolata speciale.

Appena finito il lancio, piombano due Rata, che buttano malamente due bombe, poi tornano mitragliandoci, ma prendendoci di fianco, con poco danno, forse perché disturbati dalla contraerea tedesca. Ci schiacciamo sulla neve, sperando di non essere colpiti; vedo le fiamme uscire dalle mitragliatrici, e sotto la pancia di un mulo mi sento proprio nulla. Passano; solo un alpino è lievemente ferito da una scheggia, con uno strappo ai pantaloni, erano cartucce dirompenti.
Il tiro dei russi si affievolisce e noi ci si muove più speditamente, quasi di corsa scendiamo alla ferrovia, l’attraversiamo e risaliamo velocemente la sponda opposta che è già sera; il toccare le rotaie ci da una specie di coraggio e di speranza, quasi fosse la salvezza. Cerco un’isba; ne trovo una affollata di tedeschi, dove si trova un capitano della Divisione Vicenza e il sergente Schieppati di Milano, sciatore del Monte Cervino, che era con me al Battaglione Tartaro nel ’40; caccio via i tedeschi, dicendo che loro hanno già altra zona di raduno, e poi mi abbraccio con il sergente su un divano, addormentandoci di colpo. Siamo fuori? Dentro? Non lo so. Solo dopo due giorni vedremo il primo villaggio con i camini che fumano e carri armati tedeschi con il cannone rivolto verso di noi: siamo fuori anche se in terra di nessuno, ma salvi: finalmente!

Sergente Giacomo Alberti
Battaglione Pieve di Teco, 1^ Reggimento Alpini
Durante la campagna di Russia facevo parte della seconda compagnia del Battaglione Pieve di Teco. Sul Don, la sera del 17 gennaio 1943 il nostro battaglione ricevette l’ordine di ripiegare, ed al mio plotone, comandato dal tenente Francesco Bruzzone, fu affidato il compito di far da copertura.
Alle 2 del mattino seguente (18 gennaio), come ci era stato ordinato, lasciammo la nostra postazione, per ricollegarci con il nostro battaglione. Subito ci rendemmo conto che la situazione era assai preoccupante. Lungo la pista di Popowka trovammo materiale, vettovaglie ed anche armi abbandonate; incontrammo incessantemente soldati che ripiegavano, mentre aerei sorvolavano continuamente la zona in lontananza, si sentivano rumoreggiare i cannoni.
Alcuni uomini della mia squadra, per il freddo, per la stanchezza ed anche impressionati dalla gravità degli avvenimenti, davano segni di scoraggiamento e dovetti incitarli non poco a tener duro. Purtroppo, giunti a Popowka non riuscimmo a trovare il nostro battaglione, che si era allontanato già da qualche ora verso un’altra direzione. Ci presentammo allora al comando di reggimento ed il colonnello Manfredi diede disposizioni affinché fossimo aggregati al Battaglione Ceva.

La nostra faticosa marcia proseguì ed il giorno 20 gennaio, verso le 5 del mattino, con la compagnia comando di questo battaglione, ci trovammo a combattere contro un agguerrito caposaldo russo a Nowo Postojalowka. In questa località dovevano aver avuto luogo già altre aspre battaglie, come era testimoniato dai morti e dal materiale bellico disseminati sulla neve.
Le compagnie del Ceva andarono all’attacco, una dopo l’altra, ma non riuscivano ad espugnare il caposaldo nemico, forte anche di carri armati pesanti. Ad un certo punto, tutte le compagnie del battaglione, già fortemente decimate, al comando del maggiore Avenanti, andarono simultaneamente all’attacco ed egli cadde a pochi passi da me, mentre al grido di “Viva l’Italia”, in piedi, incitava i suoi uomini. L’incalzare dei carri armati russi, che si facevano sempre più minacciosi, ci impedì di portargli un qualsiasi soccorso.

Da quel momento, non vidi neppure più il mio tenente che, fino ad allora, non cedendo mai allo scoraggiamento, trascinandosi carponi tra morti e residuati bellici, sotto una gragnuola di colpi, con il suo eroico esempio, aveva esortato tutti noi del I plotone ad andare avanti. Nel punto in cui egli si trovava con alcuni uomini era passato un carro armato e non riuscii a vedere se era stato fatto prigioniero o ucciso. Era ormai il pomeriggio di quel tragico 20 gennaio.
In pochi superstiti, ci ritirammo in mezzo alle case, dov’era piazzata l’artiglieria alpina e dove si trovavano anche gli ufficiali del comando di reggimento. I feriti, sistemati alla meglio su delle coperte erano numerosissimi. Del mio plotone, di cui, ormai, ero il solo responsabile, erano rimasti soltanto cinque alpini (Sonaglio, Marrone, Balbi, Crudi e D’Emilio) ed uno sciatore di cui non ricordo il nome. Dagli ufficiali del Ceva, ai quali mi ero rivolto, appresi che bisognava lasciare la zona, evitando di passare nel punto occupato dai russi.

Questo significava dover abbandonare anche il poco materiale di cui eravamo ancora in possesso, perché, per evitare il nemico, era necessario camminare su terreni scoscesi ed impervii, fuori dalle strade normali. Anche i feriti, con alcuni medici che si erano offerti volontari, furono lasciati in quel villaggio, perché era impossibile portarli con noi. Ci incamminammo quindi, guidati dal colonnello Manfredi, in un canalone, che si trovava sulla destra dello schieramento nemico e, con l’aiuto delle tenebre, riuscimmo ad evitarlo.
Sul far del mattino, un altro caposaldo russo ci impedì la marcia: si trattava, però, fortunatamente, di forze prive di mezzi corazzati e, in poche ore di combattimento, con le sole armi dei fucilieri, costringemmo il nemico ad abbandonare l’altura che occupava e proseguimmo il nostro cammino fino a notte. Giungemmo quindi in un bosco, nel quale ci fermammo a riposare qualche ora; tra gli alberi, sotto la neve, trovammo del fieno che ci serve per improvvisare dei giacigli, ma il freddo terribile impedisce di sostare a lungo e, dopo poche ore, riprendemmo il cammino.

A mezzogiorno circa, incontrammo un paese che, a prima vista ci parve disabitato e ci inoltrammo nelle case, in cerca di cibo e di riparo dal gelo. Fummo però subito sorpresi dall’arrivo di numerosi carri armati, sbucati improvvisamente per le strade, che cominciarono immediatamente a sparare su di noi, cercando anche di investire i gruppi di soldati. Non fu possibile organizzare una resistenza: diedi perciò ordine ai miei uomini di disperdersi, per non offrire un facile bersaglio al nemico. Purtroppo, non potemmo più ricongiungerci, perché ognuno prese una diversa direzione ed ignoro anche quanti se ne salvarono.
Io mi ritrovai con due soli uomini del mio plotone: Balbi e D’Emilio e con alcuni alpini di altri reparti, e con questi proseguii il cammino. La nostra marcia, sempre più difficile ed estenuante, continuò, ormai, eravamo esausti e scoraggiati: il freddo, la stanchezza, la fame, i numerosi combattimenti con i russi ci avevano completamente sfiniti. Finalmente, giungemmo in un paese nel quale si trovavano dei reparti della Divisione Tridentina e con loro ci fermammo qualche ora. Ben presto, però, questi ripresero il cammino e noi, anche sé stremati, ci unimmo a loro, un po’ rincuorati per aver incontrato dei reparti ancora abbastanza organizzati.

In testa alla colonna marciava un’autoblindo e si capiva che su di essa viaggiava il comandante, perché un piccolo aereo venne a portare ordini e notizie posandosi sulla neve e ripartendo subito dopo. Alla sera di quello stesso giorno ci fermammo in un villaggio e, dopo molto tempo, anche noi potemmo riposare in una casa. La fame si faceva sempre più insopportabile, ancora una volta dovemmo accontentarci di carne di mulo cruda. Durante il giorno successivo fummo attaccati diverse volte, ma gli alpini della Tridentina erano ancora in grado di difendersi ed anche di contrattaccare e riuscirono sempre a mettere in fuga i russi.
Il giorno seguente incontrammo una resistenza ben più forte, il nemico presidiava un grosso paese e disponeva di molti uomini, mezzi corazzati, katiusce e armi automatiche. L’urto tra la nostra colonna e il caposaldo russo fu tremendo; tutti combattevano strenuamente, mentre io, stremato dai disagi sofferti, senza uomini e senza armi, dovetti limitarmi ad assistere, impotente, all’aspra battaglia che si svolgeva intorno a me, disperandomi di non poter portare anch’io un valido contributo. Riuscimmo, infine, a superare anche quella che era sembrata una barriera insormontabile.

Seppi poi, quando, molto più tardi, si cominciò a cercare di riordinare le idee ed a collegare i ricordi dell’uno e dell’altro, che doveva trattarsi della battaglia di Nikolajewka, ossia dell’ultima vera battaglia di sfondamento. Usciti da quell’ultima battaglia, io e molti altri, dopo aver camminato per alcune ore, non ci sentimmo più la forza di proseguire: ci fermammo quindi vicino a dei pagliai, ai quali appiccammo il fuoco per riscaldarci. Quando le fiamme si spensero ed il calore scomparve, fummo costretti a rimetterci in cammino, e mi accorsi di avere i piedi congelati.
Ero talmente sfinito che avrei rinunciato a partire, ma i miei due uomini che fino ad allora avevo protetto ed incoraggiato, mi costrinsero a continuare la sempre più faticosa marcia. Dopo ore di lento cammino, all’alba del giorno successivo, incontrammo un paese nel quale si trovavano degli alpini del Pieve di Teco. Erano del reparto salmerie ed avevano ancora delle slitte attaccate a muli, sulle quali trasportavano qualche ferito ed un po’ di viveri. Anch’io venni caricato su una di esse.

Vittorio Carbonetto
3′ Compagnia, Battaglione Pieve di Teco
Un piccolo reparto del Battaglione Pieve di Teco del 1^ Alpini ebbe a Popowka il suo destino segnato. Nelle prime ore di quel gelido pomeriggio, mentre l’immensa colonna umana si muoveva verso occidente ignara di andare incontro al lungo calvario della sanguinosa, ritirata, il I Plotone della 3^ Compagnia fu fermato da un ordine del comandante il battaglione, l’allora maggiore Carmelo Catanoso. La prima squadra di questo plotone fu mandata un paio di chilometri sul fianco della colonna per cercare di eliminare un centro di fuoco nemico che disturbava il movimento della colonna mietendo vittime.
Quei dodici segaligni liguri, aiutati anche da un po’ di fortuna riuscirono nell’intento e fedeli alla consegna non si mossero dalla balka conquistata fino a quando, a sera inoltrata, uno sciatore della Tridentina portò l’ordine di rientrare nella colonna e risalirla per mettersi a disposizione del comando di divisione.
Con gran fatica, “pistando” in mezzo ai vari reparti ciò fu fatto con la speranza anche di potersi riunire al proprio battaglione, ma purtroppo questo non avvenne mai poiché la ventura aveva avviato il Pieve di Teco su un altro itinerario: nel tremendo scontro a Waluiki contro preponderanti forze nemiche fu quasi totalmente distrutto dieci giorni dopo, e in quella località scrisse una delle più leggendarie pagine di valore.

Questo piccolo gruppo di liguri partecipò con oscura modestia ma con fermezza a tutti i combattimenti che la Divisione Tridentina sostenne nel lungo ripiegamento fino a Nikolajewka, stringendo denti e cinghia, imprecando e moccolando e con gran sofferenza come fecero tutti gli alpini che il destino inviò sul fronte russo. Combatterono con disciplina, seppellirono come poterono i loro morti e si portarono dietro i loro feriti fino in patria. La loro natura, il loro modo di pensare e di agire, il loro comportamento, unito alle tradizioni della loro terra furono gli elementi che cementarono questi uomini che mai si tirarono indietro e fecero con freddezza il proprio dovere senza discutere, mugugnando magari, e rimasero uniti sempre in ogni circostanza.
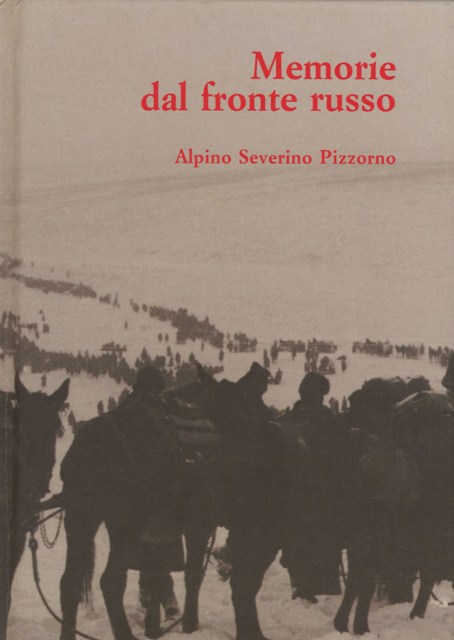
Mai fu necessario intervenire per disporre turni di guardia, mai fu necessario alzare la voce durante i combattimenti; un ordine preciso, uno sguardo negli occhi e il pensiero della loro baita nell’aspra terra di Liguria faceva di quei pochi alpini un’unica cosa; qualunque cibaria racimolata qua e là fu sempre egualmente divisa fra tutti; un intercalare dialettale faceto metteva un mesto sorriso su quei volti maschi e macilenti.
Pare impossibile come le qualità liguri possano esprimersi nei momenti più delicati della vita: con vigile tranquillità ognuno si assunse il compito più consono al proprio carattere: chi impartiva ordini, chi procurava munizioni o quel poco da mettere sotto i denti per placare i morsi della fame e chi si dedicava, nei momenti possibili, ai feriti curandoli con quel niente che si aveva, ma sempre rincuorandoli.

Si arrivò così alla famosa giornata che passò alla storia come la battaglia di Nikolajewka. Quel giorno il freddo attanagliava i corpi ormai esausti e lo spirito; quei poveri alpini non sapevano nulla di quanto avveniva, si trovavano al lato sinistro dello schieramento e seguivano con palese tensione ciò che succedeva nella parte centrale, fermi nella neve a ridosso della loro unica slitta che portava le ultime e poche munizioni e i feriti. Ancora oggi ricordano quei momenti di attesa e nei loro sguardi riappare quell’immenso carnaio di vivi e di morti e si chiedono come siano riusciti a non essere annientati dal ferro, dal fuoco, dal gelo e dalle privazioni.
Dopo varie fasi di lotta il combattimento investì anche il loro settore: un segno di croce, un pensiero ai propri cari e la speranza che la mano divina fosse su loro, poi si buttarono nella mischia per tutta la durata dell’impari lotta assieme agli altri alpini della Tridentina. A sera dopo il vittorioso combattimento, si riunirono nel tiepido calore di una isba della cittadina conquistata e guardandosi con apprensione pensarono ai camerati del Pieve di Teco, liguri come loro, sperando che quel turbine di distruzione non avesse toccato il loro bel battaglione: fu il contrario.

Ancora oggi quei pochi del Pieve che sopravvissero alla campagna di Russia, nei loro incontri annuali ricordano sempre con tanto fraterno amore i loro commilitoni scomparsi nelle gelide pianure russe che non alzarono mai le mani in segno di resa ma solo per salutare i loro caduti; e con orgoglio dicono: “Anche il Pieve di Teco era presente a Nikolajewka”.
Sottotenente veterinario Armando Fronzaroli
Battaglione Pieve di Teco, 1^ Reggimento Alpini
Io ero sottotenente veterinario del Battaglione Pieve di Teco comandato dal maggiore Carmelo Catanoso. Il battaglione era in linea sul Don quando giunse l’ordine di ripiegamento; dopo una freddissima notte di marcia giungemmo al luogo di concentramento dell’intero Corpo d’Armata Alpino. Anche se immaginavamo che la ritirata non sarebbe stata facile, tuttavia nessuno di noi aveva la precisa sensazione di ciò che ci avrebbe atteso.

Infatti una sera, dopo aver lasciato la località chiamata, se non erro, Malakijewa, c’incamminammo verso un’ampia radura sita tra due foreste; quando la colonna si fu addentrata lungo il pianoro, nutrite scariche di mitragliatrici la investirono provenendo dalle zone alberate: ci fu una reazione da parte degli alpini, ma anche un avanzamento più svelto della colonna stessa verso due strade che si aprivano al limite delle foreste; io ed alcune mie slitte delle salmerie prendemmo la strada di destra (logicamente, perché ci trovavamo sul limite destro della colonna), mentre il grosso e pressoché tutta la Divisione Cuneense s’avviarono invece per la strada di sinistra che li condusse poi a Waluiki ed alla prigionia.
Camminammo tutta la notte ed al mattino invano cercammo i nostri commilitoni; avevamo perduto il Pieve di Teco e non l’avremmo più ritrovato. Adesso, insieme con noi, erano in maggioranza uomini della Tridentina, della Julia, della Vicenza, della stessa Cuneense, nonché tedeschi, ungheresi, rumeni. In un’isba ci riunimmo e fraternizzammo con alcuni ufficiali e soldati della Tridentina, un piccolo reparto di salmerie comandato da un ufficiale biondo, barbuto, di media età, dal fisico robusto: il capitano Rossi.

Egli acconsentì volentieri a che ci unissimo al gruppo; parlando con accento bresciano ci disse che anche lui aveva perduto il contatto col comando di battaglione, ed era contento di accoglierci in quanto uniti avremmo avuto più probabilità di cavarcela. Così restammo insieme nei giorni seguenti cercando di risparmiare il più possibile le vettovaglie e di procurarcene nei villaggi che attraversavamo, cosa questa ogni giorno più difficile.
Alcuni che erano insieme al capitano Rossi (non ricordo il suo nome di battesimo) subito mi fecero intendere di stimare poco il loro superiore: lo consideravano pressoché una nullità, un antipatico e noioso egoista che si lagnava continuamente di tutto, e aveva un esagerato timore di perdere la pelle.
Neppure dagli alpini era troppo ben visto: lo avevano ironicamente soprannominato “Garibaldi” ed accennavano a lui sempre e soltanto con questo soprannome; e invero, la barba bionda e folta, il naso dritto, la figura stessa della persona, era facilmente accostabile alla caricatura dell’eroe dei due mondi. Nei primi giorni della ritirata c’era ancora una parvenza di distinzione gerarchica fra i gradi militari, che di giorno in giorno rapidamente calò. Pur tuttavia, il capitano Rossi, fosse per la sua presuntuosaggine o forse perché una volta era stato anche temuto, conservò una certa parvenza del grado, e nessuno del gruppo si prese mai con lui eccessiva confidenza.

Invece ebbi la conferma che lui sapeva di non essere ben visto quando una volta mi avvicinò e, dopo avermi lungamente parlato della famiglia e dei bambini, mi manifestò apertamente il suo dispiacere per non essere riuscito a farsi amare dal reparto. Ricordo che sentii per lui una certa pena; pensai che infine non era colpa sua se per natura era di carattere antipatico.
La sera prima della battaglia di Nikolajewka eravamo sfiniti, senza cibo, ormai completamente demoralizzati; a stento trovammo asilo in un’isba semidiroccata: legati i muli intirizziti anch’essi allo stremo delle forze, ci sdraiammo tra coperte luride e indurite dal gelo, gli uni addossati agli altri, tra le grida represse dei congelati.
Giunse l’alba e ci cominciammo a preparare per un altro giorno di marcia. Il vento continuava a soffiare fastidioso e implacabile come la sera precedente; il capitano Rossi si mosse in silenzio con gli altri, ormai proprio uguale agli altri, senza prosopopea ed anche senza più lagnarsi. Ci imbrancammo con la colonna già in movimento; andavamo avanti, l’uno dopo l’altro, affondando gli arti nella neve con fatica smisurata. Ma a un tratto la colonna si fermò.

Era capitato altre volte, ma non così improvvisamente. A poco a poco gli uomini si affiancarono, si ammassarono, disponendosi a raggera sulla sommità di un largo pendio che digradava verso un grande centro abitato. Mentre tutt’attorno venivano raggruppandosi i componenti della colonna in ritirata, poco lontano esplodevano i proiettili nemici e dalla città si udivano gli spari della battaglia già ingaggiata da tempo.
Tutti restammo fermi in attesa dello sviluppo del combattimento e intanto cominciarono a giungere le prime notizie: eravamo davanti a Nikolajewka, il presidio russo doveva essere molto consistente, tentativi di sfondamento degli alpini erano fino allora falliti, presto sarebbe disceso un reparto tedesco e forse tutto si sarebbe risolto.
Ma cominciarono a trascorrere le ore e nulla di nuovo accadeva mentre la forzata immobilità acuiva su di noi i morsi del gelo. A un certo punto giunse la notizia che i tedeschi si rifiutavano di attaccare; la situazione si faceva di momento in momento sempre più grave, il sole stava declinando, e si profilava il terribile spettro di una notte all’addiaccio. A un tratto tutto lo schieramento fu percorso come da un vocio confuso che stava ripetendo un consiglio, un’esortazione: bisogna scendere a basso tutti insieme… è meglio morire combattendo che morire di freddo…

Era come un brusio, un vai e vieni di voci confuse ed alterate. Ma poi tutto si attenuò, scomparve; lo scoramento sembrò aver avuto il sopravvento: nessuno osava, nessuno si azzardava a muoversi. Ma ecco a un tratto farsi avanti un uomo, un uomo dalla bionda barba ghiacciata; prende la cavezza del primo mulo e comincia decisamente a scendere verso valle.
Subito, seguendone l’esempio, noi della folla cenciosa ci riversiamo giù per la balka, ed era chiaro che ormai niente e nessuno avrebbe potuto fermarci, nemmeno le bombe che ci esplodevano intorno. Anche noi seguimmo il nostro capitano, guardandone come ipnotizzati il bel volto eretto. E poi avvenne il miracolo: i pezzi russi cessarono di sparare. Ci sembrò addirittura di scorgere i russi fuggire tra le sempre più vicine isbe di Nikolajewka, e ci apprestammo a piombare sulla città come falchi affamati, spinti da una forza sovrumana donataci dall’esempio del capitano Rossi, che mai avremmo creduto capace di tanto.

No, non fu il capitano Rossi a conquistare Nikolajewka; la città fu presa metro per metro dagli sparuti ma valorosi reparti alpini che per l’intera giornata combatterono e morirono tra le sue tragiche isbe; ma per noi, per noi delle salmerie sbandate, il principale conquistatore di Nikolajewka fu proprio lui, il capitano Rossi detto Garibaldi.


