a cura di Cornelio Galas
Fonte: “Nikolajewka: c’ero anch’io”. Giulio Bedeschi. Testimonianze fra cronaca e storia
Artigliere alpino Giuseppe Fachin
14ª Batteria, Gruppo Conegliano, 3^ Reggimento Artiglieria Alpina
Nelle prime ore del 26 gennaio era ancora buio; fui svegliato di soprassalto da scoppi vicinissimi di granata e colpi di mitragliatore. Compresi subito che i russi erano piombati nel paese cogliendoci nel sonno. Urli, bestemmie rabbiose si mescolavano con le; invocazioni dei feriti e dei moribondi. Ci chiamavamo fra conoscenti e compagni per unirci e ripartire insieme in direzione della grossa colonna già in marcia. Perdemmo parecchio tempo a ritrovarci, molti erano morti; i russi, frattanto, erano fuggiti, forse attaccati da qualche nostro reparto.

Appena chiaro scorgiamo la colonna che arranca faticosamente sulla ripida salita di fronte e sulla quale cadono fitte le granate dei mortai russi. Si vedevano chiaramente saltare per aria a decine soldati, quadrupedi e slitte. Vedendo questo decidemmo di non seguire quella strada, ma di prendere una pista secondaria a destra, ai piedi della stessa collina. Durante il percorso in mezzo a tanti altri riconobbi un mio compaesano ferito sulla neve che invocava aiuto; il suo nome è Gino Taddio della 13ª Batteria.
Pregai allora un artigliere della 15ª Batteria che, passava di lì in quel momento con una slitta carica di feriti e congelati di fargli un po’”di posto anche per lui e portarlo almeno fino al prossimo villaggio di Nikolajewka. Povero Gino, gli mancava completamente una natica asportatagli da una granata ed al cui posto era appiccicato un blocco di sangue e neve ghiacciata.
Caporale Franco Chiaruttini
14ª Batteria, Gruppo Conegliano, 3^ Reggimento Artiglieria Alpina
Raggiunsi i miei compagni dopo tre giorni; avevo perso il contatto con loro nelle ultime case di un paese. Sfinito, affamato e tanto sonno, avevo cercato cibo e riparo in una di quelle buche fatte nel terreno ove i contadini mettevano patate ed altro a riparo dal gelo; dopo aver mangiato qualche barbabietola cruda mi ero addormentato e sarei rimasto lì, chissà quanto tempo, se una ragazzina (non la dimenticherò mai) che per qualche suo motivo era scesa in questo rifugio, non mi avesse svegliato.
Salii la scaletta e appena all’aperto mi resi conto che la situazione era disperata; vidi qua e là soldati finiti e congelati che non potevano camminare, con le mani alzate, si arrendevano ai partigiani. Carri armati sovietici sparavano e rastrellavano la zona. Correndo riuscii a riparare dietro un covone di paglia; vedevo in lontananza la colonna, come una striscia nera; dovevo raggiungerla a tutti i costi, solo agganciandomi a loro avevo la possibilità di ritornare.

Attesi non so quanto tempo e appena potei mi addentrai in un bosco poco distante, senza perdere l’orientamento aspettai il buio, ripartii col passo più lesto che potevo. Dopo ore di estenuante cammino cominciai a trovare qualche gruppetto, i più stanchi, poi altri ancora, li superai con la volontà di non rimanere fra gli ultimi.
La mattina presto, forse le ore due, del 26 gennaio sentii fuori di un’isba ove avevo trovato riparo per la notte, delle voci che conoscevo, uscii e ritrovai alcuni miei compagni che si scaldavano attorno ad un fuoco, mi aggregai a loro, partimmo, inghiottiti dalla lunga colonna che procedeva verso occidente. Eravamo in sei con una slitta. Giungemmo sull’altura di fronte a Nikolajewka verso le dieci del mattino, la battaglia infuriava; correva voce che fosse l’ultima che al di là del paese si sarebbe usciti dalla sacca.
Animati dalla volontà di finire questo calvario, tutti nella misura delle proprie possibilità abbiamo cercato di contribuire allo sfondamento e all’occupazione del paese. Vidi un soldato romeno seduto sulla neve, aveva perso le gambe, rideva e agitando il copricapo salutava chi gli passava accanto; era sicuramente impazzito. Gli apparecchi mitragliavano a bassa quota. Scesi il pendio e assieme agli altri amici ci portammo a ridosso del terrapieno della ferrovia quando una raffica di mitraglia ci colse in pieno; due miei compagni morirono, uno si mise a correre (non lo rividi mai più) uno rimase gravemente ferito ad una coscia e un piede; con l’aiuto dell’amico Felice lo caricai sulla slitta cercando di medicarlo, il sangue non colava, era gelato. (Morì la sera stessa in un’isba al caldo, dissanguato.)

La sera in un capannone di Nikolajewka trovai del lardo e una cassa piena di scatolette di carne che caricai in spalla pensando che per un po’ non avrei sofferto la fame; appena fuori, fui assalito da quattro soldati tedeschi, volevano portarmi via la cassa, ingaggio una lotta col calcio del moschetto e col sopraggiungere di alcuni italiani in mio aiuto ebbi ragione di loro e così ci dividemmo le scatolette. Dure giornate attendevano ancora.
La volontà di sopravvivere, il pensiero dei cari che attendevano al paese, il frico (formaggio cotto) e la buona polenta carnica erano come iniezioni stimolanti per non cedere allo sconforto e allo sfinimento ma continuare a lottare per poter un giorno testimoniare che coloro che non sono tornati devono essere scritti a caratteri d’oro nell’albo degli eroi.
Artigliere alpino Giovanni Bergagnini
14ª Batteria, Gruppo Conegliano, 3^ Reggimento Artiglieria Alpina
Frammisto al grosso della colonna avevo da poco raggiunto il pianoro antistante Nikolajewka allorquando come una valanga ci piombò addosso la massa di quelli che ci precedevano, creando un indescrivibile: le nostre truppe erano state attaccate e costrette a indietreggiare, sembrava che ormai tutto era perduto, era la nostra fine. Questa situazione aveva creato un tale scompiglio che molti cadevano travolti e calpestati. Poi le cose si calmarono, con il ritorno di nuova speranza.
Erano circa le ore 13 ed i combattimenti infuriavano alle porte della città, un concitato susseguirsi di voci “avanti il Tiràno, avanti il Morbegno, avanti l’Edolo, avanti il Val Chiese, avanti il Val Camonica”. Il pianoro ora conteneva tutta la colonna di quadrupedi, slitte e soldati italiani, tedeschi, romeni e soprattutto ungheresi provenienti da Woronesch; in totale ritengo non meno di quarantamila uomini sostavano sulla neve accasciati, moribondi di fame e di stanchezza in attesa di poter continuare ad andare avanti.

In questo deserto privo di ogni appiglio o riparo compare all’orizzonte un aeroplano, poi un altro e poi un altro ancora diretti verso di noi aprendomi il cuore alla più grande speranza. Ma quale delusione allorquando questi apparecchi si furono rivelati russi anziché tedeschi come noi speravamo; appena sopra di noi si abbassarono fino a 30-40 metri iniziando un fitto spezzonamento e mitragliamento.
In questo momento io mi trovavo quasi fra i primi e poco distante dal crinale prospiciente a Nikolajewka che intravvedevo avvolta dagli incendi e dagli scoppi della battaglia in corso, alla mia destra a non più di cinquanta metri stavano un gruppo di soldati tedeschi che sparavano sulla città con una katiuscia e due pezzi, mentre i nostri 75/13 erano un po’ più a destra. Più vicino a me stavano invece due carri tedeschi su uno dei quali era il comandante della Tridentina, generale Reverberi, che si affannava a farsi intendere con molti gesti poiché era quasi ridotto senza più voce.
Intanto la squadriglia di aeroplani compiuto il massacro stava allontanandosi e già tiravamo un sospiro di sollievo vedendoci ancora in vita e scampata anche stavolta, quando comparve lontana una nuova squadriglia che arrivata sopra di noi compiva la stessa funzione della precedente e così per altre tre o quattro volte ancora. Ricordo intensamente quell’allucinante visione ove decine e decine di pezzi di corpi umani volare per l’aria e gli urli laceranti di dolore e di invocazione di aiuto, cercavo di non vedere né di sentire, stretto abbracciato con un mio compagno vicino cercando di nascondere la testa sotto la slitta per avere più coraggio a morire insieme.

Alla terza ondata però anche lui mi abbandonava lasciandomi solo, urlo di dolore e poi le sue braccia rabbiosamente avvinghiate alla mia vita si rilassarono; era morto. Cercai con lo sguardo qualche volto amico o conosciuto ma vidi soltanto Cesarino Dal Monte, ma non il mio quasi compaesano pino Vittorio Della Schiava appena intravisto il giorno prima. Ora il sole stava rapidamente calando verso l’orizzonte e la battaglia non accennava a risolversi, il freddo aveva cominciato a aumentare e dover trascorrere la imminente notte su questo pianoro senza alcun riparo voleva dire la morte per tutti, il solo sfiorare ora questo ricordo fa gelare l’anima.
Stavo morendo di fame, con il dolore degli organi in via di congelamento, della colite che mi straziava gli intestini; mi sentivo impazzire, quando il mio sguardo sfuocato si posò nuovamente su quei due carri tedeschi visti in precedenza. Su uno di essi rividi lo stesso generale Reverberi che gesticolava rabbiosamente senza voce con il braccio teso segnare Nikolajewka compresi che c’era nell’aria qualcosa di nuovo: “Tridentina avanti” era quell’ordine, e il resto di questa generosa divisione obbedì e andò; e con essa io pure avviluppato, risucchiato fui scaraventato nel cuore della battaglia; da questo momento la mia mente si ottenebrò e non mi rimane che una svanita visione del momento del passaggio della ferrovia.

Mi rivedo soltanto a notte avanzata verso le 22 in una squallida isba dell’abitato, mancante di tetto, di finestre e porte, in angolo completamente solo, i miei compagni tutti periti o sperduti Così mi rivedo nell’angolo a sinistra della porta d’entrata accanto un tenue fuocherello che alimentavo con manciate di paglia sparpagliate sul pavimento e fra le mani un provvidenziale coperchio di gavetta sciogliere la neve per lenire la tremenda sete che mi
arde in corpo e nella bocca sanguinante per il continuato succhiamento di ghiaccioli e di neve per calmare la fame.
Non cerco cibo, sarebbe impossibile e poi i miei piedi più doloranti che mai non mi permettevano di muovermi. Man mano che la neve diventa acqua bevo avidamente e mi sembra di rivivere, aggiungo ancora neve e bevo ancora e mi sembra non saziarmi mai, la terribile dissenteria che la colite mi produce, mi crea insopportabili dolori e mi sento bruciare l’intestino; così bevo, riempio di neve e poi bevo ancora e così senza chiudere occhi fino all’alba mi rivedo così rannicchiato solo in quell’angolo quella notte a 40^ sottozero, ma almeno riparato dal vento che sibilava come l’ululato dei lupi.

Percepisco ora dei flebili lamenti provenire da una stanza accanto; la mia ridotta sensibilità non vi fece caso tanto era cosa comune e poi la somma dei miei dolori era tale da togliermi ogni possibilità di ragionare e poter rivolgere la minima attenzione al mio simile. Solo in sèguito nel cuore della notte illuminata dall’incendio di un’isba accanto potei vedere in quella stanza una cosa orribile che mi procurò un certo sgomento; su di un giaciglio a tipo dormitorio di boscaioli stavano allineati seminudi, irriconoscibili, gonfiati dal gelo, sette o otto alpini con la baionetta conficcata nel petto e nel ventre.
Due di essi ancora in vita, rantolando con un filo di voce in dialetto friulano e carnico, afferrai e percepii così: Ah saludait la me mame (salutate mia mamma), Ah iudaimi (ah, aiutatemi). Non potei mai sapere il loro nome né il loro paese d’origine, forse della mia Carnia e del mio stesso comune; seppi soltanto poi che erano stati catturati dai russi i quali prima di dover abbandonare la città li avevano finiti così.
Sottotenente Gino Panerai
Reparto Munizioni e Viveri, Gruppo Conegliano, 3^ Reggimento Artiglieria
Alpina
Il 26 gennaio 1943 non ero a Nikolajewka, ma la conoscevo bene perché ci ero stato più volte e l’ultima ai primi di quello stesso mese. Dal novembre del ’42 ero di base a Nikitowka con 80 muli, 100 uomini (la mia Sezione del R. M.V. ed una sezione della 13ª, 14ª e 15ª Batteria del Conegliano), 4 autocarri del Battaglione Autieri di Waidelewka (tenente Jemma). Il nostro servizio consisteva nel requisire grano, valenki, slitte nei kolkhoz del Kreislandwirt (suddivisione in zone agricole fatta dai tedeschi) immagazzinando il tutto prima a Nikitowka per portarlo poi alla stazione di Nikolajewka.

Conoscevo perciò la zona da Romankowo ad est, ad Arnautowo e Nikolajewka a nordovest, dovendo visitare tutti i kolkhoz, fino a Waluiki a sudovest e Waidelewka a sud. Ricordo la strada per Nikolajewka, il terrapieno della ferrovia, il sottopassaggio che immetteva nella piazza sulla quale si affacciava un grande palazzo, adibito ad ospedale, ed un piccolo cimitero di alpini.
A Nikolajewka faceva allora lo stesso mio servizio con circa 40 uomini e 40 muli il sottotenente Serrini del Val Cismon, mentre il resto dello stesso reparto salmerie col suo comandante capitano Capello, era a Romankowo. Pochi uomini del 156º Battaglione mitraglieri della Divisione Vicenza vigilavano la stazione di Palatowka, sulla linea ferroviaria WaluikiNikolajewka.
A Nikitowka era il quartiere invernale del comando della divisione di cavalleria (generale Barbò) e del Reggimento Savoia cavalleria (colonnello Bettoni) mentre il Reggimento Lancieri Novara era a Nikolajewka. A Waluiki, grosso centro industriale ed universitario, nodo ferroviario importante con un comando tappa italiano, ero stato in dicembre. Si entrava in città da est per la strada che veniva da Waidelewka attraverso un sovrapassaggio sulla ferrovia, proprio ai margini della stazione.
Oltre la ferrovia, a sinistra sulla balka, parte della città con l’università, sulla destra, verso nord grandi fabbriche, mentre al centro, dopo le case, vi era una radura. La ferrovia da Waluiki a Livenka, a Nikolajewka, sempre terrapieno, costeggiava ad est una foresta che arrivava alle spalle di Nikitowka. Nella foresta c’era una segheria dove andavamo a requisire slitte e rudimentali ski, che avremmo dovuto poi far pervenire ai reparti sul Don. Si sentiva dire che ci fossero partigiani nella foresta, ma in realtà solo una sera, verso Natale, qualcuno era stato segnalato a Samarino, vicino a Nikitowka.

Questa la situazione a metà gennaio quando, mentre sul fronte il Corpo d’Armata Alpino si apprestava a lasciare le sue posizioni, il comando della divisione di cavalleria ricevette l’ordine di spostarsi a sud, verso Kupianski Il comando del R. M.V. del Conegliano (capitano Manzone) era a Podgornoje e là avevo mandato verso il 10 gennaio un caporal maggiore ed alcuni artiglieri a prendere ordini, ritirare la posta per noi, qualche indumento; erano ripartiti il 13.
Dalle lettere che i miei colleghi Cenni e Bonafini mi mandarono in tale occasione si accennava ad uno spostamento in vista, come ad un fatto normale nella nostra situazione di militari; erano sereni scherzosi e certo non prevedevano che stava per iniziare la tragedia della ritirata nella quale pochi giorni dopo avrebbero trovato eroica morte.
Questi miei uomini, fatta sosta il 14 sera a Rossosch, mentre stavano per ripartire all’alba del 15 furono sorpresi di vedere sulla strada carri armati russi, distrutti poi dagli alpini del comando del Corpo d’Armata Alpino e dagli Stukas; rientrarono nel pomeriggio a Nikitowka allarmati. A sèguito di questo fatto ed a conoscenza dello spostamento previsto per la cavalleria, mi feci ricevere dal generale Barbò affinché chiedesse disposizioni, via radio, ai comandi superiori per reparti come il mio, quelli del capitano Capello e di Serrini, reparti di salmerie quasi disarmati (avevamo una trentina di colpi ciascuno per il moschetto ’91).

La risposta fu: “Il Corpo d’Armata Alpino rimane sulle sue posizioni”. Il 16 mattino vedemmo perciò sfilare il Savoia Cavalleria con stendardo al vento in testa, colonnello comandante e squadroni come ad una parata in piazza d’armi. Il 16 sera arrivarono a Nikitowka con un pullman ufficiali del comando di Rossosch (diversi erano ufficiali superiori), da dove erano usciti dopo la seconda ondata di carri armati russi; tennero una concitata riunione, poi proseguirono nella notte stessa col loro mezzo per Waluiki e con loro il tenente Selvatico, ufficiale del comando distaccato a Nikitowka, per il coordinamento del nostro lavoro in zona. Noi dovevamo restare in attesa di ulteriori ordini.
Mandai ad avvisare a Romankowo il capitano Capello, che era all’oscuro di tutto, perché venisse con i suoi ad unirsi a noi; ci saremmo potuti difendere meglio. Il 17, non vedendo arrivare ordini, decidemmo di spostarci a Waluiki e di dare appuntamento là anche a Serrini da Nikolajewka, poiché speravamo di poter trovare qualche organizzazione nel centro maggiore. Il 17 a mezzogiorno eravamo a Waluiki. Soldati italiani sbandati arrivavano da est, resti delle divisioni di fanteria, servizi, nessuno del C. A.A.; incontrammo gli ufficiali del pullman che sempre più concitati ci ingiunsero di ritornare a Nikitowka in attesa di disposizioni.

Rifatta la strada indietro, fermai gli uomini ed i muli stanchi a Samarino per la notte ed all’alba del 18 col capitano Capello, fatta funzionare finalmente l’autocarretta degli alpini, che ci aveva seguito sempre trainata dal cavallo del capitano, eravamo di nuovo a Nikitowka, deserta; lungo la strada per Waluiki qualche soldato del C. A.A. con qualche mulo, isolati, autocarri italiani ancora pieni di indumenti invernali e tedeschi con benzina e materiale vario, abbandonati lungo il cammino. Non ci restava che ritornare a Waluiki ove arrivammo di nuovo la sera del 18.
I russi erano segnalati in arrivo dai tedeschi, venivano da da Waidelewka; il mattino del 19 entrarono nella stazione, avendo facilmente ragione del velo di resistenza che in pochi avevano cercato di opporre sul momento, individualmente, mentre stavamo trasferendoci oltre. Anche Serrini era arrivato da Nikolajewka in quel momento all’appuntamento in stazione con i suoi, senza incontrare russi o partigiani sul suo cammino.
Nella notte del 20 riuscimmo in pochi ad uscire dalla città abbandonata dai carri tedeschi dopo che avevano scambiato colpi di cannone per tutta la giornata con i russi, i quali rastrellavano la radura in cerca di italiani ed avevano occupato tutto il resto della città. Dirigendoci con la bussola ad ovest raggiungemmo il mattino la nuova posizione dei carri tedeschi.

L’uscita di Waluiki si è chiusa per il C. A.A. nella giornata 19 ed ha permesso ai russi di risalire a nord per cercare di chiudere l’altra uscita, quella di Nikolajewka. Viene da chiedersi: sarebbe successo se si fosse potuto organizzare una qualche difesa colle forze disponibili in zona. I reggimenti di cavalleria avevano combattuto valorosamente nell’agosto precedente ed erano uomini ben riposati, avvicendati, forti di una tradizione; noi del C. A.A. eravamo in tutto duecento.
Ai primi di gennaio il Savoia aveva fatto un’esercitazione contro un presunto attacco da est e sulla balka che limita Nikitowka, avevo mandato anch’io una pattuglia di formazione, qualche uomo anche con ski. Si sarebbe potuto alleggerire l’ultima fase della ritirata? Nikolajewka si sarebbe evitata? A Waluiki la Cuneense e gran parte della Julia non sarebbero cadute nella rete? La gloria degli alpini in Russia sarebbe stata pagata con meno sangue?
Tenente Angelo Damini
4^ Batteria, Gruppo Udine, 3^ Reggimento Artiglieria Alpina
Non mi si accuserà perché ricordo episodi di quella guerra che io e i miei soldati abbiamo combattuto da onesti italiani, perché chiamati al dovere con regolare cartolina precetto. Abbiamo obbedito perché non stava in noi criticare, decidere, volere la guerra. Nessuno ricorda i sacrifici dei combattenti di questa guerra quasi fosse delitto ricordarli; sarebbe delitto il mio se non li ricordassi e se non elevassi in questo momento un riconoscente pensiero ai gloriosi caduti dell’Albania e della Russia che sono morti convinti di morire per la loro patria.
Rientro nell’argomento. Ecco. Alle 5 del mattino torno al comando di reggimento dell’8^ Alpini e riferisco al colonnello Cimolino. Nella stessa notte, come aveva preveduto il colonnello, i russi hanno attaccato in forza nel settore della quota 172 “Cividale” ed erano stati respinti con perdite rilevanti da parte nostra. Il colonnello Cimolino non ha chiuso occhio nella notte, è preoccupato, vuole notizie degli altri settori. Anche lui prevede una catastrofe.

Mi attacco al telefono e chiedo al capitano Erigenti le novità della notte e degli altri settori. Le novità sono queste, alle ore 5 e mezzo del mattino del 16 gennaio 1943: nel settore tenuto dagli ungheresi immediatamente a sinistra della Divisione Tridentina – al di là dell’estremo sinistro del Corpo d’Armata Alpino – i russi hanno sferrato un attacco riuscendo ad ottenere una penetrazione nel settore ungherese di circa 6 km in profondità.
Il comunicato aggiunge che gli ungheresi stanno prendendo le misure del caso e che certamente nella mattinata elimineranno l’infiltrazione nemica. A questa notizia il colonnello Cimolino scatta ed esclama: “Misure o non misure, ed intanto i russi hanno sfondato e sono penetrati per 6 km. Anche nei settori sud si diceva così e poi l’avanzata nemica non è stata più arginata. Questa è la rovina del Corpo d’Armata Alpino. “Cerca di sapere qualche cosa di più, Damini, e tienimi informato. Non staccarti dal telefono, perché prevedo che di ora in ora la situazione avrà degli sviluppi.”
Alle sette del mattino stesso riesco ad avere questa notizia: Il contrattacco degli ungheresi è fallito, l’infiltrazione russa in quel settore si è approfondità. Non si sa se sia un errore, ma i 6 di due ore prima sono invece 60 km. E questo è il principio della fine. Il colonnello Cimolino non si sbagliava. Contemporaneamente arriva dal comando divisione l’ordine di ripiegare nell’oscurità della sera e di raggiungere nella notte Tarnowka. Gli ordini sono presto dati; la 12ª Compagnia del Tolmezzo deve rimanere in linea e ripiegare nel settore della Cuneense alle quattro del mattino. Il tenente Oglina è incaricato di seguire questa compagnia.

Ritiro i miei uomini dalla linea e da Golubaja Krinitza con un’auto carretta, facente parte di una lunga colonna, raggiungo Tarnowka. Il freddo è intenso, mi riparo in una isba e attendo. Lunghe colonne di slitte e di soldati stavano giungendo. Tutti sono compresi della situazione. Le colonne sono silenziose. Alle 10 di sera il maggiore Sangiorgio del comando divisione mette a disposizione una macchina e mi ordina di ritornare a Illuiscewoka, collegarmi col capitano Brigenti che si trovava nel bivio di quella località al di là di una grande palude fortemente ghiacciata ed attraverso la quale passavano le truppe, gli automezzi ed i cannoni della divisione.
Brigenti mi avrebbe detto cosa dovevo fare nella notte. Non discuto e parto. Dovevo reagire al sonno, al freddo e alla stanchezza. Colonne silenziose di uomini sono in ripiegamento. Trovo Brigenti che mi dice di rimanere con lui finché l’ultimo uomo della divisione fosse passato al di là della palude il cui ghiaccio sarebbe poi stato fatto saltare dai tedeschi che già avevano forato le cannette di esplosivo. A Illuiscewoka intanto i tedeschi stavano facendo saltare i depositi di munizioni collocati nelle isbe. La notte è sinistra, forti detonazioni, incendi di case, passaggio continuo di truppe.
Il periodo di ritirata che va dal giorno 19 gennaio al 1^ febbraio 1943 è difficile da descriversi, ognuno ha un romanzo da raccontare, coloro, quei pochi, della Julia che si sono salvati non si san render conto nemmeno oggi di come han fatto; ancor oggi è chiara visione di quelle giornate: morti, morti, feriti abbandonati sulla neve, villaggi che bruciano, carri armati, gemiti, invocazioni, migliaia di punti neri sulla bianca steppa, oggi migliaia di croci punteggiano idealmente quelle terre.

… Siamo a Popowka, il 18 gennaio. Confusione, notizie poco buone sulla situazione; attendiamo ordini del comando divisione che dovrebbe aver raggiunto Podgornoje, sede del comando divisionale della Tridentina e fors’anche del Corpo d’Armata Alpino. A sera giunge con un camion il tenente Merino del comando di divisione e ci porta l’itinerario del ripiegamento, pochi viveri e notizie disastrose. Alle 11 di sera il colonnello Cimolino tiene rapporto ai comandanti di reparto col tenente colonnello comandante Rossotto del Gruppo Conegliano del 3^ Artiglieria Alpina.
Gli ordini sono precisi: due o tre giorni al massimo di marcia, rompere una sola resistenza nemica e raggiungere i capisaldi tedeschi. Ci incoraggiamo e nella notte stessa ci disponiamo per la partenza. Alleggeriamo i nostri zaini di ogni cosa inutile e di ogni peso che non fosse viveri per 2 giornate e munizioni.
Lo stesso fanno i soldati, lo stesso facciamo con i materiali. Il gruppo d’artiglieria fa saltare due pezzi per ogni batteria, distrugge tutto il materiale che non fosse munizioni, anche questo in numero ridotto, rendiamo inservibili le macchine e le autocarrette che non possono servirci, perché dobbiamo abbandonare le piste e dirigerci in direzione ovest toccando i paesi segnati nell’itinerario di ripiegamento.

Alle prime ore del mattino del 19 ci mettiamo in marcia. E’ in testa il Gemona con la 72ª Compagnia di punta. Marciamo in formazione di combattimento, lentamente, ma decisamente. Arriviamo a Nikolajewka di Rossosch (da non confondersi con l’altra più avanti). Qui lasciamo il gruppo Udine del 3^ Artiglieria, il mio gruppo dell’Albania, saluto i miei vecchi soldati e ufficiali.
Continuo la marcia con la colonna deli ‘8^ Alpini e del Gruppo Conegliano. Al nostro apparire nelle vicinanze di un villaggio bruciano alcuni grandi pagliai, nessuno di noi ha dato fuoco. Sono certamente delle segnalazioni russe. Il colonnello Cimolino mi incarica di interrogare i borghesi per avere notizie del nemico. Col tenente Sanguinetti, che parla russo, chiedo a dei bambini se sanno dove sono i soldati russi.
Vengo a sapere che alcuni reparti italiani, due giorni prima, in ripiegamento per quella località erano stati completamente distrutti da forze russe. Un bambino dice che nel paese vi sono parecchi carri armati russi e molti soldati. Il colonnello Cimolino mi prega di correre in testa della colonna per dire al tenente Chiussi di mandare avanti delle pattuglie per esplorare il paese che già si vede in distanza. Eseguo l’ordine. Chiussi stacca due pattuglie e rallenta la marcia della testa della colonna.

Pochi minuti e le pattuglie si arrestano ed aprono il fuoco. Tutta la 72ª Compagnia balza in avanti e si trova subito impegnata col nemico. La colonna si ferma ed i reparti si dispongono in ordine dì combattimento. Entriamo nelle prime case del paese, siamo nella zona di Ssolowiew Nowo Postojalowka. I russi si ritirano in un gruppo di case diviso da noi da una; balka, con a destra un boschetto. Da questo partono raffiche di mitragliatrici. La compagnia di Chiussi, col comandante in testa, con impeto irresistibile entra nel villaggio superando la balka e l’accanita resistenza nemica.
Il nemico, che sembrava avesse abbandonato il villaggio occupato dal Gemona, improvvisamente contrattacca ed i nostri devono ripiegare lasciando sul terreno molte perdite. Breve consiglio di guerra, bisogna sfondare a qualunque costo; continuare la marcia, il tempo è prezioso. Il Gemona e il Tolmezzo riattaccano appoggiati da pezzi di artiglieria. Dopo due ore di duro combattimento non riescono ad avanzare. Intanto si fa notte. Si riordinano i soldati dei due battaglioni, rinforzati dal Cividale e dal Ceva, della Cuneense, che ci aveva raggiunto nella serata, e si riprende l’attacco.

La resistenza nemica è sempre più forte. Chiussi è ferito alla testa e vuol rimanere a combattere. Le perdite aumentano di ora in ora, la situazione è disperata; ben quattro attacchi sono stati sferrati nella notte senza successo. Si raccolgono gli uomini, si racimolano persino i conducenti, gli attendenti e tutti i disponibili insomma per tentare un attacco risolutivo nelle prime ore del giorno 20.
Molte sono state le perdite in quella notte, la neve è cosparsa di morti e di feriti che gemono e invocano soccorso. Ogni ufficiale rianima i soldati che si dispongono nuovamente al combattimento. Questa volta sarà ancor più duro, perché ad ogni costo bisogna sfondare. Io rimango col Gemona e mi confondo con i soldati nell’attacco. Ho il fucilemitragliatore regalatomi dal generale Ricagno, comandante della divisione. E’ uno Stein tedesco; ha solo 6 caricatori da 40 colpi l’uno.
Dopo mezz’ora sono senza cartucce, e in quel momento sembra che il fuoco accenni a diminuire. Non siamo ancora entrati nel villaggio, improvvisamente ci piombano addosso tre carri armati. I pezzi del Conegliano sparano alla distanza di cento metri dai carri. I carri continuano la loro marcia, uno si dirige verso un pezzo, lo raggiunge, lo schiaccia nella neve assieme ai serventi che non si sono mossi dal loro posto di combattimento.

La lotta in quel momento assume aspetti selvaggi, tutti sono impegnati, i carri si piazzano alle nostre spalle ed iniziano un tiro rapidissimo ed a breve distanza col cannone di bordo. Contro i carri non c’è niente da fare, gli alpini non credono a questo, ne rincorrono uno, in un balzo gli sono sopra, tentano di aprire la botola che resiste; un secondo carro interviene in favore del primo, spazza con la mitragliatrice gli alpini che sono sopra; il carro assalito dagli alpini fa un “dietrofront”, sparisce nella balka perdendo molto fumo, certamente si è incendiato.
Lo spettacolo in questo momento è terrificante. Gruppi di alpini distesi sulla neve continuano a far fuoco, due pezzi d’artiglieria che sparano a zero, qualche mortaio impennato sulla neve, i carri armati russi che scorrazzano in mezzo a noi, cannoni anticarro russi dal boschetto ci tempestano di colpi, soldati trascinano feriti nelle isbe vicine, urla, grida, ordini di ufficiali, rantoli di morenti che nessuno assiste, la neve si arrossa. Alcune case bruciano.
Verso mezzogiorno breve tregua, intanto nell’orizzonte, alla nostra destra, quasi alle spalle, scorgiamo il nero serpeggiare, sulla steppa bianca, di una colonna che avanza avvicinandosi a noi. Una pattuglia di alpini sciatori corre incontro alla colonna. Siamo ormai convinti che sono dei russi, seguiamo la nostra pattuglia che s’avvicina alla colonna. Sono alpini anche loro, ormai li distinguiamo, è l’intero 9^ Reggimento con il reparto quartier generale della Julia che vengono in nostro aiuto. Sembriamo tutti pazzi e come per incanto il fuoco cessa. I russi si ritirano nel villaggio, i carri armati spariscono nella balka. La colonna del 9^ sta per raggiungere il boschetto, improvvisamente si scatena un fuoco d’inferno.

Gli alpini del 9^ balzano in un terribile attacco, noi corriamo con loro, la mischia è feroce a corpo a corpo col nemico. Le fasi di questo combattimento hanno dell’inverosimile. Noi siamo frammischiati ai russi che sono mimetizzati, come molti di noi, con camici bianchi. Non ci distinguiamo bene gli uni dagli altri. Un ufficiale russo approfitta dell’occasione e gioca d’astuzia. Appoggiato ad un carro armato fermo, con larghi gesti del braccio, chiama a sé un gruppo di alpini.
Il capitano Erigenti è in testa a questo gruppo ed è il solo ad accorgersi del tranello, grida ai suoi alpini: “Sono russi” e si butta con ardimento che ha dell’incredibile nella mischia trascinando i suoi alpini. Dopo alcuni passi stramazza al suolo; anche l’ufficiale russo cade. Tutto intorno è una feroce mischia, si lotta a bombe a mano. I russi dopo circa un’ora si ritirano nuovamente nel villaggio al di là della balka.
Il capitano Erigenti viene raccolto in condizioni disperate, è colpito alla testa, al braccio destro ed in varie altre parti del corpo. Il destino vuole che non muoia; i suoi soldati non lo abbandonano e lo trascinano di villaggio in villaggio, di combattimento in combattimento, con sacrifici ed avventure che superano ogni immaginazione di guerra, ed oggi vive a Padova, senza il braccio destro e senza l’occhio sinistro; il resto del corpo glielo hanno abbastanza rabberciato.
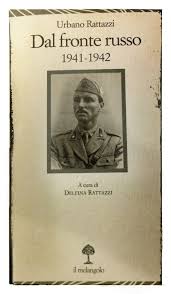
Verso le ore 15 tutto sembra essere cessato, ci rimane per il desolante spettacolo di centinaia di feriti che si trascinano sulla neve. I morti non li contiamo più. Tutte le isbe sono piene di feriti. Il generale Ricagno, il capo di stato maggiore colonnello Molinari e gli altri ufficiali della divisione sono con noi in quel momento Sono fissi ad esaminare una carta topografica nell’interno di un’isba, quando un proiettile di cannone scoppia nella finestra dell’isba. Il generale rimane calmo, attende che il fumo si dilegui dalla stanza e riprende l’esame della carta.
Ogni collegamento radio ormai è impossibile con i comandi superiori. Siamo terribilmente soli e ci dobbiamo arrangiare. In un momento di tregua del combattimento me ne sto seduto sulla neve col fucile mitragliatore fra le ginocchia. All’intorno dei morti alpini e artiglieri del Gruppo Conegliano.
Non ho la forza di parlare, né di muovermi: guardo con occhi incoscienti i feriti che si trascinano nella neve e che noi non abbiamo la forza di aiutare, quasi li invidiamo, perché sono più vicini alla morte. Uno si è trascinato vicino all’isba ove i medici stanno lavorando. L’isba è piena e i feriti fanno la coda fuori. Questo si è trascinato da solo, lasciando una scia di sangue sulla bianca neve, appoggia la testa sul muro dell’isba e mi guarda, con un’espressione che non so descrivere. Gli mancava completamente il piede destro e dal moncone della gamba il sangue gli usciva e lui sembrava rassegnato ad attendere, non certo il suo turno di medicazione, ma la morte. Il suo sguardo m’impressionava più che il suo sangue; non so resistere e mi giro da un’altra parte.

Un altro alpino mi passa vicino, si trascina a stento, non parla, mi guarda, ha il moschetto in ispalla e dal braccio destro gli manca la mano. Credo che non senta più il dolore; l’espressione del suo volto è da incosciente; a un certo momento mi ha sorriso. Un altro soldato mi avvicina, mi guarda, si siede sulla neve accanto a me, mi offre un pezzo di pane cosparso di miele e mi dice: “Sior Angelo, coraggio dobbiamo ritornare a Cavaso”.
E’ un mio paesano e con gli occhi, più che con la parola m’interroga per sapere cosa succederà di noi. E’ Orfeo Visentin, attendente di un mio amico del Val Piave. Gli chiedo notizie del suo tenente, non sa dirmi nulla, crede sia morto poche ore prima. E’ inutile ricercarlo tra i morti, sono troppi e poi… anche trovandolo? Non è insensibilità, né abbrutimento questa indifferenza; è un fenomeno del momento, è l’influenza del sangue sul sangue; dei troppi morti sui vivi che non hanno più speranza della vita.
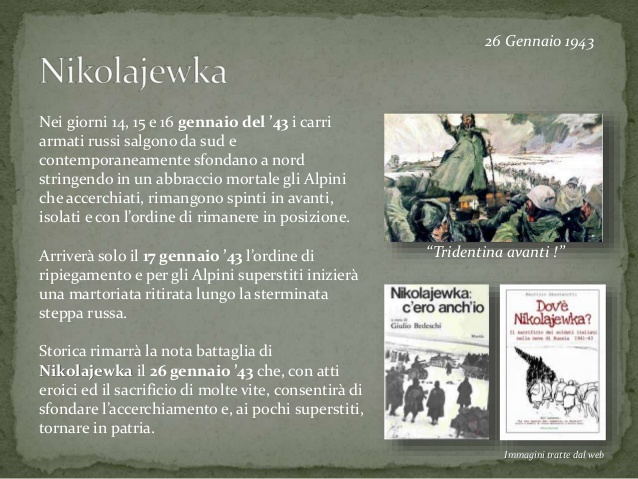
Un ordine. Si parte. Lasciare i feriti nelle isbe, muoversi nel massimo silenzio, prendere le munizioni ai morti e ai feriti, incolonnarsi e… silenzio. Ormai è scuro e il nemico non si deve accorgere che noi partiamo. Ritorniamo indietro in direzione est per alcuni chilometri… Siamo alla sera del 20 gennaio e dobbiamo raggiungere Waluiki. Nessuno sa che il Corpo d’Armata e la Tridentina hanno cambiato itinerario e che pochi di noi arriveranno vivi a Nikolajewka…
Il sergente Venuti, il mio sergente, è riuscito a trovare un cavallino russo che ha attaccato ad una piccola slitta. Mi segue con Lazzera e i due fratelli Miodini; degli altri miei soldati non so più nulla, con noi non ci sono; cinque sono certamente morti, nove sono feriti e lasciati a Ssolowiew, me ne mancano ancora 18 dei 36 partiti da Golubaja Krinitza due giorni prima. Il sergente Venuti ha l’impressione che anche questi 18 siano morti nell’attacco del villaggio abbandonato il giorno prima.
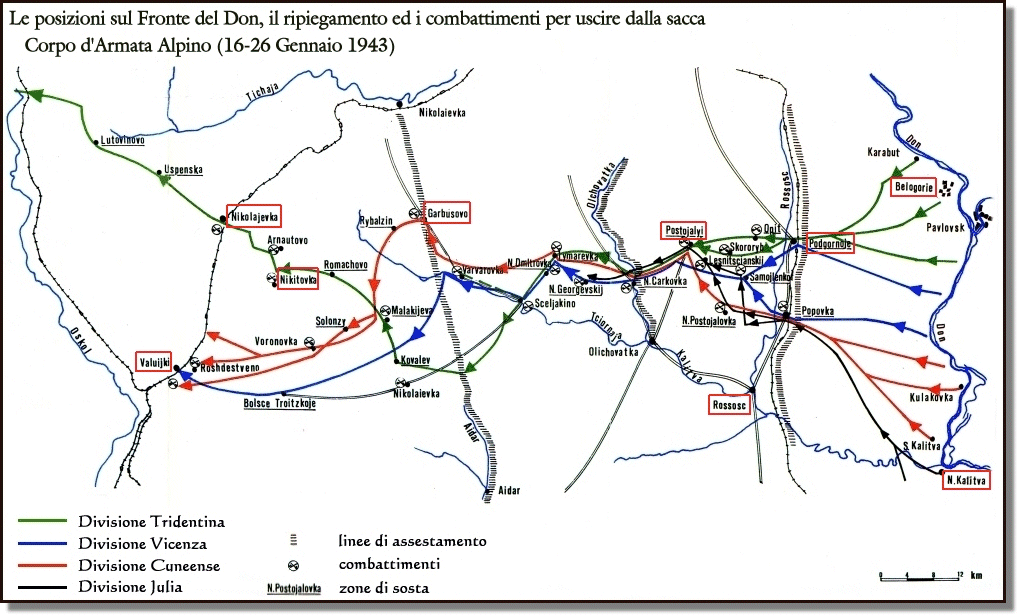
Verso le ore 10 del mattino, siamo se non sbaglio al 20 gennaio 1943, ci incontriamo con la Divisione Cuneense. Il generale Battisti è in testa su un cavallo bianco. Proseguiamo assieme poi ad un certo momento ci vien dato l’ordine di accodarci. Un breve alt finché la Cuneense passa e riprendiamo il cammino. A mezzogiorno giungiamo in un gruppo di case situate nel quadrivio di due grandi piste.
Ci fermiamo per circa un quarto d’ora e riprendiamo poi la marcia. Io sono in testa della colonna della Julia, facevo parte del gruppo di ufficiali del comando divisione col generale Ricagno, seguivano il reparto quartier generale del 9^ Alpini, il Gruppo Conegliano e il Gruppo Udine in coda. Con la testa della colonna abbiamo lasciato il quadrivio per scendere in una specie di valle e poi salire in un mammellone e camminando su un campo di girasoli coperti di neve. Intanto la colonna si snodava dal quadrivio formando un lungo cordone nero serpeggiante nella steppa bianca. Tutto sembrava calmo.

Improvvisamente udiamo in direzione del quadrivio un violento fuoco di mitragliatrici e di cannoni. I russi hanno attaccato la coda della colonna con carri armati giunti dalla pista est. Noi ormai siamo a circa due km dal quadrivio. Il Gruppo Udine e particolarmente la 34ª Batteria, sono stati in breve distrutti. La colonna si è spezzata ed alcuni reparti del 9^ Alpini, che sono rimasti dietro il Gruppo Udine impegnati subito in combattimento sono riusciti poi a girare la posizione ed a sfuggire al nemico. Molte sono state le perdite nostre anche in quell’occasione.
I carri armati russi intanto si dispongono lungo la valle per tagliarci la ritirata dovendo noi scendere dal mammellone per proseguire in direzione ovest. Fortunatamente comincia a far scuro ed immaginando le intenzioni del nemico, cambiamo direzione per raggiungere un bosco nel quale i carri armati non ci avrebbero potuto raggiungere. Il rumore di questi carri era continuo. Ci fermiamo nel bosco e successivamente fuori attorno a dei grandi pagliai. Sono le otto di sera e si riparte, questa volta riprendendo la direzione ovest.

Dopo circa 2 ore di cammino entriamo in un grande villaggio ove già si trova la Cuneense. I russi non devono ignorare la nostra marcia di quella sera, perché dalla sommità di una collina sparano con pezzi anticarro, colpendo in più parti la colonna. Ricordo un particolare in cui la mia intuizione del momento ha salvato la colonna. Camminavamo ai fianchi del mammellone, stavamo scendendo mezza costa mentre udivamo gli spari dal quadrivio.
Ero in quel momento vicino al generale Ricagno, con lui c’erano altri ufficiali tra i quali il colonnello Moro comandante da poco del 3^ Reggimento Artiglieria Alpina. Eravamo tutti
disorientati e non sapevamo che cosa si dovesse fare. La situazione, come da alcuni giorni, era disperata e bisognava affidarsi al destino. Il generale, che era in testa alla colonna, non sapeva più in quale direzione dirigersi. Chiese il parere del colonnello Moro. Il colonnello Moro propose di scendere a fondo valle e spingersi poi a sud convinto di sfuggire così all’accerchiamento nemico.

Il generale rimase silenzioso, poi ad un certo momento si voltò, mi scorse e mi chiese: “Che ne dice lei Damini? Dobbiamo andare a sud come dice il colonnello Moro?”. Io lo guardo, quasi meravigliato che chiedesse il mio parere, parere che francamente non condividevo, perché intuivo, anzi immaginavo che topograficamente a fondo valle ci fosse una strada, come del resto era logico ammettere e quindi percorrere le strade in quei momenti in cui eravamo “braccati” dai russi, era un’imprudenza.
Francamente esposi la mia idea suggerendo di mantenerci a mezza costa, di raggiungere il bosco che vedevamo distante circa un’ora di strada, di spingerci poi a nord per riprendere in un secondo tempo la marcia ad ovest. Avevo osservato che gli attacchi russi di quei giorni provenivano tutti da sud ed immaginavo quindi che al nord la strada fosse più libera. Il colonnello Moro mi guardò, sostenne ancora la sua idea, ma infine esclamò: “Proviamo pure ad andare a nord, ma non ho fiducia che riusciremo a sfuggire”.
Il generale approvò senz’altro la mia proposta. Riprendemmo la marcia e dopo alcuni minuti sentimmo il rumore di carri armati che percorrevano la strada di fondo valle. Era quasi scuro e vedevamo i fari dei carri armati che ci cercavano. L’avevo indovinata! Il generale non mancò di dirmelo e da quel momento, fino al giorno in cui fu preso prigioniero, non volle più che lo lasciassi. Era un soldato fra i soldati. Nel pastrano non aveva gradi, e il passamontagna era uguale a quello della truppa.

Più volte, stanco di camminare, si appoggiava a qualche slitta sopportando le sfuriate dei conducenti, che non lo riconoscevano e non permettevano che nessuno si attaccasse alle slitte per non stancare di più i muli che rappresentavano per noi in quel momento tutta la nostra speranza. Le poche slitte erano cariche di feriti e i muli da molti giorni erano digiuni. Ogni tanto i muli di qualche slitta si lasciavano cadere al suolo e non c’era verso di farli rialzare. Dovevamo abbandonarli con la slitta anche se questa era carica di feriti che, disperati chiedevano soccorso sapendo che ormai dovevano morire sulla neve.
Queste cose le comprendono solo quelli che le hanno vissute, sono indescrivibili; una battaglia si può descrivere, ma l’abbandono di una slitta carica di sette, otto feriti, nella steppa, soli, nell’impossibilità di muoversi è indescrivibile. E’ indescrivibile il loro strazio, la loro disperazione nel vedersi abbandonati e condannati a morte certa. Qualcuno si gettava dalla slitta, a carponi camminava sulla neve invocando soccorso che nessuno gli poteva dare e dopo qualche centinaio di metri si fermava e si disponeva a morire. In questi casi dovevamo girar loro al largo, perché dalla disperazione si aggrappavano al pastrano od ai pantaloni e non mollavano la stretta finché non sopraggiungesse la morte.

Quella notte l’abbiamo passata in un paese del quale non ricordo il nome ma che se potessi avere una carta topografica del luogo, riconoscerei con certezza. La posizione non era sicura. Durante tutta la notte le artiglierie russe hanno sparato sul paese. Io ho avuto la fortuna di dormire alcune ore sopra uno dei caratteristici forni delle isbe russe. Mi sono messo in forza ed alle prime ore del mattino abbiamo ripreso la marcia piena di incognite.
Ci precedeva la Cuneense molto ridotta di uomini, dovevamo essere al 21 o 22 gennaio. Non avevamo più cognizioni del tempo e quindi posso anche sbagliare. Si pensi che il calcolo delle giornate lo faccio ritornando indietro dal 10 febbraio, data precisa, in cui sono uscito dalla sacca. Il freddo è intenso anche perché è una giornata serena. Il mistero di quella notte non è ancora risolto. Pochi metri fuori dell’isba nella quale ho riposato, alla mattina ho trovato 3 morti sulla neve che alla sera prima non c’erano. Altri morti ho visto lungo il paese, erano civili russi e tedeschi. Ho bene osservato e non erano morti a causa di scoppi di granata.

Tanta era l’indifferenza in quel momento che non mi sono preoccupato di chiedere cosa fosse avvenuto nella notte. Io non avevo sentito nulla ed ero soddisfatto d’aver riposato in un ambiente caldo. Continuiamo la marcia in direzione ovest fino a mezzogiorno. Ci arrestiamo in un grande villaggio. Il generale Ricagno prega il tenente Caruso dei carabinieri di cercare un’isba per ricoverarci almeno un’ora, il freddo è insopportabile. Con Caruso ho cercato anch’io, tutte erano piene di soldati feriti, distesi per terra, senza un filo di paglia, senza mangiare, senza medicamento, solo in preda ad una disperazione indescrivibile.
Non c’era un’isba libera e quindi, per ripararci dal freddo dovevamo entrare in una qualunque. Stavamo riferendo questo al generale quando due ufficiali della Cuneense ci informano che una colonna di carri armati proveniente dall’ovest sta per raggiungere il paese. Contemporaneamente in direzione est sentiamo colpi di mortaio, cannone e raffiche di mitragliatrice e fucileria. In quella direzione doveva trovarsi l’8^ Reggimento Alpini. Non c’è tempo da perdere. Giriamo a sinistra e… marcia avanti a tutta pressione.
Marciamo in direzione sud. Nessuno ha fame, nessuno è stanco, nessuno ha freddo. Qui mi incontro con Erigenti che ritenevo abbandonato a Ssolowjew. E’ disteso in una slitta accompagnato ed assistito da un bravo carabiniere del comando di divisione al quale, credo, deve la vita. Credo che il mio aspetto abbia fatto impressione a Erigenti, perché mi incoraggia e mi da una pastiglia di… non so che… che mi ha ridato un po’ di forza. Realmente il freddo stava per vincermi e la fame mi tormentava, da due giorni non mangiavo un grammo di pane.
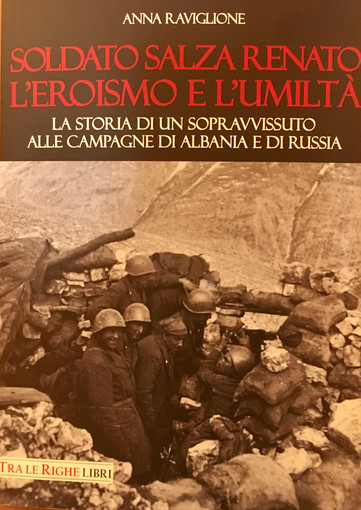
Incontro un altro amico, il capitano Rizzetto pure da Padova, che vistomi in condizioni pietose mi cede il suo mulo; come l’avesse trovato nessuno lo sa. Lui intanto si attacca un paio di sci e fa il collegamento tra la testa e la coda della colonna. E’ pieno di forza e di vita da far meravigliare gli altri. Ci raggiunge intanto un gruppo di alpini dell’8^ che ha seguito una via traversa e che per pura combinazione ci ha incontrati.
L’attacco che abbiamo sentito ad est era effettuato contro il comando dell’8^ Alpini che si è fermato in un piccolo villaggio per una breve e necessaria sosta. Gli alpini dell’8^ superstiti, ci raccontano i particolari. Il colonnello Cimolino è stato catturato col capitano Magnani. Il tenente Sanguinetti è morto, il tenente De Laurentis ferito, altri ufficiali sono morti ed i rimanenti prigionieri. Nessuno degli ufficiali del comando dell’8^ è sfuggito alla sorte. L’attacco è stato improvviso; carri armati hanno improvvisamente accerchiato il villaggio e in un breve e violento combattimento hanno distrutto le nostre forze.

L’attacco è provenuto da est e noi l’aspettavamo da ovest, eravamo bene informati! La situazione si aggrava, gruppi di soldati prendono direzioni arbitrarie, la colonna non ha più ordine. Raggiungiamo una colonna tedesca di salmerie, discendiamo in un lento e lungo declivio il cui terreno permette di vedere lo spettacolo offerto in quel momento da uomini in fuga disordinata, terrorizzati, violenti nell’andare, abbandonati. Terminata la discesa, saliamo per superare un mammellone. Alla sommità di questo un sinistro spettacolo si offre alla nostra vista. Incomincia ad oscurare.
Migliaia di uomini scendono il versante opposto per raggiungere il villaggio sottostante. Molte case bruciano. Alcuni cannoni russi piazzati nelle vicinanze ci tempestano di colpi. Molte mitragliatrici con i proiettili traccianti segnano rapide lunghe scie nella semioscurità. Granate scoppiano nel mezzo di gruppi alpini, soldati morti, slitte rovesciate, muli sanguinanti che girano da soli nella neve.

Migliaia di punti neri, formicolanti in un tappeto bianco in contrasto con l’oscurità, bagliori di scoppi di granate, scie luminose di proiettili, vertiginoso ed indifferente movimento di uomini tutti diretti in direzione del paese, bagliori di decine di incendi, è lo spettacolo in quel momento. Guardo tutto ed esclamo: “Ecco la sagra della morte”. Il tenente Venturoli che mi è vicino mi guarda e mi risponde; “Come sei lugubre Damini!”. In quel momento sono perfettamente cosciente della situazione ed i presagi che ne facevo si sono dimostrati poi esatti.
Il paese, che era a fondo valle, si distendeva per circa due o tre km con case disposte da ambo i lati della strada lunga e diritta. Riusciamo a raggiungere le case all’estremo nord. Tanta è la stanchezza ed il freddo che il pericolo ci rende insensibili. Ci aggiustiamo in due, tre isbe vuote, indifferenti di quanto avviene nel rimanente del paese. La morte non la temiamo più, ci basta trovare un riparo dal freddo. Abbiamo perso ogni speranza di uscire dalla sacca.

Siamo degli automi, privi di sensibilità, che brancolano nell’ignoto, senza meta, senza speranza, senza direzione. A sera tardi diminuisce il frastuono della battaglia, cessano gli spari e ad una certa ora della notte tutto è silenzio. Solo gli incendi delle isbe illuminano il panorama. Mi sdraio in un po’ di paglia ed il sonno mi vince. Credo aver dormito quattro ore. Ad un certo momento il tenente Corradi che mi è vicino mi scuote, mi sveglia e mi grida: “Su presto scappiamo”. Non occorre dire di più.
Il crepitio di mitraglie e fucili, gli spari di mortai e cannoni, il rumore di carri armati mi dicono tutto. Non ho niente da prendere, perché non ho più niente con me, esco dall’isba all’oscuro. Movimento di soldati che fuggono, scie luminose che si incrociano, gente che si chiama, spari, detonazioni.
Appena fuori m’imbatto nel generale Ricagno. Lo riconosco, è solo, nessun ufficiale era con lui, è confuso tra i soldati che non lo conoscono e nessuno l’aiuta. Lo vedo incerto nel camminare; gli altri corrono per raggiungere una posizione riparata dal tiro delle mitragliatrici che fortunatamente sparano con proiettili traccianti; lo vedo vecchio, affannato nella neve, lo prendo per un braccio e lo trascino con me quasi correndo. Non camminiamo, non corriamo, ma danziamo.

Con una danza acrobatica, saltellante a destra e a sinistra, evitiamo le pallottole delle mitragliere che abbiamo la fortuna di vedere, perché sono luminose. E il povero generale si lascia trascinare da me, saltella come me e non parla. Dopo una mezz’ora di vera fatica, raggiungiamo la sommità di un’altura nel cui versante opposto siamo fuori tiro e quindi, per il momento sicuri. Qui incontriamo il colonnello Molinari ed alcuni altri ufficiali del comando divisione.
Mi intrattengo brevemente col colonnello Molinari ed espongo il mio punto di vista sulla situazione. Propongo di dividerci in piccoli gruppi per sfuggire al nemico. Marciare decisamente in direzione ovest e sciogliere la colonna che è continuamente attaccata, aspettata, avvistata dagli aerei, e decimata. Certo che ogni gruppo deve essere formato da uomini decisi e risoluti, altrimenti è stato meglio abbandonarsi in una isba e farsi prendere prigionieri. Il colonnello non è entusiasta del mio progetto.

Difficoltà di vario genere si oppongono: la mancanza di carte topografiche, la mancanza di bussole, l’ignoto a cui si andava incontro, la stanchezza dei soldati che si sarebbero abbattuti definitivamente se lasciati soli anche con un ufficiale a piccoli gruppi, ecc. Conviene con me nel riconoscere che è dovere salvarsi e raggiungere le nostre linee con qualunque mezzo. Camminiamo intanto in direzione nord.
La marcia è faticosa, perché si affonda sulla neve e stentiamo a guadagnare terreno. Intanto si fa chiaro. Espongo il mio progetto ad alcuni altri ufficiali che lo trovano troppo rischioso: “Meglio morir assieme che morire soli” mi dice qualcuno. Il tenente De Strobel, che non si sente di affrontare il rischio, mi da una piccola bussola. Il colonnello Molinari mi dice che se voglio tentare lo faccia pure augurandomi fortuna. Il maggiore Sangiorgio mi dice che è una pazzia avventurarsi in tre o quattro sulla steppa, privi di ogni conoscenza del terreno, senza riserve di mangiare od altro, con l’incognita della strada che dobbiamo percorrere.
Ciò nonostante mi irrigidisco nella mia idea, non ho la forza però di staccarmi dal mio generale e da altri ufficiali amici. Dei miei soldati non ne ho neanche più uno. Discendiamo in una dolce china, quando improvvisamente la strada sottostante, gremita di soldati in ritirata, si fa teatro di una mischia terribile. Da nord e sud provenivano carri armati nemici; si arrestavano, sparavano col cannone e riprendevano la marcia.

Non c’era niente da fare: o lasciarsi uccidere o prendere, o tentare l’impossibile per attraversare la barriera di fuoco e ferro e spingersi in direzione ovest nella steppa. In quella direzione si scorgeva anche un boschetto. Non perdo tempo nella decisione. Seguito dal tenente Venturoli, dal tenente Corradi e dal tenente della sussistenza Anacreonte, e due soldati, mi butto a valle, taglio la colonna e con uno sforzo sovrumano raggiungiamo il
boschetto.
Il mio generale non ha avuto la forza fisica di seguirmi. Del gruppo di alcune centinaia che eravamo prima, solo noi sei ci siamo salvati in quella occasione: tutti gli altri sono stati presi o uccisi nel combattimento di fondovalle. Un’eccezione, il tenente Hauda che non si era staccato con noi ci ha raggiunto dopo circa un’ora, solo, zoppicante per un principio di sinovite al ginocchio destro.
Da questo momento incomincia la più dura, la più tragica, la più interessante delle avventure della mia vita. Sette punti neri sulla steppa bianca! soli, senza viveri, senza carte
topografiche, in territorio nemico, con un freddo dai 35^-40^ sotto zero, in terreno sconosciuto, con una sola direzione ovest, con un solo desiderio: quello di giungere in patria, senza conoscere quante centinaia di km dovevamo percorrere senza farci prendere e… mantenersi in vita, fortemente decisi a tutto, superare, combattere e arrivare o morire.


