a cura di Cornelio Galas
Fonte: “Nikolajewka: c’ero anch’io”. Giulio Bedeschi. Testimonianze fra cronaca e storia.

Caporal maggiore Luigi Melegari
116ª Compagnia, Battaglione Gemona, 8^ Reggimento Alpini
Gli episodi sarebbero tanti, ma sempre di quelli che si vedevano mentre si camminava in colonna. Posso raccontarne uno che mi è rimasto impresso, mentre si camminava per arrivare verso Nikolajewka. Lì in un fossato c’erano due o tre morti, e invece uno era ferito, seduto a terra e si reggeva sulla mano destra, era tutto tremante e faticava a respirare.
Ad un tratto un artigliere si ferma, tira fuori la rivoltella e dice: “Guarda guarda, bisogna coparlo questo, può fare la spia dopo”, e gli tira un colpo alla tempia e lo fredda. Questo russo ha visto e capito tutto ciò che succedeva, guardava fisso negli occhi quell’artigliere, ma non ha aperto bocca.

Alpino Enrico Chiapponi
Compagnia Comando, Battaglione Gemona, 8^ Reggimento Alpini
Giungemmo a Nikolajewka nel primo pomeriggio del 26 gennaio. Qui ad attenderci trovammo i fucilieri russi che, al riparo del terrapieno della ferrovia che attraversava la periferia del paese, ci arrestarono con un nutrito fuoco di sbarramento, mentre dalla collinetta adiacente i mortai appoggiavano la loro azione.
La situazione era veramente drammatica. Bisognava andare avanti a tutti i costi, sfondare la linea nemica per non restare chiusi in una sacca micidiale. Le sole armi che avevamo a disposizione erano: carabine, moschetti modello ’91 e qualche fucile mitragliatore. La scorta delle munizioni era quasi esaurita, ci restavano solo pochi proiettili e qualche bomba a mano del tipo Balilla. Ma non si poteva indugiare a lungo, bisognava agire subito.

Ed il nostro comandante, tenente Pio Marcili, in sella al suo cavallo, ci guidò all’attacco gridandoci: avanti Gemona! Ci affiancammo allora all’eroico Battaglione Edolo della Divisione Tridentina e ci buttammo sul nemico con l’impeto e la volontà di chi vuol sfondare a tutti i costi. Era in gioco la nostra stessa vita, la nostra libertà. La battaglia fu cruenta, i morti si contarono a decine, i feriti a centinaia.
Vidi cadere amici carissimi, sentii implorare feriti abbandonati sulla neve. Dolore e pietà si alternavano nel mio animo, ma non si poteva far nulla per loro, perché mancavano i mezzi per soccorrerli. E furono lasciati in quella bianca distesa di neve in balia di un destino crudele. Io stesso per poco non subii la loro sorte.

Fui colpito all’avambraccio sinistro da una grossa scheggia di mortaio mentre avanzavo verso la ferrovia. Mi trovavo ad una cinquantina di metri da questa, quando mi cadde di mano il fucile. Mi chinai per raccoglierlo e vidi sorpreso la mano grondante di sangue. Tamponai, mentre correvo, la vasta ferita con i brandelli della manica e mi portai al riparo sotto al terrapieno della ferrovia in prossimità del sottopassaggio dal quale si accedeva al paese.
Mi raggiunsero quasi subito il maresciallo Girolamo Zuradelli, un sergente alpino friulano ed un alpino di Corniglio Parmense, i quali mi legarono strettamente il braccio con una corda per arrestare l’emorragia e mi fasciarono la ferita con una mollettiera che mi slacciarono da una gamba. Entrammo poi insieme in Nikolajewka, perché la battaglia che volgeva al termine si stava risolvendo in nostro favore. Trovammo riparo in un’isba e lì pernottammo con altri militari.

Il mio braccio, però, non mi lasciò riposare. Il dolore era forte. Qualcuno mi consigliò di levarmi gli scarponi per poter riposare meglio e, sperando che ciò mi portasse sollievo, lo feci. Il mattino seguente però me ne pentii amaramente: durante la notte si erano talmente induriti dal gelo che, quando i russi ripresero a sparare costringendoci a fuggire in gran fretta, non potei infilarli e fui costretto a camminare tutto il giorno in mezzo alla neve con le sole calze.
Soltanto a sera trovai due pezzi di coperta che mi feci legare ai piedi e con queste, sempre camminando, continuai la ritirata fino al 3 febbraio, giorno in cui fui caricato su di un camion e trasportato all’ospedale di Karkow.

Alpino Nullo Filippelli
Battaglione Gemona, 8^ Reggimento Alpini
Era un freddo intenso, in quell’inverno, per riscaldarsi un poco girovagavamo da un’isba all’altra, dove qua e là avevano fuochi accesi, ed in cerca di nostri compagni. Avevo con me appesa alla cintura in un sacchetto una pagnotta di pane che da diversi giorni conservavo gelosamente. M’introdussi in un’isba, sentii gridare: “Raus!”; era gremita di soldati per lo più tedeschi. Ad un tratto mi accorsi che mi era sparita la pagnotta dal sacchetto.
Per me quel pane, sfinito com’ero dagli stenti, in balia della sorte, voleva dire tirare avanti qualche giorno in più. Immediatamente mi diedi da fare per rintracciarla e mi accorsi che me l’aveva presa un soldato tedesco: “Ridammi quel pane, è mio” dissi. Di scatto lui estrasse la rivoltella e me la puntò sul petto (forse per spaventarmi). Non esitai un istante; lo presi per il bavero del cappotto e non so cosa sarebbe successo se non fosse intervenuto un ufficiale tedesco che parlava stentatamente in italiano. Mi fece restituire la pagnotta, lo ringraziai e gli diedi una fetta di quel pane duro che accettò molto volentieri.
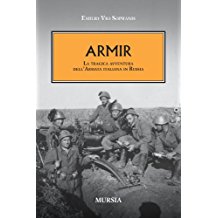
Mi ricordo del tenente Pio Marcili a cavallo che gridava incitando “Avanti Gemona” dietro il terrapieno della ferrovia là dov’è morto il maresciallo Zuradelli e l’alpino cuciniere Bianchin. In quei giorni c’era con me un ragazzo del mio paese e precisamente il caporal maggiore della Compagnia Comando del Gemona (Giuseppe Gabelli), gli avevo dato qualche sigaretta che ancora tenevo, poi immediatamente ci fu un attacco, povero Giuseppe lo persi di vista in quel momento e non lo rividi mai più, e tuttora risulta disperso.
A Nikolajewka durante l’attacco decisivo, condotto dalla Tridentina, quanti e quanti ne vidi morire. Girovagai per tutta la notte tra i feriti cercando un volto conosciuto, inciampando nella neve, oltre la scarpata e verso il viadotto finché venne l’alba e con gli occhi semichiusi vedevo come in un sogno la mia casa, la nostra cara Italia. Sono fiero di essere un alpino della Julia, ringrazio Iddio di avermi salvato da tanto pericolo passato.

Tenente Ignazio Malacarne
Battaglione Gemona, 8^ Reggimento Alpini
Non mi riesce di ricordare nomi e fatti precisi degni di essere mandati alle stampe; ho nelle orecchie il ricorrersi di ordini, sollecitazioni, preghiere e bestemmie, invocazioni e urla; vedo il generale Reverberi passare fra l’immensa fiumana, chiamando a raccolta i vari battaglioni dall’alto del suo semovente; vedo ancora gli alpini dei pochi reparti rimasti, serrare, portandosi verso la testa della colonna, trainando le poche armi collettive ed individuali rimaste efficienti; ho presenti scene strazianti di altri mentre tendono la mano per essere rialzati e portati avanti, gli occhi imploranti misericordia od allucinati dal terrore di essere lasciati a morire sulla neve.
Osservo lo spettacolo inenarrabile della pazza corsa verso le prime posizioni, per non giungere in ritardo alla conquista dell’isba calda ove poter ricoverarsi per passare la notte al riparo… Ma tutto questo è nulla e non serve… Sono ricordi confusi; visioni apocalittiche che si sono stampate entro di me e non mi lasceranno più. Ma anche queste immagini non servono. Ce n’erano parecchi di alpini con me, ma nessuna esatta fisionomia torna alla memoria; nessun nome risuona nelle mie orecchie.

Ho cercato, ho tentato, mi son spremuto le meningi; nulla è in me che possa essere cucito e detto senza il timore di sbagliare, di confondere. E” rimasto in me solo il quadro generale, ma sfocato e nebuloso, di quella terribile e lunghissima giornata. Nulla di più. Mi spiace, ma non posso proprio far nulla per contribuire anche in piccolissima parte alla stesura della storia di quel leggendario pugno di uomini che mi permisero di ritornare. Non avermene, e so che non me ne vorrai, perché anche tu sei stato a Nikolajewka!
Alpino Pietro Reverberi
69ª Compagnia, Battaglione Gemona, 8^ Reggimento Alpini
Il 16 gennaio del 1943, iniziò praticamente la nostra ritirata: i russi ci avevano circondati e chiusi nella cosiddetta sacca del Don. Incolonnati, ancora uniti, ci avviammo in direzione di Karkow cercando di forzare le maglie dell’esercito russo. Nonostante continui attacchi russi che continuavano a martellarci ininterrottamente per diversi giorni, il nostro battaglione rimase comunque unito fino al 21 gennaio, poi venne quasi completamente distrutto da un terribile attacco russo.

Senza alcuna pietà compagnie di soldati sovietici ci piombavano addosso da ogni parte portando la morte tra le nostre file ormai completamente incapaci di difendersi sufficientemente. Quando tutto terminò, insieme a coloro che non perirono in quell’immane carneficina e più precisamente insieme ad alcuni miei amici, ripresi il cammino lungo ed interminabile verso la Patria tanto sospirata.
Eravamo in quattro o cinque con due muli ed una slitta sulla quale trainavamo diversi soldati feriti o congelati; continuavamo a camminare in mezzo a quella steppa senza saperci più orientare. In sèguito scoprimmo che nel precedente attacco erano stati fatti prigionieri il nostro capitano Magnani ed il colonnello Cimolino.

Non vi era più comando, la colonna di sbandati avanzava lungo la steppa come un enorme serpente che sembrava non avere mai fine: innumerevoli erano coloro che, sfiniti per le ferite o per il freddo, si lasciavano cadere e non si sarebbero forse mai più rialzati; questi segnavano tangibilmente la fine della colonna. Continuavamo a camminare con circa 45^ sotto zero ma ormai era diventata una cosa meccanica, ognuno sapeva benissimo che chi si fermava era perduto.
I russi non ci lasciavano tregua e come branchi di lupi affamati ci attaccavano, ingrossando così sempre più il numero di coloro che non avrebbero mai più rivisto la loro patria ed i loro cari. Ma il culmine degli attacchi russi si riscontrò nei giorni 26 e 27 gennaio a Nikolajewka dove vi fu una immane battaglia di sangue e dove noi riuscimmo a passare grazie all’aiuto pervenutoci dalle retrovie da parte del battaglione stanziato di retroguardia alle nostre truppe.
Cominciò tutto con continui attacchi e continue azioni di guerriglia fra reparti sovietici e reparti italiani, noi ci difendevamo come meglio potevamo, ma ormai nell’animo della maggior parte di noi si stava insediando la trepidazione, la paura, lo sgomento di non più ritornare in patria. Aeroplani, mitragliatrici, granate, bombe di mortai colpivano il grosso della colonna e non davano la possibilità di camminare.

Era una confusione immane, indescrivibile; si cercò di far fronte ai russi con ogni mezzo, ma sembrava di combattere contro dei fantasmi, le bombe piovevano da ogni parte e ovunque lasciavano un segno tangibile di morte e distruzione. Non ricordo altro di ciò che avvenne in quei due giorni di fuoco, anche perché in sèguito ad un bombardamento aereo fui colpito da una granata che aveva centrato l’isba in cui io mi ero riparato. Rimasi pertanto senza conoscenza per diverse ore, due miei amici alpini, Arturo Sassi e Gino Ugolotti di Traversetolo, mi videro e credettero che fossi morto.
In sèguito, dopo essermi ripreso, mi fermai alcune ore in una casa poco distante dal luogo della battaglia dove alcuni russi (c’erano due donne e un vecchio) mi curarono un poco e cercarono in ogni maniera di aiutarmi, assistendomi e dandomi da mangiare quel poco che avevano. Questo in particolar modo mi ha colpito, la grande umanità di quella gente che non rifiutava di aiutarci anche se eravamo loro nemici.

Comunque con la forza della disperazione riuscii a riprendere il cammino: ero ferito leggermente ad una gamba ed avevo un principio di congelamento al piede sinistro. Non stavo comunque peggio di altri miei compagni che per ferite o per essersi congelati gli arti inferiori restarono a morire agonizzando là nella neve senza che nessuno potesse aiutarli. Insieme a migliaia e migliaia di soldati continuammo così la nostra marcia, io, alcuni miei amici che avevo ritrovato durante il cammino, alcuni muli ed una slitta.
Di tanto in tanto qualcuno di noi si allontanava dal gruppo per raggiungere delle case e lì fermarsi un poco al caldo, intorno a quelle enormi stufe russe di terracotta, per trovare un po’”di sollievo e per riprendere fiato, cercando ogni volta cibo: pane di girasole, patate, carote e qualsiasi altra cosa che potesse dare sostentamento in quella lunga e faticosa marcia verso casa.

Fu in una sosta presso una di queste case che a me ed ai miei amici portarono via la slitta ed i muli: questo a testimoniare come ognuno, pur di poter arrivare a Karkow, si arrangiasse in ogni maniera. Pertanto noi dopo esserci riposati un poco riprendemmo la marcia trainandoci dietro nella neve i feriti a turno. Tra i feriti vi era anche un mio caro amico con cui ero partito per il fronte, Athos Fornaciari di Traversetolo, che riuscii a condurre a Karkow grazie al ritrovamento di un’altra slitta abbandonata nella neve da altri alpini.
Arrivammo infine a Karkow e dopo le medicazioni e le disinfezioni partimmo per l’Italia sul treno ospedaliere n. 11; ormai eravamo in salvo; ma il pensiero dei giorni trascorsi, di tutti quei ragazzi morti e fra i quali moltissimi miei amici non mi dava pace, ed ancora oggi mi rattrista immensamente il ricordo di quei terribili giorni.
Tenente Riccardo Marchiori
Battaglione Gemona, 8^ Reggimento Alpini
Dopo aver scavato per oltre tre mesi e creato sul nostro tratto del Don, tra Kuwschin e Semejki, un baluardo difensivo fatto di chilometri di trincee e camminamenti, di una infinità di postazioni, quasi tutte in caverna e fortificate, di confortevoli bunker per truppa e comandi, improvvisamente ed inaspettatamente riceviamo l’ordine di partire per destinazione ignota.

Precisamente il giorno 17 dicembre del 1942 alle ore 6, con una temperatura di 30 gradi sotto zero, abbandoniamo commossi i nostri rifugi e le nostre trincee. Su solide slitte costruite da noi stessi sul modello russo e trainate dai nostri muli impareggiabili carichiamo le armi, le munizioni e quanto ci può occorrere per un lungo periodo di marce abbandonando tutto il superfluo.
Lo spirito è al solito molto elevato e ben presto i nostalgici canti alpini accompagnano il duro e stridente rumore dei muli e delle slitte sulla neve gelata: si intuisce la probabilità di duri combattimenti ma ci pare quasi di ritornare verso l’Italia. La prima marcia non è lunga: da Semejki a Ssaprina, nove chilometri in direzione ovest; ci accampiamo in un bosco nei rifugi lasciati dal Tolmezzo che era partito “autotrasportato”… brutti presagi quando gli alpini vanno in automobile!

La mattina dopo riprendiamo la marcia, il gelo non è scemato; areoplani sovietici ci mitragliano improvvisamente da bassa quota: ad un primo momento di panico succede la rabbiosa reazione degli alpini che, ad un secondo attacco, rispondono con le armi automatiche ed i fucili. Gli aerei si allontanano senza aver causato alcun danno mentre le armi restano pronte sulle slitte; la marcia riprende lenta dovendo scaglionarci in profondità ed anche perché incrociamo le salmerie della divisione Vicenza che ci aveva sostituito in linea.
Per qualche giorno continuiamo a camminare verso sud riposando la notte in villaggi sparsi sulla grande pianura. La temperatura, sempre assai rigida, produce qualche congelamento tra gli alpini che, sia pure bene equipaggiati, non hanno ancora calzature adatte. Intanto si comincia a sapere qualcosa della nostra sorte: “radio naia” avverte infatti che dovremo difendere il fianco destro del Corpo d’Armata Alpino in un tratto che va da Nowo Kalitwa a Iwanowka, fianco minacciato dal nemico che aveva sfondato più a sud con forze poderose.

Il Gemona che era stato, sul vecchio fronte, ininterrottamente in linea, passa ora di rincalzo: dovremo momentaneamente accamparci tra Golubaja Krinitza e la quota 176. Mentre raggiungiamo tali posizioni aerei russi ci attaccano ancora con mitragliamento e spezzonamento causandoci perdite dolorose. Ci accampiamo alla meglio e, per la prima volta, dormiamo all’aperto dentro a dei buchi scavati nella neve: con un po’”di paglia, qualche coperta ed il telo da tenda steso sopra, non si sta troppo male, né molto peggio si starà successivamente quando non avremo più paglia, più coperte e più il telo da tenda. A questo mondo tutto è relativo.
Per qualche giorno cerchiamo di migliorare i nostri rifugi spesso disturbati da attacchi aerei e da tiri di artiglieria, anche la katiuscia, (il temibile lanciarazzi multiplo russo) si fa spesso sentire. La sera del 24 dicembre il tenente colonnello Dall’Armi invita qualche ufficiale del battaglione nel suo ricovero sistemato all’interno di un pagliaio; si tratta di bere due fiaschi di Chianti che egli aveva gelosamente conservati per tale data: sarà questa l’ultima volta ch’io sentirò la voce del mio comandante di battaglione, sarà questa l’ultima volta ch’io vedrò il suo profilo indimenticabile. Egli cerca di trasfonderci tutto il suo coraggio e parte della sua grande forza ma, quella sera, prenderà con sé anche parte del nostro cuore.

Durante la stessa notte (che è quella santa di Natale) siamo in allarme per un accanito combattimento che si svolge davanti a noi (e che dura fino all’alba) il nemico aveva attaccato sul settore del Tolmezzo ma è sanguinosamente respinto. Ritenta l’attacco all’alba del 28, poi al 30, spariamo con i mortai mentre le compagnie vanno al contrattacco: alla testa di tutti riservandosi come spesso diceva il posto d’onore è il tenente colonnello Dall’Armi; non crede a dei soldati nemici che “fanno il morto” e mentre in piedi ed allo scoperto prendeva visione della linea la pallottola di un finto morto lo colpisce al ventre e lo fa stramazzare.
Trasportato in un vicino ospedale da campo muore durante la notte ricordando fino all’ultimo i suoi alpini. Quando la notizia si sparge tra i nostri ricoveri ci sentiamo come perduti. La notte del primo giorno del nuovo anno siamo chiamati in linea con i mortai da 81 e mentre ci piazziamo alle spalle dei valorosi mitraglieri del Cividale il nemico ci scorge e ci da il suo augurale saluto.

Davanti a noi si erge, nera di fumo e di cadaveri, quota 176 che dovremo difendere ad ogni costo; una compagnia di tedeschi ne tiene saldo possesso con nidi di nostre mitragliatrici e cannoni tedeschi da 86; non per questo il nemico cessa i suoi continui attacchi e qualche volta sta per raggiungere la quota ma sempre è respinto da una difesa disperata. Una pattuglia nemica cerca di raggiungere i miei mortai da sinistra (segno che il nostro fuoco disturba qualcuno) ma gli alpini addetti ai pezzi la “fanno fuori” con i fucili e le bombe a mano.
Il giorno 3 di gennaio riceviamo l’ordine di abbandonare ancora le posizioni e di attestarci più ad ovest in sostituzione del Val Cismon provato ormai da lunghi giorni di combattimenti sanguinosi. Ci schieriamo oltre quota 176 davanti a Deresowatka; la nuova posizione non è certo ideale; siamo più in basso del nemico, rintanati dentro trincee frettolosamente apprestate, a destra una nuova quota altrettanto famosa: la 205. Il giorno successivo il nemico ritenta l’attacco alla quota 176 ma due nostre compagnie, la 20ª e la 16ª, partono al contrattacco a plotoni spiegati.

Sembra di assistere, tanto la manovra è perfetta, ad una esercitazione tattica sulle nostre montagne, gli alpini avanzano tra l’infuriare di una reazione terribile e di un fuoco micidiale. Ma la 176 resta nostra ed il bollettino germanico della sera dirà che, grazie al valore degli alpini della Julia; la situazione, su quel tratto di fronte, è ristabilita a nostro vantaggio.
Nei giorni successivi il nemico non attaccherà più; nostri colpi di mano condotti molto dentro alle linee nemiche riescono in pieno; si distinguono, in queste azioni, alpini della 70ª e 71ª Compagnia comandati dagli ufficiali Marchini e Continenza; sono fatti vari prigionieri tra i quali un ufficialetto molto impomatato e profumato che ostenta un cinturone di divisa italiana.

Fino alla metà di gennaio il nostro tratto di fronte si mantiene relativamente calmo e così approfittiamo per rendere i nostri rifugi più solidi e caldi mentre arrivano anche i preziosi stivali di feltro che completano il nostro equipaggiamento aiutandoci a sopportare il freddo intenso. Ben lontani dall’immaginare che la situazione debba precipitare, il giorno 14 la nostra compagnia di riserva riceve l’ordine di schierarsi sulla destra del battaglione, in sostituzione di un reparto tedesco.
Impareremo a nostre spese che quando si verifica un fatto del genere, la bufera è vicina: i nostri alleati, pur tanto valorosi, lasciano spesso “l’onore” di risolvere situazioni disperate agli alpini. Quella stessa sera arriva un ufficiale del 9^ per indicare al capitano Rago, nuovo comandante del battaglione, la via da percorrere per un eventuale ripiegamento. La notizia ci sbalordisce ma purtroppo in altri settori la situazione è peggiorata e Rossosch stessa sta per cadere.

La notte passa ancora calma, ma verso l’alba oltre quota 205 sentiamo il caratteristico rumore di combattimenti in corso, l’allarme percorre tutta la linea, siamo pronti a qualsiasi evenienza. Mi viene richiesto il fuoco dei mortai oltre la quota ad una distanza di oltre 4 km; dall’osservatorio, situato dentro a un pagliaio, dirigo il tiro impossibile con l’angoscia nel cuore; anche davanti a noi comincia il fuoco: mortai e pezzi ci sparano addosso ed ancora mi domando come tante bombe siano potute entrare nella paglia dell’osservatorio senza farmi alcun male.
Mi viene richiesto di controbattere anche quel fuoco infernale ed alcune vedette vengono ad indicarmi da dove sparano i russi: vedo distintamente sullo sfondo di due pagliai il fiammeggiare dei loro pezzi; febbrilmente calcolo la distanza e l’angolo di tiro e dirigo il fuoco di tre mortai su quel nuovo obiettivo. Ormai la linea è tutta un fuoco, intorno all’osservatorio continuano a piovere colpi e colpi; due piastre di appoggio si spaccano ma gli alpini, indomabili, le sostituiscono con le piastre da roccia ed altro materiale di ripiego, frattanto i miei sottufficiali, Forabosco e Papinutto, mi avvertono esultanti che i pezzi del pagliaio non cantano più.

Da quota 205 brutte notizie: la 69ª Compagnia (quella che era andata nella notte in linea) non da più notizie di sé, cosa sarà accaduto? Il plotone arditi va verso la quota mentre ad est il fragore della battaglia aumenta. Arriva un portaordini con un breve e conciso messaggio: alle ore 18 si ripiegherà. Abbandono il magico osservatorio e scendo alle armi per disporre ogni cosa, arrivano gli alpini delle salmerie con muli e slitte. Si comincia il carico ma ad un tratto si ode uno scoppio fragoroso: un mortaio è saltato! Due alpini sono gravemente feriti, uno muore tra le nostre braccia mentre l’altro viene mandato all’infermeria del battaglione con una gamba spappolata.
Così tristemente calano le prime ombre di quel pomeriggio del 16 gennaio mentre anche le armi vengono caricate. Da quota 205 scendono i resti dei plotoni, silenziosi nella loro tuta bianca; solo squadre di esploratori, con il tenente Marchini, restano di copertura: decimato e stanco ma ancora pieno di fede il battaglione va verso Tarnowka. Improvvisamente sulle linee che abbiamo appena abbandonato riprende un fuoco d’inferno, una infinità di bocche da fuoco battono le nostre trincee ormai vuote: pensiamo con raccapriccio e con orgoglio a quei pochi rimasti.

All’alba arriviamo a Tarnowka, ci buttiamo dentro a delle case abbandonate per un breve riposo. Verso mezzogiorno siamo ancora in piedi, per ora non ci sono ordini ma solo notizie dolorose: Rossosch è caduta ed il nemico ha lanciato dei reparti molto dentro al fronte, praticamente noi stessi siamo già circondati o dentro a sacche. Subito dopo si riprende la marcia assai celermente: dovremmo raggiungere Popowka al più presto.
Camminiamo il giorno, la notte successiva e parte della mattina dopo; a Popowka un’infinità di alpini e di tedeschi, incrociamo reparti della Tridentina e della Cuneense che hanno pure abbandonato la linea. Riusciamo ad incolonnarci abbastanza ordinatamente dietro al comando di reggimento, il colonnello Cimolino è in testa e lo seguiamo ancora fiduciosi: “Forza ragazzi – egli ci sprona -, in 60 km saremo fuori ma bisognerà menare le mani”.

Quando nel pomeriggio, dopo un breve attacco aereo, le nostre pattuglie avvistano reparti nemici davanti a noi, crediamo sia giunto il momento di “menare le mani”. Mentre i nostri pezzi da 47 passano in testa e tutto il reggimento si dispone per l’attacco improvvisamente da un villaggio davanti a noi, Nowo Postojalowka, avanzano dei carri armati. Non ho seguito da vicino questo attacco ma me lo racconterà più tardi il tenente Carta: gli addetti ai pezzi hanno sparato fino all’ultimo, fino a venire letteralmente schiacciati dai carri che sopraggiungevano… e dire che nelle esercitazioni in pace le nostre granate foravano qualsiasi corazza!
La 70ª e la 71ª del Gemona assieme ad altri reparti dell’8^ muovono all’imbrunire all’attacco del villaggio; ancora speriamo, sfondata quella resistenza, di raggiungere le nostre linee. Esaurite o disperse nelle retrovie le munizioni da mortaio ci vengono date due
mitragliatrici a difesa di due pezzi anticarro; nella notte buia e fredda si riaccende il combattimento, nostri reparti raggiungono d’impeto il villaggio mentre nuovi carri armati spuntano da ogni parte ed il combattimento continua di casa in casa.

Affluiscono i feriti sempre più numerosi, i carri non ci lasciano passare; alle 3 di notte va all’assalto il Battaglione Ceva della Cuneense con identico risultato. All’alba ancora altri reparti tentano di sfondare mentre noi riceviamo l’ordine di schierarci su di una linea un poco arretrata per parare, dice “radio naja”, eventuali contrassalti del nemico. Approfitto della sosta momentanea per mettere un po’ d’ordine al reparto e per far rifocillare gli uomini che ne hanno tanto bisogno; io mi avvicino a quattro tedeschi che fanno colazione con le schiene appoggiate alle pareti di un’isba.
Hanno delle pagnotte e del salame sulle ginocchia mentre stringono tra le dita dei panini appena confezionati; con un cortese “bitte” faccio l’atto di prendere qualcosa: solo allora mi accorgo che quegli uomini così tranquillamente seduti sono morti stecchiti! Non hanno, almeno apparentemente, alcuna ferita ed il loro atteggiamento di accostare il cibo alla bocca non potrebbe essere più naturale. Arriva intanto nella mia direzione un piccolo reparto: è il comando della Divisione Julia con il generale Ricagno in testa che ci saluta affettuosamente.

Si riaccende il combattimento perché i russi avanzano e guadagnano terreno appoggiati dai carri armati, “radio naja” aveva ragione: la nuova linea si mostra ora utile. Il momento è emozionante, i pezzi da montagna sparano a zero ed in certi punti restano isolati; i carri non fanno ormai più grande impressione, vedo qualche ufficiale e qualche alpino salirvi sopra mentr’essi sono in moto e sparano. Il nemico viene ancora respinto, facciamo qualche prigioniero, per lo più giovanetti che combattono con grande accanimento.
I pezzi da montagna sono liberati, troviamo gli artiglieri che li difendevano con la baionetta e con le bombe a mano: un capitano ferito gravemente al ventre ci ringrazia. Mentre lo trasportano morente al posto di medicazione egli invoca un nome di donna, un nome tanto italiano. I russi si sono ora ritirati nel villaggio, mi passa vicino il capitano Giglioli, comandante la 71ª, che, ardimentoso e generoso come sempre, li aveva inseguiti. Gli è vicino il sottotenente Continenza che stringe qualcosa tra le mani: è una specie di periscopio ch’egli ha staccato dalla torretta di un carro russo.

Giglioli mi dice che Continenza fermava i carri salendovi sopra e che lo proporrà per la medaglia d’oro al valor militare. Cerchiamo di radunare gli uomini che restano, molti, troppi ne mancano travolti nel combattimento, nomi cari, nomi di valorosi che tutto hanno dato per la patria lontana. Ci ordinano di alleggerirci il più possibile: distruggiamo tutte le cose superflue compresi i nostri mortai da 81 resi ormai inservibili per la mancanza di munizioni; sulle poche slitte a disposizione non trasportiamo che i feriti e le armi automatiche.
Mentre ancora una volta le ombre della notte calano sul campo di battaglia illuminato tristemente da qualche incendio isolato e da razzi luminosi, la colonna si rimette in marcia nella neve profonda e farinosa. Procedere su quel terreno è estremamente duro e faticoso: il comandante di battaglione, capitano Rago, è triste e silenzioso, cammina a testa bassa e ordina ai pochissimi ufficiali rimasti di procedere per un tratto con lui. Gli diamo le “novità”, riceviamo qualche ordine mentre la colonna si allunga sulla pianura appena illuminata da una luna nascosta un poco tra le nubi.

Si cammina l’intera notte girando molto al largo di Nowo Postojalowka (la località della precedente battaglia) che lasciamo a sinistra illuminata da molti incendi e ci sganciamo dal nemico senza essere visti. Camminiamo fino all’alba, passiamo le poche ore di luce del giorno successivo in un bosco per riprendere la marcia quando cala la sera.
Ancora un combattimento durante la notte per aprirci la strada, mentre reparti tedeschi muovono sulla sinistra noi attacchiamo a destra, tutto viene questa volta risolto in breve tempo. E” anche troppo evidente ormai che siamo circondati e dentro ad una sacca: dovremo combattere non per avanzare ma per retrocedere, in guerra succedono anche di queste cose. Comunque il giorno successivo non ci fermiamo ma continuiamo a marciare, ora pesantemente per la neve troppo alta e farinosa, ora velocemente su neve crostosa o su qualche pista battuta.

La notte dal 22 al 23 gennaio ci trasciniamo ancora stanchi ma fiduciosi: la marcia è ora veloce, ci preoccupiamo solo di spronare quei soldati che si buttano fuori della pista e che, seduti sulla neve, si addormenterebbero per sempre. All’alba del 23 raggiungiamo un villaggio e subito siamo chiamati ad un rapporto dal comandante di reggimento. Il colonnello Cimolino ci ordina di ammazzare qualche mulo e di rifocillare i soldati, egli giudica di essere prossimi alle nostre linee e ci esorta ad avere ancora fiducia e coraggio.
Sarà invece quella l’ultima volta ch’io vedrò anche questo caro viso di fiero combattente ed i suoi occhi ardenti e paterni. I resti del nostro battaglione si accampano in qualche isba ai margini del villaggio; dopo aver mangiato qualcosa ci buttiamo affranti su della paglia addormentandoci quasi subito. Ma il nostro riposo sarà solo di poche ore. L’allarme delle sentinelle è subito seguito da un fragore infernale: sparano sul villaggio con cannoni e mitragliatrici mentre sbucano enormi carri armati da ogni parte.

Mai ne ho visti tanti; si buttano addosso alle case, schiacciano le slitte, travolgono muli e conducenti, rincorrono e sparano su chi tenta di fuggire. Con pochi alpini e qualche ufficiale ci buttiamo verso le isbe del comando ma siamo preceduti da altri carri; vedo Giglioli che ne affronta uno con la pistola spianata, buttiamo le ultime bottiglie di benzina sui cingoli di un altro, le fiamme non lo fermano.
Organizzare una qualsiasi resistenza è cosa veramente impossibile, succede una grande confusione ed io mi trovo, con pochi altri, vicino al mio comandante di compagnia ed al capitano Belletti. Con mille precauzioni ci allontaniamo da un gruppo di carri armati che ci gira attorno e, strisciando sulla neve mentre ci sparano da tutte le parti, ci buttiamo in un canaloncino fuori del villaggio.
Restiamo in cinque: Belletti, Carta, io e due alpini; il capitano si è presa una pallottola ad un ginocchio, lo fasciamo con un pacchetto di medicazioni, la ferita non è per fortuna molto grave. Decidiamo di aspettare la sera per tentare di allontanarci durante la notte, non abbiamo viveri ma possediamo una bussola, un parabellum russo, le nostre pistole e due coperte. All’imbrunire, con infinite precauzioni, usciamo dalla buca e, allontanandoci da una larga pista e dal villaggio prendiamo direzione ovest.

Fuori del villaggio troviamo il corpo del tenente Bianco, di Roma, steso sulla neve, morto da poco; gli prendiamo qualche documento mentre dal portafoglio esce una foto di una signora dai capelli bianchi, è la mamma lontana che ora lo aspetterà invano. Marciando per sette ore arriviamo ai piedi di una collina sulla quale c’è un piccolo villaggio che si presenta tranquillo e quasi ospitale. Propongo subito di allontanarci di corsa perché da mesi questi villaggi mi portano scalogna, ma stanchi ed affranti, veramente impossibilitati di proseguire in quelle condizioni decidiamo di entrare in una casa poco discosta per procurarci del cibo.
Ci accoglie una vecchia ringhiosa che sbraita un russo incomprensibile, fuori un cane si mette ad abbaiare insistentemente; divoriamo una zuppa di cavolo, mettiamo in una sporta del pane e qualche patata ed usciamo. Appena varcata la soglia una scarica di parabellum fischia per aria, contemporaneamente davanti e dietro a noi una trentina di uomini, già a pochi passi, ci prendono di mira con i fucili. Uno grida qualcosa in tedesco: il
cuore ci balza dentro al petto, per un attimo speriamo siano soldati germanici.

L’illusione dura poco: una scarica di parabellum ci consiglia di togliere le mani dalla pistola; non c’è scampo: siamo anche noi ormai prigionieri! Ci strappano di dosso armi ed orologi, che si contendono a cazzotti sulla neve, e con i fucili puntati sulla schiena ci avviano verso il centro del villaggio. Posso esaminare quegli individui: non hanno divise da soldati, uno di loro chiede chi di noi parla tedesco; mi faccio avanti e mentre i miei compagni sono condotti dentro ad un’isba io vengo introdotto in un’altra.
Attorno ad un tavolo stanno seduti degli uomini che mi interrogano su questioni di nessuna importanza a base di propaganda od altro, sono curiosi di sapere l’opinione di un ufficiale italiano sulla grande offensiva russa. Ciò mi schiarisce le idee e non ho alcuna difficoltà ad accontentarli; alla fine del colloquio credo di commuoverli offrendo a quello che ritenevo il capo l’unica cosa che mi era rimasta: la penna stilografica che serbavo all’interno della camicia.
Ma è come se tirassi fuori una bomba a mano, balzano in piedi con occhi terrorizzati mentre salta fuori il solito esperto che la esamina: la credevano una penna esplosiva! Poi mi spogliano quasi completamente lasciandomi in maniche di camicia ed, in quelle condizioni, mi fanno cenno di uscire. Istintivamente faccio per prendere la pelliccia ma una risata di tutti loro mi agghiaccia il cuore, non ho però ancora capito le loro vere intenzioni.

Vengo introdotto nella casa dove stanno i miei compagni che, a loro volta vengono spogliati; delle donne russe mi offrono gentilmente del pane; mentre una posa degli occhi tristi sul viso emaciato del capitano Belletti, intuisco che vorrebbero dirci qualcosa. Ora entrano nella stanza quattro giganteschi mongoli con dei meravigliosi occhi a mandorla che ci fanno cenno, con i fucili spianati, di uscire. Li accompagna il solito interprete armato di parabellum.
Non è certamente delizioso passare, in quelle condizioni, da una temperatura di venti gradi sopra zero ad una di trenta sotto, ci fanno camminare fuori del villaggio: credo ci portino in qualche casa o prigione quando, in mezzo alla neve, ci fanno fermare. Malmenandoci alquanto ci mettono uno in fianco all’altro poi passano dietro le nostre schiene ed a pochi passi ci prendono di mira con i fucili.
Semplicemente, alla maniera “russa”, stanno per fucilarci: splende una luna meravigliosa, sono le due e mezza circa del 24 gennaio 1943. Mirano alle nostre teste: la prima raffica colpisce Belletti che cade silenziosamente sulla neve mentre personalmente le pallottole mi fischiano vicino all’orecchio destro. In quel tragico istante il tenente Carta trova la presenza di spirito di slanciarsi di corsa in avanti, non perdo un attimo e lo seguo seguito da due alpini.

I russi, evidentemente sorpresi, ci fanno guadagnare qualche metro, poi nuove raffiche ci fischiano vicino mentre ci rotoliamo sulla neve giù per un piccolo canalone. Ci buttiamo fra degli arbusti che troviamo in basso e, seguendo quella copertura, tentiamo di risalire dall’altra parte. Però appena usciamo dalla copertura i nostri amici, che erano intanto spuntati sul margine della valletta, riprendono a spararci addosso: uno dei due alpini cade colpito da una raffica alla schiena mentre l’altro si ributta dentro al boschetto, invano richiamato.
Le pallottole si infilano nella neve, sprofondiamo fino alle ginocchia ed angosciosamente ci
sembra di non andare più avanti. Finalmente raggiungiamo il margine opposto e, su neve di nuovo dura, possiamo correre velocemente. Due russi ci inseguono ancora ma, ormai distanziati, rinunciano e si pèrdono nella notte: commossi ci inginocchiamo sulla neve e ringraziamo Iddio.
Carta è stato colpito alla mano ed a una coscia, la temperatura è tremenda e la camicia di flanella ci ripara solo in parte. Ci frizioniamo energicamente a vicenda e poi, aiutandoci con la stella polare, riprendiamo a correre verso ovest. Siamo sfuggiti alla fucilazione, dovremo ora vincere il gelo in quelle condizioni. Riusciamo a correre fino all’alba quando una raffica di vento ci porta il caratteristico rumore di una colonna in marcia.

Con emozione ci buttiamo in quella direzione ed arriviamo in vista di un reparto di truppe
tedesche ed italiane. Un ufficiale tedesco ci offre del cognac che tracanniamo mormorando in breve la nostra avventura. Contemporaneamente ai fianchi e davanti a noi compaiono numerosi carri armati russi che cominciano a sparare con tutte le armi. Siamo ancora in duro combattimento ma subito possiamo armarci e rivestirci con indumenti tedeschi ed italiani che troviamo addosso ai primi caduti.
Più e più volte tentiamo di sfondare lo sbarramento russo e finalmente riusciamo ad aprirci un varco verso ovest. Nella colonna ritroviamo nostri alpini, sfuggiti come noi all’accerchiamento del giorno avanti, che ci danno da mangiare. Siamo ancora con i nostri soldati e potremo ancora lottare dopo l’incredibile avventura. Carta, ferito e ormai dolorante, trova posto in una slitta di feriti, mentre quasi senza riposo, seguiamo le sorti ed il duro cammino di questa colonna formata da circa mille uomini e meravigliosamente comandata da un ufficiale tedesco che mi affida l’incarico di proteggere la marcia con pattuglie avanzate e scaglionate sui fianchi: pare di rinascere, di essere ritornati dei veri soldati!

Ritirata di Russia 1943
Mi accompagna un graduato tedesco molto coraggioso e cordiale. Durante una breve sosta vicino ad un fucile mitragliatore egli stacca un ramoscello da un arbusto che spunta dalla neve e mi mostra le gemme che pare stiano ingrossando: vuol dirmi che arriva la primavera. Ma la parola Frùhling gli resta nella gola: una pallottola lo colpisce in mezzo alla fronte, egli si accascia senza un lamento mentre alcuni uomini fuggono nel bosco.
Dopo quel triste pomeriggio non troviamo più carri russi, siamo sempre alle prese con partigiani che tentano continue imboscate e che ci seguono a cavallo. Il cammino è duro mentre la stanchezza di cinquanta giorni di lotta e di marcia si fa sentire. Alla sera del 28 gennaio, all’uscita da un bosco, troviamo ancora il nemico che ci attacca da tutte le parti e con tutte le armi. Sarà questo il combattimento più doloroso e più sanguinoso: mentre calano le prime ombre della sera dopo ore di lotta riusciamo ancora a passare.

Ma nella notte buia, con un freddo di oltre 40^ gradi, stanchi ed affranti perdiamo l’orientamento. La colonna si ferma mentre i feriti urlano e qualcuno impazzisce: un soldato tedesco si china sulla neve e ridendo disegna dei cerchi concentrici, poi lentamente si spoglia; non ho la forza di intervenire. Finalmente riprendiamo a marciare, troveremo più tardi un abitato dove possiamo riposare e un medico per curare i feriti.
L’alba del giorno successivo è piena di sole e di azzurro, areoplani ci buttano viveri e ci indicano la strada: camminiamo in questo sole, finalmente senza combattere, ancora per due giorni. Raggiungiamo Woltschansk ed una larga strada; su quella strada tutti ci mettiamo a correre disordinatamente: è il 31 gennaio 1943.
Caporal maggiore Elio Borgobello
20ª Compagnia, Battaglione Cividale, 8^ Reggimento Alpini
Durante i combattimenti sostenuti dal Battaglione Cividale sul Don, nell’inverno 1942-43, ho preso parte alla conquista della quota “Signal”, poi ribattezzata dagli stessi tedeschi quota “Cividale” data la decimazione che subì il reparto per entrarne in possesso, specie nei giorni 4-5 gennaio e seguenti fino al 16 dello stesso mese.
Voglio ricordare il capitano Dario Chiaradia da Caneva di Sacile (Udine), poi medaglia d’oro alla memoria, il quale era sempre alla testa del reparto, anche quando ufficiali subalterni lo pregavano di non esporsi troppo. Fu veramente un padre per noi della 20ª Compagnia. Con lui voglio ricordare anche il tenente Luigi Ansaldo da Genova, comandante del plotone mitraglieri di cui facevo parte, nonché il comandante di squadra (la Squadra Mitraglieri) caporal maggiore Gustavo Anzil da Collalto di Tarcento (Udine), veterano delle campagne di SpagnaAfricaAlbania e Grecia, medaglia d’argento alla memoria.
Il tenente Ansaldo e l’Anzil vennero colpiti dal fuoco nemico nel pomeriggio del 4 gennaio, mentre il capitano Chiaradia veniva colpito a morte il 5 successivo e decedeva all’ospedale di Rossosch. Con loro vorrei ricordare tutti gli altri compagni d’arme che su quella maledetta quota trovarono la morte, ma la lista sarebbe troppo lunga e incompleta.
Caduto l’Anzil venivo designato quale comandante dei superstiti della 1^ Squadra Mitraglieri, ed essendo anche il graduato più giovane, collocato coi miei fedeli compagni d’arme a poche decine di metri dalla cresta della quota conquistata a così duro prezzo. In tre buche scavate nella notte mi sistemai coi miei bravi compagni e con la nostra fedele Breda a difesa di quella collinetta fino al giorno 16 gennaio 1943, fino a quando cioè ci giunse l’ordine di ripiegare nel calanco, dove i resti del battaglione Cividale si erano già raggruppati e si stavano snodando in direzione di Golubaja Krinitza.

Due militari all’esterno di un rifugio militare in Russia nell’estate 1942
Sulle prime mi sembrava strano quell’ordine, ma, inviato un alpino a chiedere maggiori spiegazioni, questo ritornava assicurandomi che il gesticolare di altro militare a circa 150 metri da noi, identificato poi nel portaordini della 20ª, Ambrosini Bruno da Udine, significava proprio l’abbandono delle nostre postazioni. Fu così che, al calare delle tenebre, facemmo partire qualche raffica verso le postazioni nemiche, dopo di che, in fila, raggiungemmo il calanco, dove effettivamente i pochi ufficiali superstiti cercavano di inquadrare i propri uomini per compagnia, iniziando il ripiegamento.
Nel rioccupare la quota il 5 gennaio suddetto, ricordo che mentre eravamo sdraiati sulla neve in ordine sparso per sottrarci allo scoppio continuo dei colpi dell’artiglieria russa, si videro spuntare sulla nostra sinistra due carri armati che, per la loro direzione, ci lasciavano supporre essere russi. Per nostra fortuna erano invece due semoventi tedeschi che si trovavano seminterrati sul nostro fianco destro e che erano stati chiamati in appoggio per riconquistare la quota come infatti avvenne.
Ricordo pure l’unico pezzo d’artiglieria piazzato lungo il canalone che da Golubaja Krinitza conduceva alla quota: era un 88 tedesco che di tanto in tanto entrava in azione in appoggio alla nostra artiglieria ed era sistemato vicino ad un pagliaio dove gli inservienti s’erano scavati un profondo ricovero proprio sotto al pagliaio medesimo. Rammento anche che una sera colì allora tenente Antonio Ferrante di Ruffano e ai sottufficiali Bacco e Ferrari nonché all’amico Morandini Luciano da Tricesimo (Udine) si andò a prelevare un fucilone anticarro che si trovava a qualche centinaio di metri dalle nostre postazioni, riuscendo a portarlo nel nostro caposaldo o settore.

Altro ricordo è quello riguardante l’arrivo in linea di alcune casse contenenti bottiglie Molotov accatastate su una slitta, il cui conducente ci aveva fatto credere trattarsi di bottiglie di spumante per festeggiare il nuovo anno. Indimenticabile l’arrivo dei famosi “valenki” gli stivaletti di feltro in uso fra la popolazione e militari russi. Se fossero giunti prima chissà quanti di noi si sarebbero salvati dai congelamenti. Per la cronaca, chi scrive subì congelamenti di primo e secondo grado alle mani ed ai piedi.
Altri episodi potrei citare, ma non riesco ad elencarli in ordine di tempo. Il giorno 19 gennaio, giunta la colonna a Nowo Postojalowka, dovette arrestarsi perché era stato avvistato a distanza un forte contingente di truppa o partigiani russi dotati di molti automezzi e carri armati. Esaminata la delicata situazione, il bravo colonnello Cimolino, comandante l’8^ Reggimento Alpini, decideva di attendere il calare della notte per muoverci, aggirando il nemico a vasto raggio. I russi, stanchi di aspettare un nostro attacco che avrebbe significato una catastrofe per noi, coi mezzi a disposizione, si fecero vivi con due carri armati, uno medio e un T 34.
Appena scorti a distanza, una batteria alpina del Gruppo Conegliano, piazzò i pezzi pronti ad intervenire (alzo zero). L’ufficiale che impugnava una pistola e dava ordini ai suoi uomini, esortava questi ad attendere che i carri fossero vicinissimi prima di aprire il fuoco. Tutti obbedirono, ma al momento in cui ebbe inizio la sparatoria, ci si accorse che i proiettili non riuscivano a perforare le corazze ed i carri si sbizzarrirono a schiacciare i pezzi e a mitragliare gli inservienti e quanti si trovavano nei pressi.

Preparazione del rancio in un campo di aviazione della caccia e della ricognizione italiana in Russia nell’estate 1942
Io e i miei pochi superstiti: caporali Bruno Fant da Qualso di Reana (Udine), Giacomo Londero da Gemona (Udine), Guido Specogna da Torreano di Cividale (Udine) e Gino Pividori da Apralo di Attimis (Udine), venimmo invitati dall’ufficiale della batteria a schierarci fra i pezzi a difesa, con la nostra fedele Breda. Per puro caso riuscimmo a metterci in salvo coi superstiti artiglieri alla sommità d’un costone coperto da qualche sterpo e piante di quercia, dove intanto s’erano raggruppati molti feriti e slitte cariche di feriti.
Mentre il carro medio veniva in qualche modo messo fuori uso, il secondo, liquidata l’artiglieria, stava dirigendosi verso di noi che, con la Breda, nulla potevamo fare. All’improvviso, come per incanto, fra lo stupore di sani e malati, il bestione s’inclinò in avanti sprofondando nella neve. Infatti c’era un fosso della profondità forse di un metro e mezzo e il vento s’era divertito a riempirlo di neve. Il pilota tentò più volte di disincagliare il carro, ma accortosi che ogni manovra era inutile, desistette; l’equipaggio rimase inscatolato per molto tempo senza fiatare.
Noi del resto non avevamo né armi né infiammabili per costringere l’equipaggio ad uscire o per mettere fuori uso il carro armato. Sta di fatto che quei carristi russi si fecero sentire con diverse cannonate al nostro indirizzo, solo quando si resero conto che, approfittando delle tenebre ci eravamo incolonnati sulla pista per Nikolajewka: ferirono alcuni alpini e fra questi il Bruno Fant, che non rientrerà in patria.

Soldati della cavalleria Savoia in azione in Russia nella primavera 1942
Ancor oggi quando penso a quel carro sprofondato nella neve, immobile, stento a crederci. Se il mitragliere per caso avesse iniziato a falciarci con le mitraglie di bordo sarebbe certamente stata una strage. Ma suppongo che l’equipaggio abbia avuto a sua volta paura di noi e di eventuali mezzi offensivi a nostra disposizione capaci di mettere fuori uso il carro; cosa purtroppo che non avremmo comunque potuto fare. In quel combattimento rimase ferito fra i tanti il tenente Ermenegildo Moro, ora colonnello sempre degli alpini in quel di Udine.
L’ufficiale venne soccorso e caricato su una slitta e quindi poté mettersi in salvo, rientrando in patria. Qualche giorno dopo, a Nowo Georgiewka carri armati e fanterie autocarrate attaccavano la colonna che si era fermata per riposare e rifocillarsi con quello che si poteva trovare nelle isbe, e fecero prigioniero il bravo e valoroso colonnello Cimolino, tenente colonnello Zacchi, capitano Magnani nonché buona parte dei superstiti del Cividale e dell’8^.
In tale occasione ricordo che all’apparire dei carri presi con alcuni alpini una direzione a caso pur di sottrarci alla cattura. Fu veramente la via giusta. Mentre i carri continuavano a mitragliare e seminare desolazione e morte fra la colonna e gli alpini ancora sorpresi in mezzo alle isbe, raggiungevo una fossa profonda circa due metri e mi lasciai scivolare dentro. Dietro di me altri 6-7 alpini mi imitavano. Intanto si notava il carro più vicino a noi, circa 300 metri, forse meno, che stava costringendo un gruppo di alpini ad alzare le mani lasciando cadere nella neve le poche armi in loro possesso.

Il generale Giovanni Messe in Russia parla ad una truppa di bersaglieri nella primavera 1942
Caratteristica uscita dalla torretta del solito carrista che imbracciava l’altrettanto solito parabellum. I poveretti si incolonnarono dietro al carro e iniziarono la marcia alla rovescia, cioè verso la pista già percorsa. Intuivo che il rimanere in quella fossa avrebbe significato senz’altro la fine. Preferivo uscire all’aperto, aiutato in ciò dagli amici testardamente rimasti nella buca e, una volta fuori seguii le orme di un tedesco che si stava dirigendo verso un costone coperto parzialmente da sterpi e sottobosco.
L’impresa era veramente avventata, se si pensa che i russi, vedendoci, avrebbero avuto facile bersaglio a falciarci. Iniziammo comunque la salita del costone, soffermandoci ogni 5-6 passi a prender fiato e guardandoci pietosamente negli occhi senza parlare per evitare spreco di energie, e così facendo raggiungemmo la vetta del costone da dove aveva inizio una immensa pianura. Sulla nostra destra notavamo la coda del troncone di colonna sfuggito ai russi che si snodava verso Nikolajewka. Riuscimmo a raggiungerla e così proseguimmo l’avventura.
Ricordo che in quella buca rimasero due alpini della 20ª Compagnia certi Mini e Toso (credo cognati) da Udine o dintorni, ed altri cui non ricordo i nomi. Non mi risulta che siano rientrati in Italia. Se la fortuna aiuta gli audaci, devo proprio autorizzarmi a dire che ho avuto una bella sfrontatezza ad uscire da quella fossa, coi piedi fasciati e senza scarpe, ed intraprendere quella marcia che mi portò alla salvezza. Quando ci penso ancor oggi non riesco a convincermi d’averlo fatto. In sèguito potei ancora riagganciarmi ai miei pochi superstiti ed altri alpini del Cividale e fra questi: Pio Giorgiutti da Savorgnano del Torre (Udine), Visentini da Povoletto (Udine) e il caporal maggiore Giuseppe Perco da Laipacco d’Udine.

Il buon Giuseppe Perco ricordo che più volte mi cambiò le pezze che portavo ai piedi, consumatesi nell’arrancare sulla neve. Grazie a lui potei trovare la forza più d’una volta di rimettermi in piedi e riprendere la marcia, quando ormai ero deciso a smetterla e lasciarmi andare sdraiandomi nella neve ad aspettare la fine. Una sera, prima di giungere a Nikolajewka, mentre col Perco mi trovavo dentro una stalla dove c’erano una mucca ed una vitella, ricordo che ci togliemmo i guanti e restammo forse più di un’ora a scaldarci le mani appoggiandole sul corpo delle due bestie.
Ad un tratto l’isba accanto alla stalla, dove s’erano ammassati forse un centinaio di soldati fra italiani e tedeschi, prese fuoco. Anche noi fummo costretti ad allontanarci in fretta. Ricordo che m’ero slacciato anche le pezze ai piedi, e dovetti camminare scalzo al fianco del mio fedele amico per un bel tratto prima di poter reperire due maniche di cappotto per rimpiazzare quegli stracci rimasti in quella stalla. Intanto dall’isba si vedevano uscire militari urlanti, alcuni con le fiamme addosso che poi si rotolavano nella neve per spegnerle, ma diversi finirono bruciati.

In elegante divisa bianco-nera, il Prefetto Foschi saluta gli alpini che in carro merci partono per la Russia. Molti non ritorneranno
Intanto l’isba era divenuta un braciere e si udivano gli schioppettii delle pallottole e bombe che i soldati avevano nei loro tascapani o tasche. Dopo di ciò, rammento che mentre la colonna stava snodandosi in vista di un paese, da un campanile dove era stata piazzata una mitragliatrice, partivano nutrite scariche contro di noi che fummo costretti a deviare la marcia di vari chilometri. Intanto giungemmo in vista di Nikolajewka. Ammassamento imponente di colonne affiancate, tedeschi, italiani, romeni, ungheresi, eccetera.
La ferrovia. Il passaggio d’un semovente con sopra in piedi due o tre uomini in tuta bianca: tedeschi. Fra di essi si trovava però anche il valoroso generale Reverberi, che ci esortò ad attaccare per entrare in Nikolajewka presidiata da forze militari e partigiani russi. Solo al calare della sera ciò fu possibile. Ricordo che pernottammo in un’isba e, la mattina successiva in marcia, faceva ancora buio. Si udivano già crepitare raffiche di mitraglia o parabellum, i russi erano già alle nostre calcagna.
Dopo un paio di giorni ricordo che lungo la pista per la prima volta incontrammo automezzi italiani; venivano in nostro aiuto per trasportare a Karkow i feriti ed i congelati più gravi. Venni fatto salire su uno di questi mezzi e raggiunsi Karkow assieme agli amici Visentini e Giorgiutti, mentre con Giuseppe Perco avevo perso il contatto a sèguito d’un mitragliamento aereo da parte di “Mosquitos” con la stella rossa, soliti attaccare la colonna a bassa quota.

Per la prima volta ci venne somministrato un mestolo di brodo ed un pezzetto di cioccolata. Vennero fatte delle medicazioni di fortuna. Intanto nella notte si udivano gli schianti dei bombardamenti aerei russi. Un cappellano militare ci disse che se fossimo stati in grado di farcela, avremmo potuto raggiungere la stazione con mezzi tedeschi, e da qui salire in treno per l’Italia. Partimmo senza esitazione. Ci portarono in Polonia, a BrestLitowsk. Credo 6-8 giorni di sosta, e poi con un treno merci in Italia.
Alpino Giacomo Mussi
Battaglione L’Aquila, 9^ Reggimento Alpini
Sono un alpino trentino della Divisione Julia, che ha seguito la ritirata con la Divisione Tridentina, quale addetto ai servizi logistici di Pobendiskaja (capitani D’Egidio e Robotti), partecipando al combattimento di Opyt, dove nel parapiglia rimanemmo in pochi. Il 25 gennaio 1943 a Nikitowka sulla collina di Arnautowo venne distrutta la 33ª Batteria del Gruppo Bergamo; prima del ponte maledetto rimase ferito un alpino abruzzese, Santini (agli arti inferiori); rimasti soli lo portai oltre la collina nella piana prima di Nikolajewka, dove venni ferito anch’io da schegge di spezzone e dovetti abbandonarlo caricandolo su di un mulo e lo affidai ad un sottufficiale del 2^ Artiglieria; da allora non ebbi più notizie.

Desidererei, se vivo, conoscere la sua sorte. Del nostro gruppo, dopo Nikolajewka a Bielgorod, trovai il tenente Prisco, Vitalesta e Fossati che mi curarono e fui ricoverato nel 4 Ospedale di riserva di Karkow. Con essi ricordo i cari amici bergamaschi Albino e Pietro Cappelli ed altri amici abruzzesi coi quali per quattro anni abbiamo vissuto tutta la guerra,
dall’Albania alla Russia (D’Addario, Sforza Cinfrini e tanti altri) e tutti gli sventurati caduti.


