a cura di Cornelio Galas
Fonte: Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Scienze Politiche. Titolo Tesi: “La campagna di Russia (C.S.I.R.- A.R.M.I.R. 1941-1943) nella memorialistica italiana del dopoguerra”. Anno accademico 1999-2000.
Italiani e tedeschi
Hitler aveva preparato l’invasione dell’ Unione Sovietica in gran segreto ed era riuscito a cogliere impreparato tanto il suo nemico quanto l’alleato italiano che era stato tenuto all’oscuro di tutto fino all’ultimo momento. La scarsa considerazione tedesca irritò notevolmente Mussolini, che non si aspettava certo di essere escluso dalla crociata antibolscevica.

Immediatamente furono iniziati i preparativi per allestire un contingente italiano da spedire in Russia. Tale iniziativa non venne apprezzata dall’alleato nazista, lo stesso Hitler, in risposta alle pressioni di Mussolini, rimarcò come lo sforzo bellico italiano dovesse essere indirizzato verso la guerra in Africa e nel Mediterraneo, non c’era bisogno dell’aiuto italiano in Russia. E d’altronde quanto poteva essere decisivo un corpo di spedizione in un confronto che vedeva schierati milioni di uomini?
La presenza italiana, quindi, era appena sopportata, ancor prima che si concretizzasse. Il ruolo del C.S.I.R. all’interno della macchina militare tedesca era così segnato fin dall’inizio: nonostante gli sforzi di Messe si trattava di operare non al fianco degli alleati, ma alle loro dipendenze. E questo non solamente per l’esiguo numero del contingente in rapporto alle forze della Wehrmacht, ma anche per la sua scarsa autonomia in fatto di approvvigionamenti e mobilità, per le quali si era alla totale mercé dei tedeschi.

Fin dall’inizio le autorità germaniche palesarono lo stato di subordinazione delle esigenze italiane alle loro, soddisfacendo solo in minima parte le richieste dei comandi italiani. Anche lo sfruttamento delle risorse locali era di totale competenza dell’amministrazione tedesca, gli italiani dovevano arrangiarsi con le loro risorse e con le briciole lasciate dall’alleato.
Sullo stato di frustrazione dei nostri servizi è interessante lo stralcio di questo fonogramma cifrato dell’intendenza: “Autorità tedesca cerca tutti modi controllare et dove possibile impadronirsi nostra organizzazione et limitare mia libertà azione modo et forma intollerabili et inconciliabili nostro prestigio alt”.
Le marce forzate per raggiungere dall’Italia le zone operative in Russia divennero un vero e proprio calvario per i soldati italiani costretti, per l’assenza di treni, automezzi e carburante, a percorrere centinaia di chilometri a piedi nelle polverose steppe russe. Una volta a contatto con il nemico ci si aspettava un utilizzo unitario del contingente, che invece veniva spezzettato in unità minori a piena disposizione delle esigenze e sotto l’autorità tedesca.

Naturalmente quando tutte le divisioni italiane furono finalmente riunite tornarono a costituire un corpo omogeneo sotto il comando italiano, ma per tutta la durata della campagna si verificarono problemi di subordinazione. Le esigenze belliche possono talvolta costringere le unità a dipendere da altri comandi, e ciò accadeva sia per le unità italiane che per quelle tedesche, anch’esse talvolta assegnate a comandi italiani.
Ma la reciprocità era solamente apparente perché, mentre la dipendenza italiana doveva essere integrale e assoluta, le unità tedesche, e non solo divisioni, ma anche singoli gruppi autonomi, quando lo ritenevano opportuno disobbedivano alle richieste e si rivolgevano direttamente al loro comando d’origine. Questo stato di cose favoriva lo sfruttamento delle risorse altrui senza tanta preoccupazione per le condizioni nelle quali versava l’alleato.

I comandi italiani erano poi costretti a operare alle dipendenze di quelli tedeschi, senza neppure essere messi a conoscenza del quadro complessivo della situazione militare nella quale si trovavano. La presunzione di superiorità dalle autorità naziste si trasferiva facilmente fino ai livelli più bassi raggiungendo i soldati che non perdevano occasione di manifestare orgogliosamente la loro tracotanza.
Con tali premesse è possibile comprendere la naturalezza con la quale venne sacrificato il contingente alpino sul Don al fine di permettere alle unità tedesche un più rapido ripiegamento. Il Corpo d’Armata alpino era stato parzialmente coinvolto negli scontri che nel dicembre del 1942 avevano prodotto l’accerchiamento di Stalingrado e lo sfondamento della linea del Don in diversi punti.

Le sue unità vennero utilizzate per tamponare alcune falle e rimasero in linea quando già da tempo altre unità dell’esercito italiano erano in ritirata e mentre quelle russe penetravano in profondità nel territorio. Quando l’esercito sovietico ruppe il fronte anche a nord del corpo alpino, dove si trovavano gli ungheresi, sarebbe stato necessario ordinare il ripiegamento per evitare che gli alpini (e la divisione Vicenza) si ritrovassero completamente isolati e chiusi dentro ad una sacca di grandi dimensioni.
Per più giorni le unità russe poterono liberamente operare alle spalle degli inconsapevoli italiani prima che, la sera del giorno diciassette gennaio, fosse ordinato il ripiegamento dalle autorità tedesche.

“E’ evidente che gli alti comandi tedeschi pensarono di rallentare ed intralciare l’avanzata dei sovietici lasciandosi alle spalle, indietro di giornate di marcia, le divisioni italiane, due delle quali ancora fresche ed integre, ma sprovviste di mezzi di trasporto veloci. E’ dunque sicuro che coloro che soltanto il diciassette gennaio ordinarono agli alpini di iniziare la ritirata, non potevano non essere consapevoli di emanare una sentenza di morte… Chissà se gli alti comandi tedeschi si sarebbero comportati allo stesso modo con truppe proprie… Io dico di sì… Solo che tra noi e loro scelsero noi a far da carne da cannone per rallentare l’avanzata sovietica”.
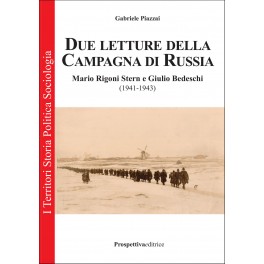
Considerazioni amare sulle responsabilità del ritardo con il quale si permise agli italiani di iniziare il ripiegamento sono espresse da più autori, che concordano sul fatto che anche solamente ventiquattro ore sarebbero state sufficienti ad evitare quell’immane calvario che fu la ritirata del corpo alpino. La poca stima e la scorrettezza dell’alleato nei confronti degli italiani si manifestò anche al momento di individuare le responsabilità dello sfaldamento del fronte del Don.
Una scarsa considerazione del valore del soldato italiano era diffusa a tutti i livelli presso l’esercito tedesco, ne d’altronde erano bastate le belle prove fornite fino al momento della disfatta a far mutare tale atteggiamento. Nell’agosto del 1942, ad esempio, un reggimento della divisione Sforzesca era stato costretta dai russi ad una rapida ritirata dalle posizioni tenute. Senza dubbio alcuno sulla consistenza dell’attacco subito, l’intera divisione fu immediatamente ribattezzata cicai, cioè scappa.

Ad ogni modo dubbi sull’efficienza della preparazione dei soldati, non soltanto in termini di materiali, venivano espresse anche dai comandi italiani.
“Quale Generale debbo invece con tutta franchezza dire che quanto ho veduto nei passati giorni mi ha fornito la riprova della insufficiente preparazione dei nostri soldati alla guerra. Anche la maggior parte dei quadri hanno dimostrato la loro imperizia, la loro impreparazione morale e tecnica a saper far fronte agli eventi nei momenti difficili”.

La linea del Don aveva il fondamentale compito di fornire la copertura del fianco sinistro alle armate tedesche impegnate nella battaglia per Stalingrado. La difesa del fiume era stata affidata, dai comandi tedeschi, alle forze alleate, italiani, rumeni, ungheresi, con l’ausilio di alcune divisioni tedesche.
La necessità di alimentare la fornace di Stalingrado aveva però via via ridotto il numero degli effettivi disposti alla protezione del fianco. Inoltre, sempre per volontà tedesca, era stata utilizzata una difesa “lineare” lungo tutto il corso del Don, disposizione questa che, dato l’esiguo numero delle forze a disposizione, non consentiva il mantenimento di unità di riserva disposte alle spalle del fronte ed in grado di intervenire dove fosse stato necessario.

I comandi italiani consapevoli di questa situazione avevano proposto, senza però la necessaria fermezza, una difesa “per capisaldi” meno rigida e più prudente. Ma i tedeschi erano oramai convinti di aver ottenuto il successo definitivo, Hitler aveva annunciato la prematura caduta di Stalingrado, non c’era bisogno di preoccuparsi tanto di un nemico già sconfitto.
“Quando si perde, si è sempre portati a cercare un colpevole. Di chi la colpa? Ma della Sforzesca, che nel giro di 24 ore aveva abbandonato completamente la riva del Don. Non si accettò la realtà e si disse che la Sforzesca era fuggita. La nostra “greca” (i comandi nel gergo militare) fu incapace di difenderla, anzi fu la prima, pur essendo stata sempre lontana dal vivo della battaglia, ad accusarla di viltà”.

L’esercito russo, tutt’altro che sconfitto, stava invece preparando la sua rivincita concentrando grandi quantità di truppe alle spalle del Don. Le prime ad essere travolte furono le truppe rumene, poi via via toccò a tutte le altre. La storiografia tedesca, e non solo, tende ad addossare le cause della sconfitta sulle spalle degli alleati, colpevoli di essersi fatti travolgere senza opporre una adeguata resistenza.
E d’altro canto questo fu l’atteggiamento delle autorità militari naziste anche durante lo svolgersi degli eventi. Neanche dopo la fine della guerra, quando si venne a conoscenza della sproporzione delle truppe che si fronteggiavano, venne mutata tale convinzione. Era difficile per un esercito sempre vittorioso come quello tedesco riconoscere i propri errori e le proprie responsabilità, molto più facile era addossare le colpe alla riconosciuta “vigliaccheria” degli alleati.

“Comme vous pouvez constater, mi fece notare con un sorriso ironico, i tedeschi sopportano il peso della lotta. I vostri soldati non combattono. Essi non tirano. Si ritirano. Per me fu come uno schiaffo… Non gli risparmiai una secca replica. Come avete già constatato, nel nostro settore i russi non sono passati. Al contrario, la vostra divisione sul Bogucar ha ripiegato e ha fatto la riverenza al nemico.
Ecco la conseguenza. Incalzai sempre più adirato: Il vostro alto comando ha smarrito lo schiaccianoci? Per quanto ci riguarda, l’ordine di ripiegamento ci ha raggiunto mentre eravamo sulla linea del Don. Noi non abbiamo fatto la riverenza al nemico… Lo mandai al diavolo”.

L’ufficiale tedesco con il quale Bellini ebbe questa accesa discussione apparteneva alla 298° divisione tedesca che durante le concitate fasi dell’attacco sovietico di dicembre, schierata al fianco degli italiani, dopo avere con varie scuse rifiutato di intervenire in aiuto dell’alleato, iniziò la sua ritirata senza alcun preavviso e senza che gli fosse stato ordinato dai comandi italiani dai quali in quel momento dipendeva.
La reazione ad un tale atteggiamento da parte delle autorità e della storiografia tedesca coinvolge naturalmente anche la memorialistica italiana, i cui autori, pur riconoscendo la scarsezza dell’equipaggiamento, tengono a rimarcare l’atteggiamento combattivo e valoroso del soldato italiano nella campagna di Russia. Valore peraltro riconosciuto dalle stesse autorità sovietiche che in un bollettino ufficiale asserirono come solamente il Corpo d’Armata alpino possa considerarsi imbattuto durante la campagna di Russia.

L’incontro con l’alleato
Il primo approccio con la mentalità e il modo di comportarsi dell’alleato, gli italiani lo ebbero ancora prima di raggiungere la Russia, mentre attraversavano i paesi dell’est Europa. Quando le tradotte militari sostavano nelle stazioni i soldati ebbero modo di incontrare i prigionieri ebrei che lavoravano guardati a vista da guardie tedesche.
Si è già rilevato come in Italia non si avesse una precisa percezione di quello che stava accadendo alle popolazioni di origine ebraica ad opera delle autorità naziste, l’incontro con tale inaspettata realtà impressionò molto i soldati italiani.

“Molti ebrei, uomini e donne, tutti con la stella gialla sul petto e sulla schiena, vagano lungo i binari: scalzi e cenciosi, passando da una tradotta all’altra, trascinano un secchio ed una scopa. Devono raccogliere le immondizie che le tradotte seminano nelle stazioni. Fingono di lavorare, come cani affamati chiedono pane e minestra. La fame e gli stenti li hanno inebetiti. Visi malati, stanchi, rassegnati: occhi pieni di fame. Alcuni bambini hanno forse sei anni… Provo pena e nausea. Quasi tutti gli alpini guardano perplessi: guardano, non capiscono”.
Era difficile comprendere come fosse possibile degradare degli esseri umani fino al punto da togliergli oltre alla dignità, anche la voglia di vivere. L’ufficiale alpino Cristoforo Negri Moscioni stava chiacchierando con un tenente medico mentre il treno stava giungendo alla stazione di Varsavia. All’improvviso il medico con un grido strozzato saltò giù dalla tradotta ancora in movimento per raggiungere un gruppo di ragazze ebree intente al lavoro.

“Il medico mi raccontò brevemente che si erano laureati insieme a Bologna poi lei era tornata a casa sua, a Varsavia, e non l’aveva più vista. Anche gli altri ufficiali giovani erano accorsi e ci demmo da fare a raccogliere viveri e denaro per aiutarla. Ma lei rifiutò dicendo grazie – sarebbe peggio perché mi attaccherei ancora alla vita; fra quindici giorni o un mese morirò lentamente di fame, è meglio così –”.
Rimasero tutti senza parole, quando un colonnello che aveva assistito alla scena li redarguì perché: “in presenza dell’alleato tedesco noi ufficiali ci eravamo abbassati a parlare con una donna ebrea e non sentivamo la dignità della razza e del grado”.

Anche Teodorico Cuzzolin racconta del suo incontro con prigionieri ebrei:
“Vidi molti ebrei, che con un grande numero dietro la schiena erano adibiti ai lavori forzati, comandati dai tedeschi. Di quella povera gente, ormai ridotta a sola pelle e ossa, costretta a finire i suoi ultimi giorni sotto la frusta, trattata peggio delle bestie e quasi senza mangiare, non me ne scorderò più!
Noi, che dovevamo andare a combattere fianco a fianco coi tedeschi, dopo aver visto ciò, non eravamo troppo contenti di proseguire il viaggio […] In Russia assistetti ad altre barbarie commesse da loro: una decina di ebrei fra donne e bambini, dopo essersi scavata una fossa, lunga sei metri e profonda due, costretti dai tedeschi, entravano per essere uccisi con armi automatiche. I tedeschi, dopo aver scaricato le armi su quei miseri, costringevano altri ebrei a riempire le buche di terra […] e queste barbarie continuavano fino a che non avevano eliminato tutti”.

Lo stupore procurato dalla vista del trattamento sprezzante riservato agli ebrei produceva, nei soldati italiani, un moto di solidarietà umana che risultava sgradito e incomprensibile agli occhi del superbo alleato e di chi ne ricercava la benevolenza. In tal modo iniziava a prodursi quel distacco profondo tra le due mentalità che in breve tempo avrebbe cancellato quel poco di ammirazione e stima che l’esercito tedesco si era procurato.
“Quando lungo i binari della ferrovia, videro le donne ebree, con i bambini attaccati alle gonne, costrette a lavorare sotto la sorveglianza di sentinelle armate, furono dapprima stupiti, poi commossi, infine offesi…Istintivamente gareggiano nel porgere qualche galletta alle sventurate e ai loro pargoli. Immediata la replica delle sentinelle che esplodono alcuni colpi in aria. Ci vuol poco per far saltare la mosca al naso ad un alpino; gli apprezzamenti nei riguardi degli alleati investono la decima generazione, qualcuno imbraccia il fucile. Ci sarebbe voluto del bello e del buono per calmarli”.

Anche Mario Tognato scrive:
“Corpi macilenti, coperti alla meno peggio con luridi stracci sui quali non mancava mai la tragica stella a sei punte con la JU nel mezzo, visi cerei sui quali formavano macchia gli occhi senza espressione. Ricordo una giovinetta, di forse sedici anni, che si fermò a guardare, mentre il nostro treno le passava accanto, un alpino che sbocconcellava una pagnotta. Da un bagliore improvviso in quel visetto tragico, il nostro alpino intuì la sua fame drammatica e le buttò la pagnotta, subito raccolta con felina rapidità. Immediatamente un soldato tedesco le fu sopra colpendola selvaggiamente con il calcio del fucile mentre un altro le rigava le carni con lo scudiscio”.
L’impressione suscitata dalla condizione degli ebrei nei territori occupati dai nazisti deve essere stata molto forte. Episodi riguardanti il trattamento dei prigionieri e della popolazione di origine ebraica sono presenti in quasi tutti i testi della memorialistica presi in esame. La differente mentalità dell’alleato ed il conseguente distacco da questa comincia a manifestarsi proprio a partire dalla differente maniera con la quale gli italiani percepiscono “il diverso”, in questo caso gli ebrei, e da come si entra in relazione con questo.

Nonostante alcune spregevoli eccezioni la questione razziale non era minimamente sentita tra i soldati del contingente italiano, la brutalità gratuita e manifesta con la quale il nazismo perseguitava le cosiddette “razze inferiori”, oltre a riuscire incomprensibile, procurava un vero e proprio risentimento nei confronti dell’alleato. Ancor prima che si entrasse in contatto si era quindi già scavato un solco, destinato a crescere col tempo, tra le due nazionalità legate più da accordi a tavolino che da affinità caratteriali.
La solidarietà degli italiani nei confronti delle sofferenze patite dagli ebrei, ebbe modo di manifestarsi anche in azioni concrete. L’episodio narrato nel libro di Elio Conighi e Gino Callin, e che vide tra i protagonisti anche il già ricordato don Carlo Gnocchi, merita di essere ricordato.

Questa volta la tradotta stava compiendo il viaggio di ritorno, riportava a casa gli alpini scampati alla disastrosa ritirata. Durante una sosta alcuni alpini notano delle donne ebree che lavoravano con piccone e badile, sotto la stretta sorveglianza delle sentinelle.
”Povere diavole, fanno una pena profonda. Un’occhiata: la sentinella più vicina ha una espressione piuttosto stolida. C’è un movimento, un pò di confusione tra chi sale e chi scende. Il treno riparte. – Sior tenente avemo caricado due done a bordo -. Il sottotenente Renzo Mondini e don Carlo Gnocchi si mettono le mani nei capelli. – Disgraziati! – . Il tono non è molto convincente, – stì lazzaroni – meriterebbero una medaglia”.

Alla prima stazione i tedeschi bloccano il treno ma il sottotenente Mondini è un uomo di fantasia ed ha già pronta una valida storiella. Si dirige con marzialità dall’ufficiale tedesco che comanda il reparto, e gli racconta di aver notato durante la sosta precedente due donne fuggire verso il bosco, avrebbe voluto dare l’allarme, ma proprio in quel momento il treno era ripartito.
“Il tedesco abbozza, richiama i suoi uomini. Si riparte: Mondini suda, don Gnocchi alza gli occhi al cielo, gli alpini sghignazzano divertiti”.

Le due ragazze camuffate da vestiti alpini arriveranno fino a Udine, dove una generosa famiglia contadina, intenerita, offrirà loro ospitalità. I rapporti con i tedeschi non furono quindi facili fin dall’inizio. L’atteggiamento sprezzante con il quale spesso gli alleati si rivolgevano agli italiani, considerati un pò come il parente povero di questa guerra, contribuiva ad ampliare quel divario che si era aperto con la conoscenza del loro modo di trattare i civili.
Anche nella quotidianità dei rapporti che si sviluppavano nelle retrovie, non erano infrequenti i momenti di tensione tra “camerati”. Naturalmente in tutto questo aveva il suo peso anche l’orgoglio nazionale spesso messo in competizione, anche in “fraterne” gare sportive dove alla fine si potevano contare numerosi i contusi.

“I nostri furieri di alloggiamento, che ci hanno preceduti di un giorno, raccontano: – Dove ci accamperemo, troveremo alcuni reparti tedeschi. I bersaglieri, accampati precedentemente nel bosco ora assegnato a noi alpini, avrebbero accoppato quattro tugnìn (tedeschi) per farsi rispettare. Basta fingere di non capire o sentire le parole d’ordini: si spara nel buio, ed allora non fanno più i prepotenti -. Gli alpini non si stupiscono affatto: alcuni promettono di dare dei punti ai bersaglieri!…Sentiamo di essere degli intrusi, sia nei confronti dei russi che dei tedeschi!”.
Le violenze tedesche si rivolgevano tanto agli ebrei quanto ai civili russi, e l’effetto sugli italiani era sempre lo stesso. Corti Eugenio:
“Nella casa c’erano donne, ragazze e bambini; il tedesco aveva scelto dal gruppo – che terrorizzato stava in un angolo – la ragazza più bella, e aveva fatto uscire gli altri. Appena fuori della porta, li aveva uccisi tutti, bambini compresi, con alcune raffiche di mitragliatore. Rientrato, aveva buttata la giovane sul letto e l’aveva violentata, invitando l’italiano a fare altrettanto.

Il nostro soldato aveva risposto con un gesto di diniego: desiderava solo rimanere nella casa al caldo. Il tedesco si era fatto preparare da mangiare dalla povera ragazza, poi l’aveva obbligata a dormirgli accanto durante la notte, violentandola altre tre volte. La mattina dopo l’aveva cacciata di casa: appena essa era stata oltre la soglia, l’aveva abbattuta con un improvviso colpo di pistola. Quante volte anche noi avevamo dovuto subire la bestialità dei nostri alleati!”.
E in fondo gli italiani erano per i tedeschi degli intrusi. Mussolini era riuscito, non senza sforzi, a far accettare ad Hitler la partecipazione italiana alla crociata contro il comunismo, ma l’impreparazione e lo scarso equipaggiamento rendevano il contingente italiano agli occhi dell’alleato più un peso che un aiuto. Queste considerazioni che erano espresse nelle alte gerarchie dell’esercito tedesco venivano percepite anche ai livelli più bassi, dove i soldati non perdevano occasione per dileggiare le truppe italiane.

Negli italiani si insinuava così un sentimento di rivalsa nei confronti di questo borioso e infallibile alleato, anche il Duce aveva dimostrato una malcelata soddisfazione di fronte alle prime batoste subite dalla Wehrmacht. Oltre alla difesa dell’orgoglio nazionale e alla superbia nei comportamenti, un altro elemento contribuiva a dividere gli alleati: i buoni rapporti che istintivamente gli italiani riuscivano a creare con le popolazioni russe erano motivo di gelosia da parte dei tedeschi.
Il divario cresceva mano a mano che si approfondiva la conoscenza reciproca.
“Due volte alla settimana i soldati andavano a Pawlograd a fare la doccia in un bagno pubblico requisito dai tedeschi: i nostri alleati ci fecero subito capire che non gradivano la presenza degli italiani e questi, da parte loro, reagivano spesso alle provocazioni, facendo volare qualche ceffone. Un giorno fui io ad essere incaricato di accompagnare al bagno un gruppo di soldati: stavo aspettando… quando intesi il rumore di una rissa provenire dall’interno e subito dopo vidi catapultare sulla strada una dozzina di tedeschi completamente nudi.

Dovetti convenire che gli alleati, in costume adamitico, non avevano più quel piglio altezzoso da superuomini che li caratterizzava quando indossavano la divisa. Gli italiani chiusero loro la porta in faccia e i tedeschi rimasero ad aspettare, rassegnati, sulla via, finché non arrivò in loro soccorso un reparto della feldgendarmerie, che li sottrasse agli sguardi divertiti dei passanti russi. Tra noi e i tedeschi non correva buon sangue”.
I tedeschi non erano gli unici alleati con i quali gli italiani si trovarono a convivere. Sopratutto durante il periodo in cui l’A.R.M.I.R. era schierato sul Don, e durante la seguente ritirata, fu possibile stringere contatti con i rumeni e gli ungheresi. Le poche testimonianze riguardanti i rapporti con le altre nazionalità, in particolar modo con i rumeni, rivelano da una parte come l’atteggiamento sprezzante dei tedeschi non fosse rivolto esclusivamente agli italiani, e dall’altra come fosse possibile mantenere rapporti di schietta cordialità e correttezza.

“Anche i rumeni usavano con i nostri la stessa fraternità che era tra essi…all’inizio dell’offensiva russa, come per un tacito accordo, tutti, si erano messi in marcia. Na dom (a casa) era la loro parola d’ordine. I tedeschi li cacciavano dalle piste, rovesciavano le loro carrette e le loro slitte. Essi si raddrizzavano e si portavano sui bordi delle strade, si raggruppavano e procedevano. Na dom!”.
La secolare amicizia tra Italia e Romania traspariva dai rari incontri, nei quali entrambi gli alleati dimostravano la reciproca stima e una cordialità difficilmente riservata ai commilitoni tedeschi.
“I romeni erano esasperati dal trattamento dei tedeschi. Il comandante di divisione lamentava di essere stato costretto ad abbandonare la sua macchina perché gli era stata rifiutata un pò di benzina… pur avendo la gamba ferita e dolorante. Sembrava che i tedeschi gli avessero perfino negata un’autoambulanza per i feriti. Questo stato di esasperazione era diffuso… contro i tedeschi, accusati di essere sprezzanti, egoisti, e di voler ingiustamente scaricare sugli alleati la colpa della disastrosa ritirata in corso”.
Evidentemente gli indottrinamenti del nazismo sulla supremazia della razza ariana, destinata a prevalere su tutte, erano penetrati a fondo nell’animo dei soldati tedeschi. La convinzione che nessuno avesse il diritto o le capacità di essere al loro livello coinvolgeva tanto il nemico quanto l’alleato: non era più una questione di appartenenza ad uno o all’altro schieramento, era la diversità, il non essere tedesco, il non appartenere alla razza eletta, che degradava immediatamente ad una condizione di inferiorità che legittimava qualsiasi tipo di angheria.


