a cura di Cornelio Galas
Non finisce tutto dopo le fucilazioni a Corfù e Cefalonia. C’è il dramma dei sopravvissuti e una giustizia. post-bellica, che deve fare i conti con patti, non scritti, di “non belligeranza”: tu non processi i miei, io non processo i tuoi …
di Carlo Palumbo
LA VICENDA DEI SOPRAVVISSUTI
Deportazione e internamento
I militari italiani sopravvissuti a Cefalonia, dopo essere stati trattati con molta durezza nei primi giorni dai loro carcerieri,sono gradualmente trasferiti nel campo di concentramento di Atene e da qui avviati verso i campi di lavoro forzato in Europa centrale.
Il trasferimento sul continente avviene in condizioni estremamente precarie e di forte pericolo per i prigionieri trasportati senza rispettare alcuna norma di sicurezza, per decisione esplicita dei comandi tedeschi.Gli incidenti che si verificano alle navi trasporto nelle settimane successive sembrano, in un certo senso, quasi voluti.
Il 28 settembre il piroscafo Ardena fa a finire contro una mina e affonda poco a sud del porto di Argostoli. Si salvano i60 tedeschi di scorta, ma solo 120 degli 840 prigionieri accalcati nelle stive.Il 13 ottobre affonda il piroscafo Marguerita, sempre a causa di una mina, ma in alto mare; muoiono 544 prigionieri sui900 imbarcati, oltre a 5 tedeschi.
Tra il 13 ottobre e il 2 novembre quattro piroscafi riescono a raggiungere il porto di Atene, trasportando circa 4.500 prigionieri.Altri 102 sono trasferiti prima della fine di dicembre a bordo di due motovelieri. Poi, il 6 gennaio 1944, avviene l’affondamento del motoveliero Alma, con un centinaio di prigionieri.
In totale da Cefalonia partono, quindi, 6.400 prigionieri italiani, secondo le fonti tedesche più di 1.264 sono quelli annegati.In effetti, le imbarcazioni che portano verso il continente i prigionieri italiani si trovano a seguire le rotte su cui la nostra marina aveva predisposto, nel luglio precedente, zone minate. I tedeschi non dispongono di carte nautiche aggiornate.Sarà il capitano di corvetta Barone a fornire loro i lucidi con la nuova situazione e solo allora si interrompono gli affondamenti.
Bisogna considerare che circa 2.250 sono i militari italiani trasferiti a Cefalonia da Zacinto, anche se probabilmente le vittime degli affondamenti sono in prevalenza soldati della Acqui. I caduti durante i combattimenti e subito dopo dovrebbero essere, secondo i calcoli più aggiornati, circa 3.900, a cui aggiungere gli italiani militarizzati non censiti e il personale civile. Circa 200 militari italiani si sarebbero invece nascosti in montagna con i partigiani greci.
A Corfù rimangono, dopo la resa, tra 8.000 e 10.000 prigionieri italiani, secondo le varie fonti, di cui meno di 4.000appartenenti al presidio originale, perché molti sono i reparti provenienti dalla costa balcanica. Nelle settimane successive sono quasi tutti trasferiti sul continente per essere poi condotti verso i campi di internamento. Ma nel periodo di permanenza sull’isola vi sono numerose perdite a causa delle incursioni degli aerei alleati. A fine settembre un attacco alleato al campo d’aviazione, dove sono concentrati i prigionieri italiani, provocanumerosi morti e feriti; il 9 e il 10 ottobre alcuni bombardieri americani colpiscono in due successive incursioni la nave ospedale Mario Rosselli, che ha a bordo circa 5.000 prigionieri in attesa di essere trasferiti in Grecia.
Vi sono centinaia di vittime, secondo alcune testimonianze addirittura 1.500. I soldati italiani fatti prigionieri in Grecia sono avviati verso Atene, dove sono caricati sui vagoni ferroviari. I treni seguono la linea che passa per Belgrado e giunge fino al confine austriaco.
Dai reduci della Acqui sopravvissuti al massacro sono giunte molte testimonianze che evidenziano il comportamento dei soldati tedeschi verso di loro. Ad esempio quella del marinaio Antonio Santillo:
«Mentre sbarcavamo al Pireo nello spazio tra la scaletta e la cancellata di uscita, i tedeschi si disponevano su due file – c’erano soldati di tutte le armi, marinai, Wehrmacht eccetera – e cominciarono a sputarci addosso, a prenderci a schiaffi […].
Appena i tedeschi ci vedevano, dicevano “Via, via Italien banditen”. Sapevano che venivamo da Cefalonia: nessuno ci volle ricoverare in ospedale […]».
Per i tedeschi gli italiani di Cefalonia erano indegni di portare la divisa, perché si erano ammutinati e avevano sparato ai proprî ufficiali, ad essi non si applicavano le convenzioni internazionali, perché erano considerati «banditi», «franchi tiratori», «ribelli». In genere, i reparti italiani sono disarmati. I tedeschi distinguono tra chi si rifiuta di collaborare con loro e con il regime fascista; chi oppone una resistenza attiva o passiva; chi rimane fedele all’alleanza con la Germania e intende collaborare o nei reparti combattenti oppure in quelli ausiliari.
Nelle disposizioni di Lanz alle sue due divisioni si legge: «Le divisioni devono fornire ai gruppi di marcia le armi individuali necessarie per l’autodifesa […] debbono essere incaricate della protezione delle colonne di marcia unità italiane armate di sicuro affidamento, particolarmente impegnate».
I prigionieri italiani vengono trasferiti verso campi di raccolta nel Reich o nei territori occupati, solo successivamente si chiede loro se intendono aderire al costituendo esercito della Repubblica sociale italiana.
I tedeschi distinguono gli internati militari italiani dai prigionieri, in quanto sono considerati potenziali «soldati del Duce». Così il responsabile dell’Okw per le questioni degli internati militari e i prigionieri di guerra scrive ai responsabili della Croce rossa internazionale (lettera del 3 maggio 1944):
«I soldati italiani che hanno servito nell’esercito di Badoglio e sono stati catturati dalle forze tedesche nel corso di operazioni militari vengono considerati prigionieri di guerra e quindi saranno loro riconosciuti i diritti della Convenzione di Ginevra del 1929. Gli internati militari italiani, in quanto si sono arresi, sono soldati del Duce e quindi non possono essere visitati dalla Cri e non possono ricevere i benefici stabiliti dal Comitato Internazionale della Cri».
Agli Internati militari italiani avrebbe provveduto la Croce rossa della Repubblica sociale italiana. In totale sono circa 2.500 i prigionieri della divisione Acqui trasportati nei campi di lavoro tedeschi, soprattutto in Germania e in Polonia; della loro sorte non sappiamo molto; i dati esistenti parlano di almeno 175 soldati morti durante la prigionia, secondo Vincenzo Palmieri (1983) si tratterebbe di 12 ufficiali e 196 sottufficiali e uomini di truppa.
Ricordiamo un episodio accaduto agli inizi del 1945, nel Lager 240 di Borisoff, in Bielorussia: dopo la battaglia di Minsk, 152 soldati italiani prigionieri, tra cui 40 provenienti da Cefalonia e 18 da Corfù, riescono a evadere e a raggiungere il Comando russo;il Comando; in un primo tempo sono rinchiusi in un campo i prigionieri tedeschi, riescono a far conoscere la loro storia e vengono liberati, collaborando poi con i soldati dell’Armata rossa.
Ma in genere i soldati italiani, una volta liberati dai sovietici, non vengono riconosciuti come lavoratori coatti ma trattati da ex collaborazionisti dei tedeschi e avviati a una seconda prigionia. Tra coloro che raggiungono i partigiani greci sul continente, come i tenenti De Angelis e Galdi, c’è chi muore di stenti alla fine del 1944, mentre i sottotenenti Giovanni Giraudi, Vito e Federico Ronzano riescono a rientrare in Italia dopo avere animato la resistenza antitedesca a Itaca.
Una sorte differente tocca ai 36 sopravvissuti della casettarossa e al cappellano don Formato. Secondo il capitano di corvetta Barone «Il 14 ottobre i tedeschi ci fecero firmare singolarmente una dichiarazione di accettazione di far parte dei servizi ausiliari tedeschi senza alcun impiego come truppe combattenti e di eseguire tutti gli ordini dei superiori germanici».
Nelle settimane successive, di fronte alla scelta che viene posta loro tra combattere con i tedeschi, entrare nei servizi ausiliari oppure essere considerati prigionieri di guerra ed essere internati, quasi tutti scelgono la seconda soluzione. Il 3 novembre 35 ufficiali sono trasferiti a Sami per imbarcarsi per il continente; la partenza avviene il giorno 12 per Missolungi, dove vengono aggregati al 36° battaglione Camicie nere Genova. Pochi giorni dopo «tutti firmano un’altra dichiarazione simile a quella che avevano firmato gli ufficiali del Battaglione: cioè di far parte di reparti italiani aderenti al nuovo governo e di cooperare per esso al fianco dei camerati germanici».
I sopravvissuti possono quindi godere di due settimane in un albergo di Atene prima di essere inviati alle loro destinazioni: i marinai nella base sommergibilistica di Bordeaux, gli ufficiali di Fanteria e di Artiglieria in Germania, in particolare nel campo di addestramento di Heuberg dove si stanno costituendo le divisioni Italia e Monterosa, oppure nei tribunali militari e nei distretti della Repubblica sociale italiana, tutti regolarmente retribuiti.
Entro il mese di marzo 1944 gli ufficiali inviati in Germania rientrano in Italia passando per Verona. Quindi, ciascuno prende strade diverse fino all’arrivo della Liberazione. Due degli ufficiali sopravvissuti, i sottotenenti Elio Esposito e Lorenzo Caccavale, sono costretti a rimanere a Cefalonia e saranno tra i protagonisti della liberazione dell’isola nel settembre 1944.
Il Raggruppamento banditi Acqui
Nel mese di ottobre 1943 i tedeschi formano due compagnie di lavoratori, per un totale di circa 600 prigionieri, che sono inviati sul continente in novembre assieme a una parte degli ufficiali sopravvissuti il 24 settembre. A Cefalonia rimangono così circa un migliaio di «prigionieri» italiani, sottoposti, almeno per un certo periodo, a un duro regime disciplinare, ma senza il clima di terrore dei primi tempi. Sono distribuiti tra diversi campi, alle carceri civili e alla ex caserma Mussolini in Argostoli, a Chelmata, a Pessades, a capo Munta, a Fiskardo, a Minies.
 Tuttavia, almeno per una parte di questi uomini, lo status riconosciuto è di militari dell’Esercito repubblicano, ovvero della Repubblica sociale italiana, nelle cui forze operanti a tutto il dicembre 1944 risultano 6 ufficiali e 328 sottufficiali e soldati del Gruppo artiglieria costiera Cefalonia, 225 militari del battaglione Genio fortificazione, 79 sottufficiali e soldati del reparto Sanità; tutte queste truppe sono alle dipendenze dei tedeschi.
Tuttavia, almeno per una parte di questi uomini, lo status riconosciuto è di militari dell’Esercito repubblicano, ovvero della Repubblica sociale italiana, nelle cui forze operanti a tutto il dicembre 1944 risultano 6 ufficiali e 328 sottufficiali e soldati del Gruppo artiglieria costiera Cefalonia, 225 militari del battaglione Genio fortificazione, 79 sottufficiali e soldati del reparto Sanità; tutte queste truppe sono alle dipendenze dei tedeschi.
A proposito di questi uomini, il capitano Pampaloni parlò, allora, di collaborazionisti. Risulta invece che essi si siano occupati della sola manutenzione delle batterie o fossero addetti a lavori pesanti, operando, quando possibile, atti di sabotaggio e rendendosi disponibili, al momento della partenza dei tedeschi, ad appoggiare l’azione armata dei patrioti.
I tedeschi, dopo la battaglia, si sono impossessati di una gran quantità di materiale, sufficiente alle necessità di oltre 11.000 uomini, in gran parte trasferita successivamente sul continente. Decidono però di mantenere sull’isola tre batterie di marina e cinque dell’esercito, per le quali hanno bisogno di circa 150 uomini che vengono presi tra gli italiani prigionieri.
Gli altri sono invece addetti ai lavori pesanti: sistemazione delle strade, manovalanza al porto, nei magazzini, nelle officine, sgombero dei relitti della battaglia e bonifica dei proiettili inesplosi. La popolazione subisce l’occupazione tedesca in un clima di paura, i collaborazionisti sono numerosi e l’attività partigiana piuttosto scarsa.
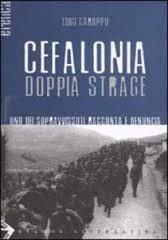 Tra i prigionieri italiani, e tra i molti che si sono rifugiati nell’interno, circa 150-200, – Loukàtos parla addirittura di 1.000 – protetti spesso da contadini e cittadini di Cefalonia, si mantiene un’attività clandestina di resistenza, anche se i rapporti con i partigiani comunisti non sono facili.
Tra i prigionieri italiani, e tra i molti che si sono rifugiati nell’interno, circa 150-200, – Loukàtos parla addirittura di 1.000 – protetti spesso da contadini e cittadini di Cefalonia, si mantiene un’attività clandestina di resistenza, anche se i rapporti con i partigiani comunisti non sono facili.
Altri 100-150 militari riescono a raggiungere il continente, tra questi Pampaloni, aggregandosi ai partigiani dell’Elas o dell’Edes. A guidare la resistenza antitedesca a Cefalonia dopo la resa è il capitano Renzo Apollonio. Egli, dopo essersi salvato dalla prima esecuzione seguita alla cattura a Dilinata, era tornato a combattere ed era stato nuovamente catturato dai tedeschi e avviato alla fucilazione, ma era riuscito a fuggire. L’indomani 22 settembre, mentre cercava di raggiungere le batterie di marina sulla costa veniva di nuovo fatto prigioniero assieme ad altri ufficiali e portato alla caserma Mussolini.
Il 24 mattina, quando si pensava che le stragi fossero finite, avvertito che i tedeschi avevano messo una taglia su di lui perché tra i protagonisti dell’azione del giorno 13 contro i mezzi da sbarco, riusciva a scappare confondendosi tra i soldati. Nel pomeriggio veniva inserito tra i militari originari delle zone annesse al Reich, Apollonio è triestino. Per non compromettere gli altri compagni, nel caso fosse stato riconosciuto, invitato ad allontanarsi dal capitano Tomasi e da don Formato, si offriva come infermiere, rinunciando a una nuova fuga che avrebbe provocato una rappresaglia tedesca, come era già avvenuto al 37° ospedale da campo.
 Correva il rischio, anche, di essere riconosciuto dai fascisti e dai collaborazionisti dei tedeschi; per questo, il 27 settembre, decideva di costituirsi al maggiore Hartmann. Il 2 o 3 ottobre veniva condannato a morte. Ma il capitano si salva ancora una volta grazie all’intervento del tenente Werner Lange, l’ufficiale che comandava il plotone catturato ad Argostoli il 13 settembre proprio da Apollonio.
Correva il rischio, anche, di essere riconosciuto dai fascisti e dai collaborazionisti dei tedeschi; per questo, il 27 settembre, decideva di costituirsi al maggiore Hartmann. Il 2 o 3 ottobre veniva condannato a morte. Ma il capitano si salva ancora una volta grazie all’intervento del tenente Werner Lange, l’ufficiale che comandava il plotone catturato ad Argostoli il 13 settembre proprio da Apollonio.
Lange conferma di essere stato trattato onorevolmente dal capitano e che il suo intervento «aveva impedito ai civili greci di uccidere i prigionieri». Da questo momento Apollonio viene reclutato per la formazione di alcune batterie da mantenere sull’isola e utilizzato come rappresentante dei prigionieri italiani verso il Comando tedesco grazie alla sua conoscenza della lingua. Questo impiego gli permette di muoversi con una certa libertà.
Dirà Apollonio nella sua relazione: «Dopo la strage il materiale umano era completamente distrutto, annientato. Vedevo la prostrazione morale e materiale del soldato, le anime non vibravano più. Sotto il terrore direi che a stento pulsava ancora il cuore. Teste basse, occhi smarriti, volontà spezzate. Con fiducia immensa, passando continuamente da delusioni profonde in amarezze, affiancatimi alcuni elementi di primissimo piano proseguii senza esitare per la mia via».
Già il 13 ottobre si costituisce una prima cellula clandestina di sei membri: il sottotenente Elio Esposito, il maresciallo Anacleto Conte, il sergente maggiore Ferdinando Insolvibile, il sergente Lino Calliari, l’artigliere Bruno Ebetelli, l’artigliere Fiorino Cattabiani. È la nascita del Raggruppamento banditi Acqui.
 Apollonio in dicembre riprende i contatti col Comando dell’Elas a Cefalonia, in particolare con Miliaresis, e fornisce notizie apprese dai tedeschi, dai piani di rastrellamento alla disposizione dei reparti, all’ubicazione dei sistemi di difesa. A mano a mano, negli ultimi mesi del 1943 e nei primi del 1944, si costituiscono altre cellule della resistenza impegnate nel «sabotaggio silenzioso», che evita le rappresaglie sulla popolazione civile ma permette di danneggiare o distruggere armamenti e munizioni, come nel caso delle quattromila cariche complete per i pezzi da 155/14 che sono rese inutilizzabili trasportandole in zone allagate.
Apollonio in dicembre riprende i contatti col Comando dell’Elas a Cefalonia, in particolare con Miliaresis, e fornisce notizie apprese dai tedeschi, dai piani di rastrellamento alla disposizione dei reparti, all’ubicazione dei sistemi di difesa. A mano a mano, negli ultimi mesi del 1943 e nei primi del 1944, si costituiscono altre cellule della resistenza impegnate nel «sabotaggio silenzioso», che evita le rappresaglie sulla popolazione civile ma permette di danneggiare o distruggere armamenti e munizioni, come nel caso delle quattromila cariche complete per i pezzi da 155/14 che sono rese inutilizzabili trasportandole in zone allagate.
Solo dopo l’arrivo della missione militare alleata Dastard II, nel mese di aprile, il Raggruppamento si impegna anche in qualche attentato. L’attività di doppio gioco portata avanti da Apollonio e dai suoi uomini è molto pericolosa, anche per la presenza di spie e di soldati collaborazionisti o fascisti che possono denunciarli ai tedeschi. Inoltre i rapporti con i partigiani, tra i quali cominciano ad apparire le divergenze tra le due principali componenti, quella comunista e quella nazionalista, diventano più difficili e Apollonio vorrebbe entrare in rapporto direttamente con la Missione militare alleata in Grecia, ma deve aspettare ancora qualche mese.
 A gennaio riesce a far fuggire il capo dell’Elas di Argostoli, avvisandolo poco prima dell’irruzione della Gestapo. Entro marzo riesce a organizzare altre cellule che gli permettono di controllare tutte le batterie servite da soldati italiani. Solo alla fine di aprile c’è il primo incontro con la missione alleata, costituita dagli agenti Themistocles Marinos e John Lazaris, con cui vengono concordate le attività successive. Il loro rapporto è conservato presso i National Archives di Kew.
A gennaio riesce a far fuggire il capo dell’Elas di Argostoli, avvisandolo poco prima dell’irruzione della Gestapo. Entro marzo riesce a organizzare altre cellule che gli permettono di controllare tutte le batterie servite da soldati italiani. Solo alla fine di aprile c’è il primo incontro con la missione alleata, costituita dagli agenti Themistocles Marinos e John Lazaris, con cui vengono concordate le attività successive. Il loro rapporto è conservato presso i National Archives di Kew.
Marinos ha scritto anche un libro di memorie in cui ricorda gli avvenimenti del 1944:
«Sull’isola c’erano circa 700 italiani che erano impegnati in 8 batterie da campagna e una compagnia per i servizi ausiliari. Il comandante delle batterie era il capitano Apollonio. Le informazioni su questo ufficiale erano state buone. Perciò decisi di avvicinarlo il prima possibile. Presa ogni precauzione, lo incontrai il 14 giugno 1944 nella casa di uno dei miei migliori agenti, Ilia Ghimis di Argostoli. […]
L’incontro fu un grande successo. Il capitano Apollonio mi dette tutte le informazioni che volevo e mi fornì anche tutte le indicazioni sulle future operazioni che i tedeschi stavano progettando sull’isola. Da allora il capitano Apollonio divenne uno dei miei più importanti agenti, utile non solo per le informazioni che mi poteva dare ma anche per il lavoro di sovversione che poteva svolgere».
 L’11 luglio Apollonio riesce ad avvisare i partigiani del massiccio rastrellamento programmato dai tedeschi; dopo l’avvio dell’azione i greci si trovano chiusi dalla manovra nemica ed è di nuovo il capitano a intervenire per fare fuggire alcune centinaia di partigiani attraverso i varchi lasciati dalle compagnie tedesche. Alla fine di luglio, Apollonio e il suo principale collaboratore, il sottotenente Boni, sono denunciati da due italiani collaborazionisti per spionaggio e propaganda antitedesca.
L’11 luglio Apollonio riesce ad avvisare i partigiani del massiccio rastrellamento programmato dai tedeschi; dopo l’avvio dell’azione i greci si trovano chiusi dalla manovra nemica ed è di nuovo il capitano a intervenire per fare fuggire alcune centinaia di partigiani attraverso i varchi lasciati dalle compagnie tedesche. Alla fine di luglio, Apollonio e il suo principale collaboratore, il sottotenente Boni, sono denunciati da due italiani collaborazionisti per spionaggio e propaganda antitedesca.
Il giudice istruttore lavora segretamente per individuare tutta l’organizzazione clandestina, ma l’indagine è ancora in corso quando ai tedeschi giunge l’ordine di cominciare ad abbandonare l’isola.
La liberazione di Cefalonia
Nella notte tra il 26 e il 27 agosto inizia l’attività insurrezionale del Raggruppamento; le batterie comandate da ufficiali o sottufficiali italiani, come quella di Apollonio, dove vi sono piccoli corpi di guardia tedeschi che hanno avuto il compito di farle saltare, passano sotto il controllo dei «banditi». I tedeschi abbandonano Cefalonia ai primi di settembre 1944. Tra il 4 e l’8 settembre, secondo la testimonianza del sottotenente Boni, «i soldati italiani inquadrati regolarmente in reparti tedeschi, presi gli ordini dal capitano Apollonio, disertavano dai vecchi reparti, sabotando armi, automezzi e materiali. Le batterie italiane rinserratesi nei loro capisaldi si disponevano in ordine di combattimento pronte ad agire nell’eventualità che le truppe tedesche intendessero usare la forza per far saltare i pezzi».
 Sono anche occupati i due depositi centrali delle munizioni di Argostoli: quello nella Scuola agraria, quello di mine ed esplosivi di San Teodoro oltre al deposito carburanti. L’8 settembre un gruppo di militari italiani, alcuni prigionieri, altri entrati in clandestinità sull’isola nei mesi dell’occupazione tedesca, riescono a impadronirsi del porto di Argostoli, impedendo che venga fatto saltare.
Sono anche occupati i due depositi centrali delle munizioni di Argostoli: quello nella Scuola agraria, quello di mine ed esplosivi di San Teodoro oltre al deposito carburanti. L’8 settembre un gruppo di militari italiani, alcuni prigionieri, altri entrati in clandestinità sull’isola nei mesi dell’occupazione tedesca, riescono a impadronirsi del porto di Argostoli, impedendo che venga fatto saltare.
Ne è protagonista il gruppo di sottufficiali e marinai, in tutto 81 militari tra i quali solo 4 dell’Esercito, comandati dal sottotenente della Regia marina Lorenzo Caccavale: i tedeschi avevano collocato centoventi bombe marine sotto tutta la banchina e intendevano farla saltare assieme alle imbarcazioni presenti. I danni sarebbero stati gravissimi e avrebbero coinvolto anche gran parte delle abitazioni civili.
È sempre Caccavale a comunicare alla missione alleata le rotte per i porti di Argostoli, Patrasso e Navarino e la disposizione dei campi di mine collocati attorno a Cefalonia e a Zante. Il sottotenente Elio Esposito, l’altro ufficiale sopravvissuto alla casetta rossa e rimasto poi a Cefalonia, organizza invece il sabotaggio del deposito di munizioni tedesco di capo Sotis.
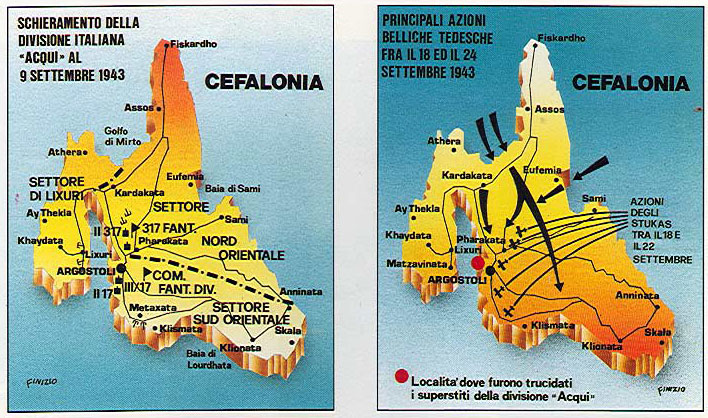 Altre azioni accompagnano la cosiddetta «insurrezione» di Cefalonia. A sera, in piazza Valianos, ad Argostoli, sono issate assieme la bandiera greca e quella italiana. Il giorno successivo si festeggia, finalmente, dopo un anno tragico per la Acqui. Vi è anche una prima riunione tra i rappresentanti del Raggruppamento, la missione alleata e i comandanti partigiani. Sempre l’8 settembre, Apollonio invia al capo missione Marinos il seguente messaggio per il Cairo:
Altre azioni accompagnano la cosiddetta «insurrezione» di Cefalonia. A sera, in piazza Valianos, ad Argostoli, sono issate assieme la bandiera greca e quella italiana. Il giorno successivo si festeggia, finalmente, dopo un anno tragico per la Acqui. Vi è anche una prima riunione tra i rappresentanti del Raggruppamento, la missione alleata e i comandanti partigiani. Sempre l’8 settembre, Apollonio invia al capo missione Marinos il seguente messaggio per il Cairo:
«La notte dell’8 settembre 1944 la guarnigione italiana di Cefalonia, comprendente un complesso d’Artiglieria, 1 battaglione lavoratori, unità del Comando Navale, 2 ospedali da campo, agli ordini del capitano Apollonio, liberatisi dal giogo tedesco, si sono messi a disposizione del Quartier Generale Alleato del Medio Oriente, attraverso questa missione militare alleata. Resto in attesa di ordini».
Il Raggruppamento banditi Acqui aveva collaborato con tutte le componenti della resistenza, ora si rivolgeva al Comando alleato mettendosi a disposizione come soldati italiani assieme agli altri reparti del Regio esercito che combattevano con loro. In questo momento si tratta, innanzitutto, di impedire il disarmo o l’incorporazione da parte degli Andartes, come erano chiamati i partigiani greci. Dal mese di maggio sull’isola avevano preso il sopravvento i militanti comunisti dell’Eam, la componente politica dell’Elas.
 Ma la risposta del Cairo non arriva subito. Il 17 i partigiani dell’Elas entrano ad Argostoli festeggiati dalla popolazione. Il 19 settembre Apollonio presenta una dichiarazione ufficiale di resa incondizionata alla Gran Bretagna. C’è il rischio che le batterie ancora in mano agli italiani cadano sotto il controllo dei partigiani greci comunisti, che gli inglesi avversano. Tra gli italiani vi sono opinioni differenti: Pampaloni, ad esempio, è favorevole al passaggio con la resistenza greca e al trasferimento sul continente. I capi partigiani offrono ad Apollonio il comando dei partigiani italiani in Grecia.
Ma la risposta del Cairo non arriva subito. Il 17 i partigiani dell’Elas entrano ad Argostoli festeggiati dalla popolazione. Il 19 settembre Apollonio presenta una dichiarazione ufficiale di resa incondizionata alla Gran Bretagna. C’è il rischio che le batterie ancora in mano agli italiani cadano sotto il controllo dei partigiani greci comunisti, che gli inglesi avversano. Tra gli italiani vi sono opinioni differenti: Pampaloni, ad esempio, è favorevole al passaggio con la resistenza greca e al trasferimento sul continente. I capi partigiani offrono ad Apollonio il comando dei partigiani italiani in Grecia.
Il 20 settembre giunge finalmente dal Cairo alla missione di Cefalonia la seguente comunicazione:
«Abbiamo chiesto alla 7a brigata dell’Elas di dare istruzioni alla loro unità di Cefalonia che agli italiani, per quanto siano considerati prigionieri di guerra, sia concesso loro di tenere le armi fino all’arrivo del rappresentante del Comando alleato, a riconoscimento dell’aiuto segreto loro datoci “.
Dal 21 i partigiani comunisti cominciano a impossessarsidei depositi e dei magazzini dell’isola. Apollonio fa rendere inutilizzabili i pezzi a sua disposizione senza farlo scoprire dai greci. Il 24 settembre il Comando del Cairo decide «che al capitano Apollonio e alla sua unità fosse concesso l’onore di rientrare in Patria con la loro Bandiera e le armi individuali» (Relazione di John Lazaris).
 Nelle settimane successive si confrontano sull’isola i partigiani comunisti dell’Elas, che vogliono mettere alle loro dipendenze i soldati della Acqui e la missione militare del governo monarchico greco appoggiata dagli inglesi.
Nelle settimane successive si confrontano sull’isola i partigiani comunisti dell’Elas, che vogliono mettere alle loro dipendenze i soldati della Acqui e la missione militare del governo monarchico greco appoggiata dagli inglesi.
Il 4 ottobre arrivano a Cefalonia i rappresentanti del governo greco, Leon Makkas, e del Comando alleato, maggiore Hutchinson, ma la loro presenza dura poco e in attesa delle navi inglesi che non arrivano la situazione non migliora. I militari italiani del Raggruppamento banditi Acqui sono adesso circa 1.300, di cui una parte proveniente dal continente. Intanto il clima politico in Grecia peggiora. Sta per cominciare la guerra civile, con l’intervento diretto degli inglesi in appoggio ai partigiani monarchici. I rapporti con l’Elas si inaspriscono quando questi vogliono trasferirli sul continente, vi sono anche numerosi episodi di aggressione a soldati italiani.
Finalmente arriva l’ordine di partenza: l’11 novembre parte il gruppo del sottotenente Caccavale, 89 tra sottufficiali e marinai; il 12 seguono quasi tutti gli italiani del Raggruppamento, che si imbarcano per l’Italia a bordo di due cacciatorpedinieri italiani e di cinque mezzi da sbarco inglesi. Nel pomeriggio del 14 sbarcano a Taranto, accolti da un telegramma di plauso del ministro della Guerra Alessandro Casati. In totale sono 1.314 soldati, tra questi 7 ufficiali, di cui 1 di Marina e 2 che si erano dati alla macchia dopo la battaglia del settembre 1943, 9 ufficiali medici, 56 sottufficiali e 1.242 marinai e soldati.
Prima della partenza Apollonio aveva indetto un referendum per decidere per il ritorno in Italia o per la permanenza in Grecia. Un centinaio di volontari rimane a combattere con i partigiani comunisti, di questi, 69 sono militari italiani di lingua slovena della 215a compagnia lavoratori del Genio che entreranno nell’Esercito di liberazione jugoslavo, 40 sono i soldati della batteria di Sami che si orientano per la proposta del capitano Pampaloni.
 Alcuni degli ufficiali della Acqui sopravvissuti alla strage di Cefalonia e che avevano aderito alla Repubblica sociale italiana accuseranno il Raggruppamento banditi di avere collaborato con i tedeschi. Nessuno di loro, una volta tornati in Italia, avrà riconoscimenti dal governo italiano, nonostante gli attestati dei partigiani greci e degli inglesi. All’arrivo a Taranto sono rinchiusi nel campo di Sant’Andrea, assieme a migliaia di altri soldati italiani rientrati dall’estero o in attesa di essere interrogati da un centinaio di ufficiali dei servizi segreti.
Alcuni degli ufficiali della Acqui sopravvissuti alla strage di Cefalonia e che avevano aderito alla Repubblica sociale italiana accuseranno il Raggruppamento banditi di avere collaborato con i tedeschi. Nessuno di loro, una volta tornati in Italia, avrà riconoscimenti dal governo italiano, nonostante gli attestati dei partigiani greci e degli inglesi. All’arrivo a Taranto sono rinchiusi nel campo di Sant’Andrea, assieme a migliaia di altri soldati italiani rientrati dall’estero o in attesa di essere interrogati da un centinaio di ufficiali dei servizi segreti.
Tra settembre e novembre 1944, don Ghilardini, Apollonio e Pampaloni si impegnano a raccogliere tra i militari italiani sopravvissuti, ma anche tra i partigiani greci e tra i membri della missione alleata, testimonianze sugli avvenimenti dell’ultimo anno, dall’armistizio alla strage del settembre 1943, ai dodici mesi di permanenza a Cefalonia sotto l’occupazione tedesca. Si tratta di una documentazione particolarmente importante ai fini della ricostruzione di quanto accaduto sull’isola.
Queste carte sono poi state lasciate all’Associazione nazionale divisione Acqui e da questa consegnate all’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito. Dal 2007 esse sono a disposizione dell’Istituto storico autonomo della resistenza dei militari italiani all’estero di Arezzo, che ne ha curato l’archiviazione, la classificazione e la pubblicazione on-line.
 La sorte dei prigionieri raccolti a Corfù non sarà meno drammatica. Un primo imbarco verso Atene è del 30 settembre, con un trasporto di 1.588 prigionieri. Il 10 ottobre è in partenza da Corfù la motonave Mario Roselli, con ben 5.500 prigionieri. La nave viene colpita e danneggiata da due attacchi aerei. Le vittime sono centinaia. Qualche giorno dopo un altro piroscafo riesce a portare in Grecia 2.000 italiani. Non abbiamo notizie di ciò che accade nei mesi successivi fino alla liberazione dell’isola.
La sorte dei prigionieri raccolti a Corfù non sarà meno drammatica. Un primo imbarco verso Atene è del 30 settembre, con un trasporto di 1.588 prigionieri. Il 10 ottobre è in partenza da Corfù la motonave Mario Roselli, con ben 5.500 prigionieri. La nave viene colpita e danneggiata da due attacchi aerei. Le vittime sono centinaia. Qualche giorno dopo un altro piroscafo riesce a portare in Grecia 2.000 italiani. Non abbiamo notizie di ciò che accade nei mesi successivi fino alla liberazione dell’isola.
Il Servizio informazioni militare e l’Ufficio storico
dello Stato maggiore dell’Esercito sui fatti di Cefalonia
Le autorità militari italiane iniziano subito un’attività di studio per ricostruire i fatti di Cefalonia; allo Stato maggiore interessa non solo la strage della Acqui, ma anche capire le responsabilità di Gandin e di alcuni ufficiali nella fase preliminare della battaglia. A Taranto, a tutti gli ufficiali arrivati da Cefalonia viene chiesto di preparare una relazione. A coordinare gli interrogatori è il capo dell’Ufficio I del Servizio informazioni militare, il tenente colonnello Gino De Luca, con la collaborazione del capitano Attilio De Luigi. Le deposizioni raccolte non sono univoche sulle interpretazioni dei fatti e nei giudizi sui diversi protagonisti.
Non tutti i reduci guardano con simpatia gli uomini del Raggruppamento banditi Acqui. Sono soprattutto quei militari che si sono rifugiati all’interno dell’isola vivendo di stenti o coloro che hanno raggiunto il continente combattendo con i partigiani greci al seguito del capitano Pampaloni: per loro quegli uomini sono innanzitutto «collaborazionisti», non tenendo conto che la loro posizione era decisa dai tedeschi.
 Vi è anche chi ha paura di essere denunciato per l’atteggiamento compromissorio tenuto durante la prigionia, alcuni sono stati informatori e spie per i tedeschi, vi sono anche gelosie per supposti avanzamenti di grado durante l’anno in servizio di lavoro coatto. Apollonio presenta una relazione di centodue pagine che risulta essere la più completa sull’anno passato in mano ai tedeschi. Anche se i giudizi raccolti presentano numerose contraddizioni, i due ufficiali del Servizio informazioni non lesinano le dichiarazioni di stima verso l’ufficiale.
Vi è anche chi ha paura di essere denunciato per l’atteggiamento compromissorio tenuto durante la prigionia, alcuni sono stati informatori e spie per i tedeschi, vi sono anche gelosie per supposti avanzamenti di grado durante l’anno in servizio di lavoro coatto. Apollonio presenta una relazione di centodue pagine che risulta essere la più completa sull’anno passato in mano ai tedeschi. Anche se i giudizi raccolti presentano numerose contraddizioni, i due ufficiali del Servizio informazioni non lesinano le dichiarazioni di stima verso l’ufficiale.
Il 18 novembre 1944 così riassumono l’interrogatorio del capitano da cui emergono le critiche sul piano militare all’operato di Gandin:
«Il capitano Apollonio ha dichiarato che la rovina delle truppe italiane in Cefalonia sarebbe dovuta al continuo temporeggiare del generale Gandin dal giorno 9 al giorno 15 settembre; di aver ritirato due battaglioni dalla posizione a nord di Argostoli attestandoli nella zona di Svolonata […].
A mio avviso il nostro collasso fu determinato dal mancato impiego […] di soldati bene agguerriti. I soldati del 317° Rgt. Ftr. hanno combattuto benissimo ma come addestramento erano di gran lunga inferiori a quelli del 17° Rgt. Ftr.; l’ordine di non poter combattere di notte e l’arrivo di truppe fresche ci dette il colpo di grazia»
 Tra i superstiti, alcuni, in particolare don Romualdo Formato e il capitano Ermanno Bronzini, presentano testimonianze che costituiscono la base per una lettura apologetica del comportamento del generale Gandin. In mancanza della documentazione italiana della divisione Acqui, distrutta nel corso della battaglia, saranno loro a fornire le ricostruzioni, non sempre esatte, utilizzate poi dagli storici.
Tra i superstiti, alcuni, in particolare don Romualdo Formato e il capitano Ermanno Bronzini, presentano testimonianze che costituiscono la base per una lettura apologetica del comportamento del generale Gandin. In mancanza della documentazione italiana della divisione Acqui, distrutta nel corso della battaglia, saranno loro a fornire le ricostruzioni, non sempre esatte, utilizzate poi dagli storici.
Le differenze emergeranno solo molto tempo dopo, quando cominceranno a circolare i documenti conservati negli archivi tedeschi. Esse risentono anche della particolare collocazione dei protagonisti dopo la conclusione della battaglia, in quanto avevano aderito alla Repubblica sociale italiana assieme ad altri sopravvissuti, avevano ricevuto regolare stipendio, compresi degli arretrati ed erano stati trasferiti in Germania per un periodo di addestramento.
 Don Formato è autore del primo libro pubblicato sulle vicende di Cefalonia. Bronzini, invece, è l’unico ufficiale sopravvissuto del Comando divisionale. Don Formato aderisce alla Repubblica sociale italiana il 14 novembre 1943, a Missolungi. Da Atene, in dicembre, è trasferito al 5° Comando formazione truppa della Repubblica sociale italiana di Heuberg, nel Baden, che lascia a gennaio 1944 per raggiungere Roma, dove ha un’udienza privata col Papa. Si nasconde in Vaticano fino alla liberazione della città e in novembre giunge a Bari con un aereo del ministero della Guerra e inizia così la sua testimonianza su Cefalonia al servizio segreto militare.
Don Formato è autore del primo libro pubblicato sulle vicende di Cefalonia. Bronzini, invece, è l’unico ufficiale sopravvissuto del Comando divisionale. Don Formato aderisce alla Repubblica sociale italiana il 14 novembre 1943, a Missolungi. Da Atene, in dicembre, è trasferito al 5° Comando formazione truppa della Repubblica sociale italiana di Heuberg, nel Baden, che lascia a gennaio 1944 per raggiungere Roma, dove ha un’udienza privata col Papa. Si nasconde in Vaticano fino alla liberazione della città e in novembre giunge a Bari con un aereo del ministero della Guerra e inizia così la sua testimonianza su Cefalonia al servizio segreto militare.
Ma della collaborazione di don Formato con la Repubblica di Salò e della sua permanenza in Germania e nell’Italia di Mussolini non rimane traccia nei colloqui con la Commissione d’inchiesta: invece, risulta che egli sarebbe rientrato da Cefalonia a Taranto il 13 novembre 1944 assieme agli altri contingenti. Tuttavia, pare che nessun reduce italiano sia giunto da Cefalonia in quella data; l’unico cappellano militare rimasto sull’isola era don Luigi Ghilardini, anche lui al centro di Taranto in quelle settimane, ma nessuno gli chiede conferma della presenza di don Formato.
 Anzi, il colonnello De Luca incarica don Formato di stendere relazioni sulle figure più significative che hanno operato a Cefalonia e il cappellano consegna nelle settimane successive quelle sul generale Gandin e sul capitano Apollonio, che propongono giudizi contrapposti sull’operato dei due protagonisti.
Anzi, il colonnello De Luca incarica don Formato di stendere relazioni sulle figure più significative che hanno operato a Cefalonia e il cappellano consegna nelle settimane successive quelle sul generale Gandin e sul capitano Apollonio, che propongono giudizi contrapposti sull’operato dei due protagonisti.
Saranno questi giudizi a essere ripresi nei decenni successivi dalla maggior parte degli storici che si occuperanno degli avvenimenti del 1943-44 a Cefalonia. I due reduci sono promotori, dal settembre 1945, di una denuncia contro il capitano Apollonio, montata artificialmente da generali amici e parenti di Gandin.
Infatti, si prestano con le loro testimonianze ad attaccare Apollonio accusandolo non solo di avere collaborato con i tedeschi nei mesi di occupazione di Cefalonia, ma di avere avuto sentimenti filotedeschi anche prima della battaglia. De Luca, in data 18 novembre 1943, registra questa dichiarazione di don Formato:
«Da altra fonte [padre Romualdo Formato] viene riferito che il giorno 9 novembre 1943 il capitano Apollonio avesse deciso di recarsi con tutta la batteria da lui comandata nella penisola di Lixuri, tacciandolo, in un certo modo, di sentimenti filotedeschi».
 Abbiamo visto nella ricostruzione di quelle vicende che l’intento di Apollonio era tutt’altro. Nel 1946 le accuse di don Formato e di Bronzini raggiungono i più alti livelli delle forze armate e lo stesso ministro della Guerra Casati. Il valore del capitano Apollonio aveva avuto, nel 1944, molti riconoscimenti, dal ministro della Guerra alle autorità militari alleate, dai comandanti partigiani greci al capo della Commissione del Servizio informazioni militari De Luca. Quest’ultimo ne aveva giudicato favorevolmente l’operato in sede di accertamento sul periodo di prigionia. Nonostante questi attestati, aveva ottenuto solamente un avanzamento di grado per merito di Guerra da capitano a maggiore nel 1945.
Abbiamo visto nella ricostruzione di quelle vicende che l’intento di Apollonio era tutt’altro. Nel 1946 le accuse di don Formato e di Bronzini raggiungono i più alti livelli delle forze armate e lo stesso ministro della Guerra Casati. Il valore del capitano Apollonio aveva avuto, nel 1944, molti riconoscimenti, dal ministro della Guerra alle autorità militari alleate, dai comandanti partigiani greci al capo della Commissione del Servizio informazioni militari De Luca. Quest’ultimo ne aveva giudicato favorevolmente l’operato in sede di accertamento sul periodo di prigionia. Nonostante questi attestati, aveva ottenuto solamente un avanzamento di grado per merito di Guerra da capitano a maggiore nel 1945.
La deposizione di don Formato inizia nel novembre 1944 a Taranto e prosegue a Roma, dove nel frattempo arriva anche il capitano Bronzini. Sarà Bronzini a far circolare la versione edulcorata della «notifica» di Gandin del 14 settembre, quella che inizierebbe con: «Per ordine del Comando Supremo italiano e per volontà degli ufficiali e dei soldati, la divisione Acqui non cede le armi».
Nell’aprile del 1946 anche Bronzini collabora per mettere Apollonio in cattiva luce, impedendo in questo modo che possa ottenere un qualsiasi riconoscimento. Don Formato e Bronzini saranno invece insigniti il primo di medaglia d’Argento al Valor militare, il secondo di medaglia di Bronzo; nessuno dei due avrà conseguenze per l’adesione alla Repubblica sociale italiana. Bronzini nel 1966 viene nominato presidente dell’Associazione nazionale reduci e famiglie caduti divisione Acqui e, nel 1972, farà ottenere una medaglia d’Oro all’allora generale di corpo d’armata Apollonio.
 Nel 1977 Bronzini, nello studio del notaio Giovanni Pampaloni, un sopravvissuto di Corfù, scrive una lettera che viene inviata al ministro della Difesa Attilio Ruffini. In essa ricostruisce le origini del «complotto»: la famiglia del generale Gandin e alcuni alti ufficiali amici intendevano difendere la memoria del comandante della Acqui dalle critiche e dalle accuse che cominciavano a circolare, anche attraverso articoli di giornale. Al progetto si era associato fin dall’inizio don Formato.
Nel 1977 Bronzini, nello studio del notaio Giovanni Pampaloni, un sopravvissuto di Corfù, scrive una lettera che viene inviata al ministro della Difesa Attilio Ruffini. In essa ricostruisce le origini del «complotto»: la famiglia del generale Gandin e alcuni alti ufficiali amici intendevano difendere la memoria del comandante della Acqui dalle critiche e dalle accuse che cominciavano a circolare, anche attraverso articoli di giornale. Al progetto si era associato fin dall’inizio don Formato.
Il bersaglio di questa operazione è proprio Apollonio. A conclusione della lettera Bronzini chiede che siano considerate nulle e distrutte col fuoco la lettera da lui inviata al ministro della Guerra il 16 dicembre 1945 e la «memoria» presentata il 2 aprile 1946 alla 3a Commissione accertamenti.
Altre notizie su questa imbarazzante vicenda sono rintracciabili in un diario personale di don Formato, un’agenda manoscritta, che coprirebbe gli anni 1943-44. Il diario, probabilmente, è oggi conservato dagli eredi di don Formato, ma Apollonio l’aveva trovato nel Fondo Acqui e ne aveva tratto una copia. Secondo Paoletti, che ricostruisce nei particolari le ragioni e lo svolgimento del progetto nel suo volume Il capitano Renzo Apollonio, l’eroe di Cefalonia, il diario «costituisce la prova che don Romualdo, dopo aver aderito alla RSI, è stato “assunto” dal Ministero della Guerra italiano, per screditare il più famoso reduce di Cefalonia ma anche il più tenace avverario della politica delle trattative voluta da Gandin».
 Già dopo gli interrogatori condotti dal Servizio informazioni militari sui reduci da Cefalonia, il 18 novembre 1944, il colonnello De Luca aveva steso una relazione in cui esaltava sia le doti di trascinatore e animatore della lotta antifascista a Cefalonia del capitano Apollonio, sia la saggezza di Gandin che aveva condotto trattative onorevoli per salvare l’onore e la vita dei suoi soldati.
Già dopo gli interrogatori condotti dal Servizio informazioni militari sui reduci da Cefalonia, il 18 novembre 1944, il colonnello De Luca aveva steso una relazione in cui esaltava sia le doti di trascinatore e animatore della lotta antifascista a Cefalonia del capitano Apollonio, sia la saggezza di Gandin che aveva condotto trattative onorevoli per salvare l’onore e la vita dei suoi soldati.
Anche l’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito, a metà del 1945, ha coscienza dei rischi interpretativi che derivano dalla vicenda di Cefalonia. In particolare, secondo l’allora responsabile, il colonnello Luigi Mondini, sarebbe «delicatissima soprattutto per il dissidio Comandante-Truppe; dissidio che l’Ufficio Storico tenta di comporre ad onore dell’uno e delle altre senza alcuna alterazione dei fatti».
Pochi mesi dopo viene pubblicato il volume del tenente colonnello Giuseppe Moscardelli Cefalonia, che si basa su un numero limitato di testimonianze: sette. L’autore evidenzia «l’intimo dramma del generale comandante dell’isola, di un uomo dibattuto da opposte esigenze rese inconciliabili dalla singolarità della situazione: la consapevolezza della sorte che incombeva sui suoi soldati; la rigida coscienza del dovere militare; la lealtà cavalleresca verso l’alleato divenuto nemico».
 Mentre è in corso l’indagine della Sottocommissione accertamenti per la concessione della medaglia d’Oro al Valor Militare su proposta del capo di Stato maggiore dell’Esercito, la denuncia contro Apollonio fatta da don Formato provoca la sospensione della pratica e l’apertura di un procedimento presso la 3a Sottocommissione presieduta dal generale Roberto Grimaldi, che il 31 dicembre 1945 produce un «rimprovero» causato dalla «formula di adesione» ai tedeschi attribuita ad Apollonio nel periodo di permanenza sull’isola occupata.
Mentre è in corso l’indagine della Sottocommissione accertamenti per la concessione della medaglia d’Oro al Valor Militare su proposta del capo di Stato maggiore dell’Esercito, la denuncia contro Apollonio fatta da don Formato provoca la sospensione della pratica e l’apertura di un procedimento presso la 3a Sottocommissione presieduta dal generale Roberto Grimaldi, che il 31 dicembre 1945 produce un «rimprovero» causato dalla «formula di adesione» ai tedeschi attribuita ad Apollonio nel periodo di permanenza sull’isola occupata.
Tra il 19 ottobre e il 5 novembre 1948, vi è finalmente una missione governativa militare ufficiale a Cefalonia che ha il compito di approfondire l’inchiesta interrogando anche i testimoni greci; inoltre, si cerca di creare un ossario dei caduti direttamente a Cefalonia, ma la guerra civile allora in corso in Grecia e le tensioni politiche internazionali impediscono di attuare questo progetto.
 Al ritorno della missione, in una Relazione riservata sui fatti di Cefalonia presentata dal tenente colonnello Picozzi, allora all’Ufficio storico, e dedicata in particolare ad Apollonio, sono evidenziate le perplessità per il ruolo di alcuni ufficiali, su cui vi sono testimonianze contraddittorie: quanto al capitano, egli appare per alcuni un eroe e guida della lotta ai tedeschi, ma per altri la sua condotta avrebbe meritato una condanna per insubordinazione, se non per tradimento:
Al ritorno della missione, in una Relazione riservata sui fatti di Cefalonia presentata dal tenente colonnello Picozzi, allora all’Ufficio storico, e dedicata in particolare ad Apollonio, sono evidenziate le perplessità per il ruolo di alcuni ufficiali, su cui vi sono testimonianze contraddittorie: quanto al capitano, egli appare per alcuni un eroe e guida della lotta ai tedeschi, ma per altri la sua condotta avrebbe meritato una condanna per insubordinazione, se non per tradimento:
«Nelle conclusioni della mia relazione ho scritto proponendo di “non perseguire i responsabili di erronee iniziative, anche se dovessero sopraggiungere nuove emergenze e ciò per non incorrere nel rischio che il processo a qualche singolo, diventi il processo di Cefalonia”. Mi riferisco principalmente all’Apollonio. Nell’eventualità di un procedimento da aprire a suo carico, se così decidessero le Autorità Superiori, io prevedo – e ritengo doveroso esporlo – che egli – in parte – si difenderebbe attaccando: ha al suo attivo elementi che potrebbero risultare di indubbia gravità a carico soprattutto di esponenti che sono morti.
Emergerebbero – poiché la realtà non si può negare – le errate iniziative, la propaganda sediziosa, le disparità di vedute, gli atti di indisciplina, certe debolezze del Comando, talune caratteristiche negative delle operazioni, i cedimenti morali, le tergiversazioni, gli episodi di collaborazionismo».
 Picozzi raccomanda di: 1) «Lasciare che il sacrificio della Acqui sia sempre circonfuso da una luce di gloria […]; 2) Insistere sul “movente” ideale che spinse i migliori alla lotta, non insistere sulla disparità di vedute, sulla crisi iniziale, sugli atti di indisciplina con i quali fu messo a dura prova il Comando; 3) non modificare “la storia” […] già fatta, non perseguire i responsabili di erronee iniziative, anche se dovessero sopraggiungere nuove emergenze: e ciò per non incorrere nel rischio che il “processo” a qualche singolo diventi il processo di Cefalonia; 4) Spogliare la tragedia del suo carattere “compassionevole”. Fare dei morti di Cefalonia altrettanti “caduti in guerra”, non presentarli come poveri uccisi».
Picozzi raccomanda di: 1) «Lasciare che il sacrificio della Acqui sia sempre circonfuso da una luce di gloria […]; 2) Insistere sul “movente” ideale che spinse i migliori alla lotta, non insistere sulla disparità di vedute, sulla crisi iniziale, sugli atti di indisciplina con i quali fu messo a dura prova il Comando; 3) non modificare “la storia” […] già fatta, non perseguire i responsabili di erronee iniziative, anche se dovessero sopraggiungere nuove emergenze: e ciò per non incorrere nel rischio che il “processo” a qualche singolo diventi il processo di Cefalonia; 4) Spogliare la tragedia del suo carattere “compassionevole”. Fare dei morti di Cefalonia altrettanti “caduti in guerra”, non presentarli come poveri uccisi».
Picozzi, però, non conosce le carte raccolte dal Servizio informazioni militari durante l’inchiesta condotta tra il 1944 e il 1946 e potrebbe essere stato influenzato dai colloqui avuti con don Formato, anch’egli tra i membri della missione del 1948. La relazione riservata viene quindi trasmessa al capo di Stato maggiore dell’Esercito.
Nonostante una nuova proposta di riconoscimento avanzata dal generale Adolfo Infante, sempre nel 1948, quando vengono assegnate le medaglie alla divisione Acqui e al generale Gandin, Apollonio viene nuovamente escluso, la stessa cosa avverrà ancora nel 1962. Nel 1949 Apollonio viene comunque sottoposto a inchiesta formale, ma nella Relazione finale del Co.Mili.Ter di Roma contro Apollonio, l’estensore, il generale Paolo Supino, torna a rivalutarne l’operato e il ruolo e conferma che «tutti, dopo il 12.IX vollero a Cefalonia la resistenza, dal Comandante di Divisione all’ultimo gregario», mentre sono da considerare «malvagie denigrazioni prive di contenuto le accuse formulate contro l’Apollonio».
 Queste accuse ritorneranno nel corso di un processo intentato dal Tribunale militare di Roma nel 1957. Ancora nel 1975, questo è il giudizio del generale Mario Torsiello, dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito:
Queste accuse ritorneranno nel corso di un processo intentato dal Tribunale militare di Roma nel 1957. Ancora nel 1975, questo è il giudizio del generale Mario Torsiello, dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito:
«Nel corso della sua attività di propaganda contro la cessione delle armi e per un’azione diretta a scacciare le forze tedesche dall’isola il capitano Apollonio agì con lealtà e a viso aperto […]. Il suo comandante, il colonnello Romagnoli concedeva all’Apollonio la libertà di preparare gli animi alla resistenza».
Come si vede, l’operato di Apollonio continua a essere oggetto di interpretazioni opposte. Quanto al generale Gandin, egli aveva ricevuto la medaglia d’Argento al Valor militare dal capo di Stato maggiore, generale Vittorio Ambrosio, nel corso della battaglia di Cefalonia, essa viene commutata in medaglia d’Oro al Valor militare alla memoria con ratifica del 19 agosto 1948. Per lo Stato maggiore, comunque, la «questione» Cefalonia rimane per molti anni imbarazzante e, preferibilmente, da chiudere definitivamente.
 Negli anni seguenti Apollonio continua la sua carriera militare: nel 1965 viene nominato comandante della brigata alpina Julia, nel 1967 ottiene la promozione a generale di divisione e nel 1972 diviene generale di corpo d’armata, poi generale a 4 stelle, e conclude la sua carriera come presidente del Tribunale Supremo militare e poi come presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, tra il 1976 e il 1977, senza tuttavia ottenere alcuna onorificenza dallo Stato.
Negli anni seguenti Apollonio continua la sua carriera militare: nel 1965 viene nominato comandante della brigata alpina Julia, nel 1967 ottiene la promozione a generale di divisione e nel 1972 diviene generale di corpo d’armata, poi generale a 4 stelle, e conclude la sua carriera come presidente del Tribunale Supremo militare e poi come presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, tra il 1976 e il 1977, senza tuttavia ottenere alcuna onorificenza dallo Stato.
Intanto prosegue la sua attività di studioso: nel 1974 ritrova la versione originale della «notifica» di Gandin del 14 settembre 1943 e una parte significativa della documentazione tedesca conservata a Friburgo e restituita nel frattempo dagli americani, nel 1985 pubblica il suo unico libro in cui collega l’accusa di ammutinamento rivolta da Gandin alla sua divisione con la scelta tedesca di non fare prigionieri a Cefalonia e mette a disposizione parte della documentazione ritrovata. Dal 1976 al 1995, anno della sua morte a Firenze, è prima presidente, quindi presidente onorario dell’Associazione Acqui.
Ugualmente interessante è la sorte di don Luigi Ghilardini, cappellano militare in servizio presso il 37° ospedale da campo. Egli era stato l’unico dei cappellani consultati dal generale Gandin contrario alla resa ai tedeschi. Era rimasto a Cefalonia durante l’occupazione tedesca, al contrario di don Formato, che invece era stato inviato in Germania per un periodo di addestramento.
 Rientrato in patria assieme al Raggruppamento banditi Acqui con l’onore delle armi dal Comando alleato del Medio Oriente e dal Comando dell’Esercito greco di liberazione nazionale, è sottoposto a processo per concorso nel reato di violenze con omicidio commesso da militari nemici in danno di militari italiani prigionieri di guerra, viene prosciolto dalle accuse nel 1957, ma gli viene negato ogni riconoscimento. Solo nel 1975 ottiene la medaglia di Bronzo al Valor militare. È segretario dell’Associazione Acqui dal 1947 al 1975.
Rientrato in patria assieme al Raggruppamento banditi Acqui con l’onore delle armi dal Comando alleato del Medio Oriente e dal Comando dell’Esercito greco di liberazione nazionale, è sottoposto a processo per concorso nel reato di violenze con omicidio commesso da militari nemici in danno di militari italiani prigionieri di guerra, viene prosciolto dalle accuse nel 1957, ma gli viene negato ogni riconoscimento. Solo nel 1975 ottiene la medaglia di Bronzo al Valor militare. È segretario dell’Associazione Acqui dal 1947 al 1975.
Il recupero dei resti dei caduti di Cefalonia
È nel corso di queste vicende che il governo italiano decide di riportare in patria tutte le salme dei militari italiani morti in Grecia. Nelle prime settimane dopo la liberazione di Cefalonia, tra l’ottobre e il novembre del 1944, gli italiani sopravvissuti avevano iniziato una prima opera di recupero dei resti dei caduti, ancora abbandonati a centinaia nei campi e sui dirupi. Molti corpi erano stati gettati in mare o in fosse naturali. I miseri resti di 1.139 caduti recuperati erano stati raccolti nel cimitero militare italiano di Drapanos, a pochi chilometri da Argostoli, che divenne un primo provvisorio ossario della divisione Acqui.
L’esumazione sistematica delle salme a Cefalonia inizia nel dicembre 1952, solo nel luglio 1953 sarà possibile recuperare quelli gettati in alcuni pozzi di Troianata, in totale 316. A conclusione di quest’ultima campagna di recupero saranno 2.176 i resti raccolti.
Nella relazione di Ghilardini del 5 settembre 1952 si fa presente la differenza tra il numero di salme che si pensava di recuperare, ovvero circa 4.000, e quelle effettivamente recuperate. Ghilardini mette in evidenza che molti corpi erano stati gettati in mare o bruciati, ma anche i numerosi errori di valutazione nel conteggio e nelle informazioni fornite dalla popolazione e dalle autorità locali. Anche molte fosse comuni rimangono sconosciute.
 “Tutte le Salme comprese credo che si possa indicare da 3.500 a 4.000 la somma dei Caduti nella battaglia e nel successivo eccidio di Cefalonia».
“Tutte le Salme comprese credo che si possa indicare da 3.500 a 4.000 la somma dei Caduti nella battaglia e nel successivo eccidio di Cefalonia».
Da notare che i dati a cui fa riferimento don Ghilardini corrispondono in linea di massima a quelli delle fonti tedesche. Il generale Lanz il 24 settembre aveva comunicato:
«È stato portato a termine il rastrellamento di Cefalonia fino alla punta nord e a Itaka. Circa 4.000 morti in combattimento o fucilati, circa 5.000 italiani fatti prigionieri».
La raccolta delle salme da trasportare in Italia viene effettuata tra l’8 dicembre 1952 e il 19 gennaio 1953. Il Commissariato generale onoranze ai caduti in guerra il 20 gennaio 1953 riassume il numero dei caduti individuati fino ad allora e «sistemati nei depositi di Drapanos, Orto Botanico del Consorzio Agrario o rastrellati in località varie», fissando il totale a 1.826, di cui 219 noti e gli altri ignoti.
Nel febbraio 1953 è effettuato un primo rimpatrio a bordo della nave Stromboli, che trasporta i resti a Bari, dove è presente il presidente della Repubblica, Luigi Einaudi. Un secondo trasporto sarà effettuato, sempre a Bari, qualche mese dopo, con la nave Dalmazia. Oggi riposano nel Sacrario nazionale dei caduti d’oltremare di Bari.
 Nelle varie edizioni del libro di don Formato L’eccidio di Cefalonia, sono indicati i nomi di circa 2.400 caduti della Acqui a Cefalonia, a Corfù o in prigionia. Vi è anche l’elenco compilato negli anni Settanta dalla sezione Regionale Lazio dell’Associazione nazionale superstiti reduci e familiari di caduti divisione Acqui e curato dall’allora presidente generale della Guardia di Finanza Dionisio Spinelli. Tuttavia, anche questo tabulato, ripubblicato a Torino nel 2003, risulta essere incompleto.
Nelle varie edizioni del libro di don Formato L’eccidio di Cefalonia, sono indicati i nomi di circa 2.400 caduti della Acqui a Cefalonia, a Corfù o in prigionia. Vi è anche l’elenco compilato negli anni Settanta dalla sezione Regionale Lazio dell’Associazione nazionale superstiti reduci e familiari di caduti divisione Acqui e curato dall’allora presidente generale della Guardia di Finanza Dionisio Spinelli. Tuttavia, anche questo tabulato, ripubblicato a Torino nel 2003, risulta essere incompleto.
Bruna De Paula, dell’Associazione Italo-Greca, nel 2001 elenca ventuno località di Cefalonia dove vi sono state stragi di massa, giungendo alla cifra di 2.264 morti.
Questi i caduti tra gli ufficiali: tra 58 e 65 in combattimento, tra 151 e 189 fucilati subito dopo la resa, 129 fucilati il 24 settembre, 7 il giorno successivo. Totale 340-395. I superstiti sono 152, di cui 109 reduci da Cefalonia al novembre 1944; 7 ufficiali e 9 ufficiali medici sono rientrati in patria nel 1944 . A questi devono essere aggiunti i 37 superstiti della casetta rossa che hanno aderito alla Repubblica sociale italiana.
A Corfù sono 3 gli ufficiali morti in combattimento, 27 sono fucilati dopo la resa, i superstiti circa 280. Le medaglie d’Oro per le vicende di Cefalonia e Corfù sono 22, tutte alla memoria: Abele Ambrosini, Elio Bettini, Marcello Bonacchi, Primo Cai, Antonio Cei, Antonio Cianciullo, Gianni Clerici, Antonio Gandin, Edoardo Luigi Gherzi, Francesco La Rosa, Luigi Lusignani, Benedetto Maffeis, Giovanni Maltese, Mario Mastrangelo, Achille Olivieri, Carmelo Onorato, Orazio Petrucelli, Armando Pica, Guerrino Poli, Mario Romagnoli, Alfredo Sandulli, Antonio Valgoi.
 Le medaglie d’Oro alla bandiera sono 5: ai tre reggimenti di Fanteria, il 17°, il 18° e il 317°, al 33° reggimento Artiglieria, alla Guardia di Finanza. Nel complesso tutte queste medaglie sono assegnate ai combattenti e ai Corpi operanti a Cefalonia, solo 3 per quelli di Corfù.
Le medaglie d’Oro alla bandiera sono 5: ai tre reggimenti di Fanteria, il 17°, il 18° e il 317°, al 33° reggimento Artiglieria, alla Guardia di Finanza. Nel complesso tutte queste medaglie sono assegnate ai combattenti e ai Corpi operanti a Cefalonia, solo 3 per quelli di Corfù.
L’OCCASIONE PERDUTA DEI PROCESSI
Processare i criminali di guerra
L’Italia, tra i paesi che hanno partecipato alla Seconda guerra mondiale, si trova in una situazione contraddittoria, perché se fino all’8 settembre del 1943 costituiva il principale alleato europeo della Germania nazista, condividendone in molti casi le responsabilità, anche criminali, dopo quella data è essa stessa vittima delle rappresaglie e delle vendette dell’ex alleato, sia sul territorio nazionale occupato, sia nelle zone di operazioni militari congiunte, come i Balcani.
Pertanto, il governo italiano post-fascista si è trovato nell’ambigua posizione di dovere rivendicare giustizia per i crimini perpetrati contro i proprî cittadini e contemporaneamente difendersi dalle richieste analoghe dei paesi occupati dalle sue truppe a partire dal 1930-31.
 Con la «Dichiarazione di Mosca» (30 ottobre 1943), le Nazioni unite decidono che a guerra finita i criminali di guerra della Germania e dei governi alleati sarebbero stati giudicati dai paesi dove erano avvenute le azioni delittuose. Su questa base, nei due anni seguenti, diverse nazioni chiedono l’estradizione di militari e civili italiani che avevano operato nei territori sotto occupazione dell’Italia: Iugoslavia, Grecia, Albania, Etiopia, Gran Bretagna, Francia, Urss.
Con la «Dichiarazione di Mosca» (30 ottobre 1943), le Nazioni unite decidono che a guerra finita i criminali di guerra della Germania e dei governi alleati sarebbero stati giudicati dai paesi dove erano avvenute le azioni delittuose. Su questa base, nei due anni seguenti, diverse nazioni chiedono l’estradizione di militari e civili italiani che avevano operato nei territori sotto occupazione dell’Italia: Iugoslavia, Grecia, Albania, Etiopia, Gran Bretagna, Francia, Urss.
Il maggior numero di richieste proviene dalla Iugoslavia, con una lista di circa 1.200 nomi, poi ridotta a 729. Le prime iniziative iugoslave sono del febbraio 1944, e sono contemporanee all’avvio dei lavori dell’Alto commissario per l’epurazione creato dal governo Badoglio. Alcuni dei principali responsabili dell’occupazione dei Balcani sono inquisiti formalmente, ma gli alti gradi dell’esercito si oppongono con ogni mezzo all’inchiesta.
Alcuni dei militari accusati di crimini di guerra, come Gastone Gambara, Mario Roatta e Taddeo Orlando (il responsabile dei rastrellamenti di Lubiana), assumono nel frattempo responsabilità ai massimi livelli; Orlando diventa ministro della Guerra; Roatta, già capo di Stato maggiore dell’Esercito, destituito e arrestato alla fine del 1944, riuscirà a fuggire dal carcere militare.
 Quanto al primo ministro Badoglio, egli era il principale responsabile della campagna militare contro l’Etiopia, che era stata condotta contravvenendo ai principî della Società delle Nazioni, e dell’attacco alla Grecia del 1940. Agli inizi del 1945 la Iugoslavia si rivolge alla United Nations War Crimes Commission per ottenere la consegna dei responsabili italiani; in luglio la richiesta viene trasferita al governo italiano che continua a far finta di non sentire.
Quanto al primo ministro Badoglio, egli era il principale responsabile della campagna militare contro l’Etiopia, che era stata condotta contravvenendo ai principî della Società delle Nazioni, e dell’attacco alla Grecia del 1940. Agli inizi del 1945 la Iugoslavia si rivolge alla United Nations War Crimes Commission per ottenere la consegna dei responsabili italiani; in luglio la richiesta viene trasferita al governo italiano che continua a far finta di non sentire.
Nell’aprile 1946, quando gli alleati, ormai spazientiti, minacciano di arrestare i criminali di guerra italiani per consegnarli alla Iugoslavia, il governo italiano decide la costituzione di una Commissione d’inchiesta presso il ministero della Guerra e richiede di poter processare direttamente i responsabili.
 I lavori della Commissione procedono con la massima lentezza, con l’obiettivo di insabbiare tutto; la relazione conclusiva arriva tre anni dopo, nel 1949, e contiene una lista di 168 presunti criminali; nel frattempo il ministero degli Esteri raccoglie una «controdocumentazione» tesa a dimostrare la loro innocenza e a scaricare le responsabilità sui partigiani iugoslavi.
I lavori della Commissione procedono con la massima lentezza, con l’obiettivo di insabbiare tutto; la relazione conclusiva arriva tre anni dopo, nel 1949, e contiene una lista di 168 presunti criminali; nel frattempo il ministero degli Esteri raccoglie una «controdocumentazione» tesa a dimostrare la loro innocenza e a scaricare le responsabilità sui partigiani iugoslavi.
Nel 1951 la Commissione viene sciolta senza che nessuno dei 39 deferiti alla Procura militare sia stato processato. Intanto la situazione internazionale si è completamente modificata: con l’avvio della guerra fredda, inglesi e americani non solo non hanno più interesse a perseguire i responsabili di crimini contro l’umanità e la sicurezza – per i quali erano stati organizzati i processi di Norimberga – ma sono interessati a riallacciare i rapporti con gli ex nemici in funzione anticomunista.
È questo il caso dell’Italia e della Germania del dopoguerra. Tra i trentatre crimini previsti nei processi di Norimberga sarebbero inclusi i comportamenti di molti degli accusati italiani: massacro sistematico, eccidio di ostaggi, tortura, deportazione, lavoro forzato, guerra senza quartiere, distruzione di edifici religiosi…
 Nello stesso periodo, e in particolare a partire dai primi mesi del 1945, il governo italiano è intenzionato a ricercare e processare i colpevoli delle stragi che avevano come vittime cittadini italiani. Ovviamente quest’azione non sarebbe possibile senza la piena collaborazione dei governi alleati. Nell’estate del 1945, con Ferruccio Parri come primo ministro, si giunge a un accordo di massima tra governo italiano e quartier generale alleato: gli inglesi del War Crimes Group South West, con sede a Klagenfurt, avrebbero avviato un unico processo contro i generali tedeschi colpevoli di crimini di guerra; gli altri imputati, dal grado di colonnello in giù, sarebbero stati affidati alla giurisdizione italiana.
Nello stesso periodo, e in particolare a partire dai primi mesi del 1945, il governo italiano è intenzionato a ricercare e processare i colpevoli delle stragi che avevano come vittime cittadini italiani. Ovviamente quest’azione non sarebbe possibile senza la piena collaborazione dei governi alleati. Nell’estate del 1945, con Ferruccio Parri come primo ministro, si giunge a un accordo di massima tra governo italiano e quartier generale alleato: gli inglesi del War Crimes Group South West, con sede a Klagenfurt, avrebbero avviato un unico processo contro i generali tedeschi colpevoli di crimini di guerra; gli altri imputati, dal grado di colonnello in giù, sarebbero stati affidati alla giurisdizione italiana.
Sembra che la decisione di concentrare presso la Procura generale del Tribunale Supremo militare tutti i fascicoli dedicati alle istruttorie o alle notizie relative ai crimini commessi nel corso della guerra – sottraendoli così al giudice naturale – possa spiegarsi con la volontà di avviare quella ripartizione di competenze tra Italia e governi alleati.
 In effetti, la decisione è presa dalla presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 ottobre 1945; circa i materiali raccolti, la Procura «provvederà a esaminarli per estrarne le denunzie del caso»; viene inoltre allegata una scheda per la denuncia dei fatti di competenza della Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni unite.
In effetti, la decisione è presa dalla presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 ottobre 1945; circa i materiali raccolti, la Procura «provvederà a esaminarli per estrarne le denunzie del caso»; viene inoltre allegata una scheda per la denuncia dei fatti di competenza della Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni unite.
La procedura seguita appare sotto molti aspetti criticabile, intanto perché la Procura generale militare non ha potere di indagine. Tuttavia questa decisione, almeno all’inizio, non comporta un blocco dei processi: fino al 1947 le Corti militari britanniche operanti in Italia celebrano quarantanove processi per crimini di guerra, tra questi quelli contro i responsabili dell’eccidio delle Forze Ardeatine e contro Kesserling.
Ancora nell’estate del 1946 si pensa a un unico processo per i crimini di guerra commessi in Italia, utilizzando personale e strutture del Tribunale militare internazionale di Norimberga, poi gli inquirenti inglesi rinunciano: all’Italia non è più applicata la resa incondizionata, mentre continua il braccio di ferro tra l’ambasciatore italiano a Londra e il presidente del Tribunale Supremo militare inglese sulla consegna dei generali italiani responsabili di crimini nei Balcani; inoltre i conservatori britannici sono contrari a colpire i militari tedeschi e italiani in quanto tali, come richiede il governo iugoslavo; la situazione è complicata dalla repressione iugoslava a Trieste (le foibe) e dal contenzioso territoriale su Trieste e sul suo retroterra.
 Nel dicembre 1947 l’attività degli alleati si interrompe, ma essi continuano a trasmettere all’Italia i dati relativi a diversi criminali di guerra, come nel caso di Reder, processato dalla giustizia italiana nel 1951. Soltanto una dozzina di procedimenti viene portata avanti. Anche per quanto riguarda la responsabilità di cittadini italiani collaborazionisti, dopo una fase iniziale in cui le Corti straordinarie di assise giudicano migliaia di responsabili di gravi reati, in genere commessi quando erano membri delle forze armate della Repubblica sociale italiana oppure assieme ai tedeschi, alla fine degli anni Quaranta la Corte di Cassazione procede all’annullamento o al rinvio a nuovo ruolo di molti processi già conclusi con severe condanne; in questo modo sono pochi i condannati ancora in carcere nel corso degli anni Cinquanta: non più di dieci persone.
Nel dicembre 1947 l’attività degli alleati si interrompe, ma essi continuano a trasmettere all’Italia i dati relativi a diversi criminali di guerra, come nel caso di Reder, processato dalla giustizia italiana nel 1951. Soltanto una dozzina di procedimenti viene portata avanti. Anche per quanto riguarda la responsabilità di cittadini italiani collaborazionisti, dopo una fase iniziale in cui le Corti straordinarie di assise giudicano migliaia di responsabili di gravi reati, in genere commessi quando erano membri delle forze armate della Repubblica sociale italiana oppure assieme ai tedeschi, alla fine degli anni Quaranta la Corte di Cassazione procede all’annullamento o al rinvio a nuovo ruolo di molti processi già conclusi con severe condanne; in questo modo sono pochi i condannati ancora in carcere nel corso degli anni Cinquanta: non più di dieci persone.
Un dato assolutamente sproporzionato per difetto; si pensi che nello stesso periodo in Francia sono stati condannati a pene di detenzione o sono sotto processo 1.300 militari tedeschi, 1.700 in Iugoslavia, 400 in Belgio, 300 in Olanda, 150 in Norvegia.
 È evidente la rinuncia della magistratura italiana, profondamente penetrata dalla cultura del Ventennio fascista, a svolgere la propria funzione istituzionale all’interno della nuova Italia repubblicana. Viceversa, procedono a pieno ritmo i processi contro gli ex partigiani. Nel frattempo, infatti, è cambiato il clima complessivo: il 31 maggio 1947 le sinistre sono escluse dal governo, è iniziata la guerra fredda e ci si trova nella necessità di riarmare la Germania.
È evidente la rinuncia della magistratura italiana, profondamente penetrata dalla cultura del Ventennio fascista, a svolgere la propria funzione istituzionale all’interno della nuova Italia repubblicana. Viceversa, procedono a pieno ritmo i processi contro gli ex partigiani. Nel frattempo, infatti, è cambiato il clima complessivo: il 31 maggio 1947 le sinistre sono escluse dal governo, è iniziata la guerra fredda e ci si trova nella necessità di riarmare la Germania.
Continuare a spingere per l’estradizione e la punizione dei criminali tedeschi rafforzerebbe la richiesta della Grecia e della Iugoslavia per analoghe misure contro i criminali di guerra italiani degli anni dell’occupazione dei Balcani.
In questo nuovo contesto storico-politico, la concentrazione dei fascicoli presso un’unica procura diventa funzionale al blocco dei processi, attraverso l’archiviazione delle indagini. Né il procuratore Umberto Borsari, né Arrigo Mirabella, suo sostituto dal 1958, ne decidono il trasferimento alle procure competenti. Nel 1960, come si vedrà, verrà invece decisa «l’archiviazione provvisoria» di tutti i fascicoli raccolti.
 Il rifiuto del governo italiano di estradare i criminali di guerra non può che bloccare l’altra legittima richiesta del Paese, quella di processare i responsabili tedeschi delle stragi e delle rappresaglie perpetrate in Italia e nei Balcani tra l’8 settembre 1943 e il maggio 1945.
Il rifiuto del governo italiano di estradare i criminali di guerra non può che bloccare l’altra legittima richiesta del Paese, quella di processare i responsabili tedeschi delle stragi e delle rappresaglie perpetrate in Italia e nei Balcani tra l’8 settembre 1943 e il maggio 1945.
Per l’Italia questo fallimento ha comportato, sul piano storico, il passaggio alla democrazia rappresentativa senza che vi sia stata un’effettiva defascistizzazione, anzi, si è addirittura perduta la memoria di quei fatti che abbiamo ricostruito. Circa 2.000 fascicoli riguardanti le inchieste avviate alla fine della guerra dagli alleati e dalle procure italiane sono stati nascosti nel cosiddetto «armadio della vergogna» all’interno della Procura militare di Roma per essere riportati alla luce, per caso, solo nel 1994.
Il Processo di Norimberga
 Il massacro di Cefalonia è stato, nel dopoguerra, al centro di diversi processi. Innanzitutto nel 1948, davanti al Tribunale internazionale di Norimberga, nell’ambito del procedimento n. 7 dei processi per crimini di guerra, dov’è inquisito il generale Lanz, già comandante del 22° corpo d’armata da montagna.
Il massacro di Cefalonia è stato, nel dopoguerra, al centro di diversi processi. Innanzitutto nel 1948, davanti al Tribunale internazionale di Norimberga, nell’ambito del procedimento n. 7 dei processi per crimini di guerra, dov’è inquisito il generale Lanz, già comandante del 22° corpo d’armata da montagna.
Lanz potrà avvalersi delle dichiarazioni di sostegno di molti ex commilitoni, che in questo modo cercavano di salvare «l’onore delle forze armate tedesche». La responsabilità dell’eccidio viene rigettata su Gandin.
 Così si esprime l’avvocato difensore nell’arringa finale, dopo aver sottolineato, contro i dati fattuali disponibili, che Lanz si sarebbe addirittura prodigato personalmente per mitigare le richieste di Hitler, salvando la vita a numerosi ufficiali italiani:
Così si esprime l’avvocato difensore nell’arringa finale, dopo aver sottolineato, contro i dati fattuali disponibili, che Lanz si sarebbe addirittura prodigato personalmente per mitigare le richieste di Hitler, salvando la vita a numerosi ufficiali italiani:
«Il generale Gandin era un militare il quale come cittadino di uno stato allora ancora neutrale mosse guerra contro la Germania di propria iniziativa e sotto la sua responsabilità. Egli fece questo, inoltre, contro un ordine esplicito del suo comandante superiore italiano, che, tramite il suo capo di Stato maggiore, aveva invitato tanto lui quanto il comandante italiano di Corfù a consegnare senz’altro le armi a Lanz.
Soprattutto, poi, [Gandin agì] contro l’ordine, ripetutamente espresso, del suo comandante in capo di Atene, che si era arreso a nome di tutta l’11a armata di fronte ai tedeschi, e aveva espresso, per quanto riguardava la consegna delle armi, un consenso che impegnava anche il generale Gandin, che era un suo subordinato.
Quando, nel settembre 1943, il generale Gandin condusse le sue truppe in combattimento contro le forze di occupazione tedesche, egli non agiva come un soldato di uno Stato che si trovava in guerra con la Germania, ma era, insieme a tutta la sua divisione, un franco tiratore».
 Nel corso dell’interrogatorio Lanz farà costantemente ricorso al «non ricordo», oppure, a proposito delle fucilazioni degli ufficiali, egli ribadisce che sarebbero avvenute secondo la legge marziale, affermazione chiaramente negata da tutti i sopravvissuti italiani agli eccidi.
Nel corso dell’interrogatorio Lanz farà costantemente ricorso al «non ricordo», oppure, a proposito delle fucilazioni degli ufficiali, egli ribadisce che sarebbero avvenute secondo la legge marziale, affermazione chiaramente negata da tutti i sopravvissuti italiani agli eccidi.
Questi testimoni, però, come quelli greci, non saranno sentiti nel corso del processo. Nella sua deposizione al processo Lanz dichiara:
« […] io avevo l’impressione che il generale Gandin cercasse un pretesto per non cedere le armi […] egli dava continuamente nuove ragioni per non cedere le armi, nonostante che sapesse benissimo quale fosse la situazione. La sua Armata gli aveva ordinato la resa […] la sua Armata si era arresa, ed io anche avevo dato l’ordine di cedere le armi».
Il Tribunale, nella sentenza emessa il 19 febbraio 1948, accetterà parzialmente l’interpretazione della difesa di Lanz, limitando così la condanna a dodici anni, di cui solo cinque scontati effettivamente, nonostante l’opinione del generale Taylor, capo dell’accusa in questo processo:
«Questa strage deliberata di ufficiali italiani che erano stati catturati o si erano arresi è una delle azioni più arbitrarie e disonorevoli nella lunga storia del combattimento armato. Questi uomini, infatti, indossavano regolare uniforme. Portavano le proprie armi apertamente e seguivano le regole e le usanze di guerra.
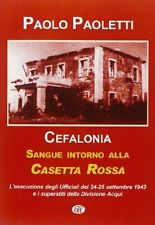 Erano guidati da capi responsabili che, nel respingere l’attacco, obbedivano a ordini del maresciallo Badoglio, loro comandante in capo militare e capo politico debitamente accreditato dalla loro Nazione. Essi erano soldati regolari che avevano diritto a rispetto, a considerazione umana e a trattamento cavalleresco […]. Se i soldati della Acqui erano prigionieri di guerra grazie alla capitolazione della XI Armata del generale Vecchiarelli, allora è chiaro che essi avevano diritto alla protezione garantita dalla convenzione di Ginevra del 1929 […]
Erano guidati da capi responsabili che, nel respingere l’attacco, obbedivano a ordini del maresciallo Badoglio, loro comandante in capo militare e capo politico debitamente accreditato dalla loro Nazione. Essi erano soldati regolari che avevano diritto a rispetto, a considerazione umana e a trattamento cavalleresco […]. Se i soldati della Acqui erano prigionieri di guerra grazie alla capitolazione della XI Armata del generale Vecchiarelli, allora è chiaro che essi avevano diritto alla protezione garantita dalla convenzione di Ginevra del 1929 […]
L’ordine di considerare le truppe tedesche nemiche […] non solo determinava uno stato di guerra di fatto tra l’Italia e la Germania, ma implicitamente autorizzava atti di ostilità contro i tedeschi nel caso in cui l’atteggiamento di questi ultimi verso gli italiani fosse diventato aggressivo».
 La Procura militare indaga
La Procura militare indaga
La strage della Acqui ha avuto anche in Italia un paradossale strascico giudiziario, che ha finito per mettere uno contro l’altro i parenti delle vittime e i sopravvissuti, tra i quali alcuni dei protagonisti della resistenza antitedesca, guastando in parte la memoria di quella che dovrebbe essere considerata una pagina eroica della nostra storia recente.
In particolare hanno continuato a contrapporsi, su molti aspetti parziali e sul rispettivo ruolo, le differenti interpretazioni di due dei giovani capitani protagonisti della lotta antitedesca: Renzo Apollonio e Amos Pampaloni, le cui strade si erano divise già dopo la fine dei combattimenti.
Il Tribunale militare territoriale di Roma, nel 1957, in seguito alle denunce del genitore di un caduto, il sottotenente Lelio Triolo, prelevato il 25 settembre 1943 dall’ospedale di Argostoli e subito fucilato assieme ad altri 6 ufficiali per rappresaglia contro la fuga del capitano Pietro Bianchi e del tenente Evardo Benedetti, ha aperto un’istruttoria formale contro 28 ufficiali, sottufficiali e truppa della Acqui, accusati di «cospirazione e rivolta» contro il generale Gandin, che sarebbe stato spinto allo scontro coi tedeschi contro la sua volontà.

Il generale Gandin
Riportiamo due stralci dalla richiesta di rinvio a giudizio:
«Rivolta continuata perché tra l’8 e il 15 settembre 1943, in Cefalonia, essendo in servizio armato, con azioni diverse esecutive di un medesimo disegno criminoso, rifiutava insieme ad altri numerosi militari obbedienza agli ordini del comandante la divisione Acqui, generale Antonio Gandin, di astenersi da ogni attività ostile e di predisporsi alla cessione ai tedeschi delle armi pesanti».
«Cospirazione perché tra l’8 e il 15 settembre 1943, in Cefalonia, si accordavano tra loro per indurre la truppa alla rivolta e per commettere atti di ostilità contro i tedeschi al fine di creare il “fatto compiuto” e impedire così al comandante la divisione Acqui, generale Antonio Gandin, l’esercizio dei suoi poteri».
Tra gli imputati vi sono i capitani Renzo Apollonio e Amos Pampaloni, accusati anche per «insubordinazione con minaccia verso superiore ufficiale, perché il 12.9.1943 minacciavano il comandante la divisione di far rifiutare la truppa alla obbedienza, al fine di influire sul superiore onde farlo desistere dal proposito di ordinare la consegna ai tedeschi delle armi pesanti».
 Intanto era stata aperta un’istruttoria contro 30 militari tedeschi accusati dell’uccisione di prigionieri di guerra. Già alla fine del 1956, il Procuratore militare aveva chiesto alle autorità di governo, in particolare al ministro degli Esteri Martino, di attivare il procedimento di estradizione per gli imputati, da presentare alla Repubblica federale di Germania.
Intanto era stata aperta un’istruttoria contro 30 militari tedeschi accusati dell’uccisione di prigionieri di guerra. Già alla fine del 1956, il Procuratore militare aveva chiesto alle autorità di governo, in particolare al ministro degli Esteri Martino, di attivare il procedimento di estradizione per gli imputati, da presentare alla Repubblica federale di Germania.
La magistratura tedesca rifiuta nel frattempo di collaborare con quella italiana: subito dopo la guerra, molti ex ufficiali, anche quelli condannati per crimini di guerra, sono stati reinseriti nell’esercito della Repubblica federale tedesca, e questo col consenso esplicito del governo inglese e di quello americano.
Tra questi l’ex maggiore Reinhold Klebe, cioè uno dei massimi responsabili della strage di Cefalonia, che nel 1956 era ancora in servizio nei reparti di truppe da montagna. Con l’ingresso della Repubblica federale tedesca nella Nato, intorno al 1956 vengono archiviati, nei paesi occidentali, la gran parte dei procedimenti attivati contro militari tedeschi per crimini di guerra.
È in questo contesto che nel mese di ottobre del 1956 si sviluppa un carteggio sull’eventualità di richiedere l’estradizione di militari tedeschi, come richiesto dalla Procura militare di Roma, tra due ministri italiani, Gaetano Martino, agli Esteri, e Paolo Emilio Taviani, allora alla Difesa; alla fine essi concordano che è opportuno mettere una pietra sopra l’inchiesta: in tempi di guerra fredda e di riarmo della Germania federale, non conviene mettere in cattiva luce la «gloriosa» tradizione della Wehrmacht.
 La ragion di stato finisce così per prevalere sulla ricerca della verità e sulla punizione dei colpevoli. Tra i militari tedeschi nominati nelle carte studiate da Martino vi è il generale di aviazione Wilhelm Speidel, già comandante in Grecia nel 1943, fratello del generale Hans Speidel, designato dalla Nato al comando delle truppe di terra del settore centrale di Shape.
La ragion di stato finisce così per prevalere sulla ricerca della verità e sulla punizione dei colpevoli. Tra i militari tedeschi nominati nelle carte studiate da Martino vi è il generale di aviazione Wilhelm Speidel, già comandante in Grecia nel 1943, fratello del generale Hans Speidel, designato dalla Nato al comando delle truppe di terra del settore centrale di Shape.
Il ministro sottolinea «gli interrogativi che potrebbe far sorgere da parte del Governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul comportamento del soldato tedesco. Proprio in questo momento, infatti, tale governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle forze armate, di cui la Nato reclama con impazienza l’allestimento».
 Con sentenza dell’8 luglio 1957, il giudice istruttore militare assolve gli ufficiali italiani perché la loro attività non costituisce reato. Sarà pubblicata nel 1974 in appendice al libro di don Luigi Ghilardini, Sull’arma si cade ma non si cede.
Con sentenza dell’8 luglio 1957, il giudice istruttore militare assolve gli ufficiali italiani perché la loro attività non costituisce reato. Sarà pubblicata nel 1974 in appendice al libro di don Luigi Ghilardini, Sull’arma si cade ma non si cede.
La seconda parte dell’inchiesta viene proseguita ancora per qualche anno, inizialmente vengono prosciolti 21 militari tedeschi, poi, nel giugno 1960, il procedimento si conclude definitivamente col proscioglimento dei 9 imputati rimasti. Nel 1956 Amos Pampaloni aveva ricevuto la medaglia d’Argento al Valor militare.
La giustizia tedesca e quella italiana
Qualche anno più tardi, nel 1964, dopo la pubblicazione del romanzo di Marcello Venturi Bandiera bianca a Cefalonia e grazie all’interessamento e alle pressioni del cacciatore di nazisti Simon Wiesenthal, viene condotta un’istruttoria da un giudice di Dortmund, il procuratore Nachtweh. L’inchiesta si conclude con l’archiviazione, comunicata allo stesso Wiesenthal nel 1969.
 Nonostante abbia sentito 231 testimoni, il procuratore tedesco non riesce a rintracciare alcuni dei protagonisti della strage. Se Hirschfeld era morto in Ucraina all’inizio del 1945, altri responsabili sono però ancora vivi, in particolare Lanz, Barge, Heidrich e Kuhn.
Nonostante abbia sentito 231 testimoni, il procuratore tedesco non riesce a rintracciare alcuni dei protagonisti della strage. Se Hirschfeld era morto in Ucraina all’inizio del 1945, altri responsabili sono però ancora vivi, in particolare Lanz, Barge, Heidrich e Kuhn.
Vengono ascoltati solo due greci e due italiani: lo scrittore Marcello Venturi e padre Luigi Ghilardini. Ai sensi della legge tedesca, l’impossibilità di dimostrare che si fosse trattato di assassinio aggravato e non di omicidio semplice, cioè di un delitto particolarmente efferato oppure commesso per bassi motivi, rende obbligatoria la chiusura delle indagini.
All’interno della Procura lavoravano allora magistrati che erano stati iscritti a organizzazioni nazionalsocialiste. Nel 1965, il governo tedesco – considerando che in quell’anno scadevano i termini di prescrizione per molti dei reati connessi ai procedimenti per crimini di guerra – richiede a quello italiano di comunicare notizie e dati su eventuali procedimenti su reati non ancora prescritti; il ministro della Difesa, il 16 febbraio 1965, risponde affermando che «l’autorità giudiziaria italiana conserva il pieno esercizio della propria giurisdizione», quindi informa di venti casi tra quelli particolarmente documentati, che saranno selezionati e trasmessi.
 Non si è a conoscenza di come si sia attivata la giustizia tedesca. Nel decennio scorso vi è stata una ripresa di interesse da parte della televisione tedesca sui fatti di Cefalonia. Un primo servizio è stato curato dalla tv pubblica Zdf nel marzo 2001.
Non si è a conoscenza di come si sia attivata la giustizia tedesca. Nel decennio scorso vi è stata una ripresa di interesse da parte della televisione tedesca sui fatti di Cefalonia. Un primo servizio è stato curato dalla tv pubblica Zdf nel marzo 2001.
Nel gennaio 2003, un secondo ampio filmato, Mord auf Kephallonia (Eccidio a Cefalonia), è stato trasmesso dal primo canale Ard. In questo nuovo clima di attenzione, che contrasta col totale silenzio del passato, la stessa Procura di Dormund, competente per i crimini di guerra, a partire dal 2001 ha riaperto le indagini.
Ecco cosa diceva in un’intervista a «Il Tempo» nel novembre 2001 il procuratore Ulrich Maaß:
«Sulla base delle mie ricerche sono riuscito a individuare una cinquantina di ufficiali che all’epoca dei fatti si resero responsabili di quei crimini. Dieci sono viventi».
 Nell’archiviazione del 1969 pesò anche il tipo di accusa, «omicidio colposo di subordinato [i prigionieri italiani]», che per la legislazione tedesca prevede la prescrizione dopo 15 anni. Ora si parla invece di omicidio «volontario» e «concorso in omicidio».
Nell’archiviazione del 1969 pesò anche il tipo di accusa, «omicidio colposo di subordinato [i prigionieri italiani]», che per la legislazione tedesca prevede la prescrizione dopo 15 anni. Ora si parla invece di omicidio «volontario» e «concorso in omicidio».
Ancora Maaß:
«Abbiamo avuto la possibilità di consultare gli archivi americani, inglesi e austriaci. E c’è la possibilità di esaminare i documenti raccolti sulla strage dalla Stasi, i servizi segreti dell’ex Germania dell’Est».
Dalle prime indagini sono emersi i nomi di almeno 200 Gebirgsjaeger (le truppe speciali da montagna); 10 di loro sono stati rintracciati, 9 ufficiali e 1 sottufficiale, che avevano allora tra i settantanove e novantadue anni. Anche l’apparizione di diari, memorie e interviste di militari apriva uno spiraglio nella coscienza dell’opinione pubblica tedesca.
Alfred Richter, un sottufficiale presente a Cefalonia, intervistato dalla rete televisiva tedesca Zdf, ricorda:
«Vengono sparati soltanto pochi colpi, poi gli italiani agitano i fazzoletti bianchi e cominciano a venir fuori a gruppi, correndo. Ma quando noi raggiungiamo l’altura, li troviamo tutti per terra, morti, sono tutti stati colpiti alla testa. Quelli del 98° li hanno dunque uccisi dopo che si erano arresi».
 Due compagnie italiane si arrendono al battaglione di Richter:
Due compagnie italiane si arrendono al battaglione di Richter:
«Non vogliono combattere contro di noi e pensano di aver salvato la vita arrendendosi. Torniamo a Frangata e consegnamo i prigionieri. Ma qui li attende una sentenza terribile. Li portano vicino al ponte, nei campi recintati da muri fuori dalla città, e li fucilano. Rimaniamo due ore sul posto e per tutto il tempo sentiamo i colpi senza interruzione […], le grida arrivano fin nelle case dei greci.
Anche medici e preti partecipano alle esecuzioni. Un gruppo di soldati bavaresi prova a rifiutarsi, ma un ufficiale li minaccia di mettere anche loro al muro. Fa una figura tragicomica un prigioniero, che si salva la vita salendo su una pedana e cantando con bella voce arie d’opera italiana, mentre i suoi compagni vengono uccisi».
 Viene anche rintracciato il capo di uno dei plotoni d’esecuzione, il sottotenente Mühlhauser, che fucilò il generale Gandin e il primo gruppo di ufficiali:
Viene anche rintracciato il capo di uno dei plotoni d’esecuzione, il sottotenente Mühlhauser, che fucilò il generale Gandin e il primo gruppo di ufficiali:
«Nemmeno mia moglie lo sa, ma fui io, in quel settembre del 1943, a comandare il plotone d’esecuzione di Cefalonia. Vidi gli ufficiali italiani cadere in silenzio sotto i nostri colpi, e ancora oggi ricordo quell’ultimo grido del generale Antonio Gandin, il comandante della guarnigione italiana, prima di cadere ucciso: “Viva il Re, viva la Patria».
Nel luglio 2006 il giudice istruttore di Monaco di Baviera August Stern decide l’archiviazione dell’accusa contro l’ex ufficiale:
«Nel caso dell’imputato si deve riconoscere un reato di omicidio, prescritto e non di omicidio aggravato».
Nella motivazione della sentenza si legge:
«Le forze militari italiane non erano normali prigionieri di guerra. Inizialmente erano alleati dei tedeschi e si sono poi trasformati in nemici combattenti diventando traditori: in questo caso è come se parti delle truppe tedesche avessero disertato e si fossero schierati dalla parte del nemico».
 Si tratta di una interpretazione che riporta indietro di decenni il giudizio tedesco sui soldati italiani, dimenticando che essi ubbidivano a un governo legittimo, quello di Badoglio e del Re.
Si tratta di una interpretazione che riporta indietro di decenni il giudizio tedesco sui soldati italiani, dimenticando che essi ubbidivano a un governo legittimo, quello di Badoglio e del Re.
Nel 2007 viene rigettato l’appello presentato dalla figlia del capitano Francesco De Negri, l’unica a costituirsi parte civile nel processo. Nello stesso anno si chiude con l’archiviazione anche l’inchiesta del procuratore di Dormund Ulrich Maaß contro 7 ufficiali della Wehrmacht accusati per le stragi di Cefalonia: non luogo a procedere a seguito delle indagini svolte in due distinti periodi tra il 1964 e il 1968, tra il 2001 e il 2007, nel corso delle quali sarebbero state coinvolte 2.400 persone in Germania, 860 in Austria e 86 in Italia, interrogati oltre 500 testimoni oculari.
Contemporaneamente, il procuratore militare di Roma Antonino Intelisano iscrive al registro degli indagati i 7 imputati assolti in Germania per omicidio plurimo aggravato.
I materiali raccolti in Germania, trentasette faldoni e cinquantuno pagine di requisitoria, vengono richiesti dall’Italia. Mühlhauser nel 2009 viene rinviato a giudizio dal Pubblico ministero del Tribunale militare di Roma, Gioacchino Tornatore.
 Si sono costituiti parte civile Marcella De Negri, Paola Fioretti e Luigi Conte. La vicenda giudiziaria è attualmente ancora in corso.
Si sono costituiti parte civile Marcella De Negri, Paola Fioretti e Luigi Conte. La vicenda giudiziaria è attualmente ancora in corso.
L’armadio della vergogna
I continui ostacoli posti alle indagini provocano nel corso degli anni numerose polemiche, creano disillusione e rancore tra i sopravvissuti e i familiari delle vittime, che in più occasioni rimproverano le Istituzioni di averli dimenticati. Molti documenti cominciano a essere divulgati solo da qualche anno, contribuendo a fare luce su alcuni particolari ancora sconosciuti.
Nel 1994, il procuratore militare di Roma, Antonino Intelisano, mentre sta indagando su due criminali di guerra, Erich Priebke e Karl Hass, si imbatte, all’interno del palazzo Cesi di via Acquasparta a Roma, sede della Procura militare, in un armadio con le ante rivolte contro il muro, in una stanza da tempo abbandonata, chiusa da un cancello.
 L’armadio contiene 695 fascicoli sulle stragi fasciste e naziste, il timbro risale al 1960, ai tempi in cui era Procuratore militare Enrico Santacroce a cui spettava la decisione di archiviare «provvisoriamente» i fascicoli.
L’armadio contiene 695 fascicoli sulle stragi fasciste e naziste, il timbro risale al 1960, ai tempi in cui era Procuratore militare Enrico Santacroce a cui spettava la decisione di archiviare «provvisoriamente» i fascicoli.
In un registro è contenuto l’elenco di 2.274 procedimenti iscritti nel Ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi, quello su Corfù è il n. 5, quello su Cefalonia è il numero 1.188. In quest’ultimo vi sono anche i nomi dei militari tedeschi coinvolti nel procedimento: tenente colonnello Barge, maggiore Hirschfeld, maggiore Nennstiel, capitano von Stoephasius, tenente Radenaker, sottotenenti Lepiold, Stettner, Heindrich, Bauer, Fremmel, Lulai, Gregor, Wiener, Hart, Kuller, Kiker, Kaiser.

L’accusa è «Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g.»; i tribunali di riferimento: “Ministero Esteri per Londra, Procuratore militare di Roma».
In realtà l’archivio è stato occultato per quarantaquattro anni. In occasione dell’indagine avviata dal Consiglio della magistratura militare, le cui conclusioni sono del marzo 1999, viene presentato il carteggio tra i ministri Martino e Taviani, che così diviene di pubblico dominio.


