a cura di Cornelio Galas
Fonte: “Nikolajewka: c’ero anch’io”. Giulio Bedeschi. Testimonianze fra cronaca e storia

Geniere alpino Giovanni Piazza
II Battaglione Misto Genio, 6^ Reggimento Alpini
Non sapevo cosa fosse la guerra, e già a 19 anni mi trovavo sul fronte russo lasciando a casa tutte le mie speranze e miei più cari ricordi; davanti mi si presentava soltanto ciò che mio padre mi aveva raccontato dei suoi anni di guerra combattuti sulle sponde del Piave come alpino. Io facevo parte del plotone conducenti e spesso mi recavo in linea a portare munizioni. Il 17 gennaio del 1943 il nostro capitano Luigi Collo ci diede l’ordine di portarci a Podgornoje, cioè di retrocedere.
A Podgornoje ci fermammo una notte e là veramente mi resi conto che mi si presentava davanti “la grande ritirata”. Qui inizia veramente la mia tragedia fatta di paura e disperazione, infatti da quel brutto momento ogni giorno si combatteva aspramente per poter uscire da quella maledetta sacca dove i russi ci avevano chiusi. Quasi subito persi i contatti con la mia compagnia e solo raramente riuscivo a intravedere, nella marea di gente qualche mio compagno o qualche ufficiale al quale subito si chiedeva dove fossero quelli del nostro battaglione, ma a questa domanda non sapevano dare nessuna risposta; in particolar modo ricordo di aver incontrato un mio conoscente, Ninì Curto del 6^ Alpini.

Circa un giorno prima di arrivare a Nikolajewka incontrai il mio caporal maggiore Giovanni Contessi con il quale percorsi la strada assieme fino al momento del tragico combattimento di Nikolajewka. Ricordo chiaramente la collina prima della ferrovia dove i russi ci inchiodarono per diverse ore; e fu lì che vidi per l’ultima volta il caporal maggiore; infatti eravamo stesi a terra per lo scoppio di una granata, rimanemmo feriti entrambi, io alla gamba sinistra e al petto e lui a un fianco; era il 26 gennaio ’43.
Io, strisciando, stavo portandomi verso il sottopassaggio della ferrovia quando venni ferito la seconda volta da un mortaio, alla gamba destra e al viso. Spinto dal terrore di non potermi più rialzare mi trascinai oltre la ferrovia sino alla più vicina isba, già piena di feriti. Là incontrai Ninì Curto il quale mi impartì subito le prime medicazioni e mi procurò un po’ di pane e latte che aveva trovato in un forno di un’isba; da tre giorni era la prima volta che riuscivo a mettere qualcosa sotto i denti.

Questo successe nelle ore pomeridiane e solo a tarda sera tornò, e caricatomi in spalla mi portò sino alla chiesa di Nikolajewka. E da quel momento non lo rividi più, seppi solo dopo parecchio tempo che venne decorato per la sua generosità e per il suo valore. All’alba fui caricato su di un mulo che mi portò per tutto il giorno, solo a sera ci fermammo, in qualche modo scesi dal mulo, e cercai di sistemarmi per la notte. Al mattino però mi accorsi che il mio mulo era sparito; decisi così di entrare in un’isba, ma nell’attimo in cui stavo entrando vidi fuori due muli e una slitta, e dentro due tedeschi; feci dietrofront, salii sulla slitta e scappai. E con quella slitta riuscii a riportarmi in colonna con gli altri e giungere sino a dove c’erano le prime ambulanze.
Alpino Giuseppe Captata
II Battaglione Misto Genio
NON POTETE DIMENTICARCI! Il nostro capo disperato si leva nell’ultimo sforzo d’orgoglio! Noi giogaie, neve, deserto, reticolato. Noi cicatrici nascoste: medaglie di fuoco nella carne di questa terra. Non potete dimenticarci! Perché non vedete le croci sulle nostre vene spezzate? I vostri occhi sono gli occhi vuoti dell’oblio. Non aspettate che il sangue conosca solo il bacio della morte e la terra nasconda la carne lacerata con le sue mani di fiore. Il nostro capo disperato si leva nell’ultimo sforzo d’orgoglio! No, non potete dimenticarci! Questa nebbia ci oscura il cuore.

Capitano medico Ugo Bassi
Comandante 5^ Sezione Sanità, 5^ Reggimento Alpini
A Nikitowka, il 25 gennaio 1943, dopo la tormenta gelida, implacabile, isbe surriscaldate. Dopo la neve, per la sete e la fame di alpini e muli, gli ultimi viveri di riserva. Nella notte crepitio di spari: alle 5 del 26 gennaio allarme, incolonnamento, partenza. In testa alla colonna del 5^ Alpini il Battaglione Tiràno che, più tardi, impegnato in una battaglia accanita e cruenta, riuscirà a superare l’attacco russo con gravi perdite di ufficiali ed alpini.
La pista nella neve corre su un terrapieno, passa su un ponte e si inerpica su una collina fra abeti e betulle.
Giunti nelle vicinanze del ponte, la colonna della 5^ Sezione di Sanità è investita da raffiche di mitragliatrici e parabellum, provenienti da un canneto sulla sinistra. Numerosi i feriti, medicati con mezzi di fortuna e caricati sulle poche slitte già sovraccariche. I muli sono l’unica speranza di salvezza,… resistono ancora, ma fino a quando? Si dirotta verso destra nella palude gelata: ci blocca un torrente ghiacciato che scorre nella balka; la riva opposta è ripida, scoscesa.

Col tenente Rolando Prada che ha il comando del reparto someggiato dopo la scomparsa del tenente Girometta che, sapremo dopo, cadde prigioniero dei russi, col tenente Crosta, con i sottufficiali, aiutiamo soldati di sanità ed alpini a spingere le slitte nel vano tentativo di superare la ripa. Ma questa è tanto ripida ed innevata da rendere vani gli sforzi nostri. “Tenente Prada, col reparto someggiato torna indietro, passa il torrente dove le rive sono meno ripide, ma tienti in fondo alla balka, defilato, e cerca di raggiungere la colonna verso la sommità della collina; abbandona tutti i carichi delle slitte e trasporta solo i feriti.”
Il tenente medico Rolando Prada esegue, ma il ghiaccio crepita, si incrina, si rompe sotto il peso di quel cassone chiamato eufemisticamente ambulanzaslitta: questa si impantana e dopo inutili sforzi viene abbandonata. Il tenente Prada fa proseguire i feriti con mezzi di fortuna: perderà i collegamenti. Soltanto il 28 gennaio a Slonowka, ormai fuori dalla sacca, vedremo spuntare alla testa della sua colonna una figura alta, incappucciata nel berretto di pelo, la barba bianca di ghiaccioli sotto il suo sorriso ambrosiano, nel contempo triste e allegro e potremo riabbracciare il tenente Prada mentre grida: “Sunt chi!”.

Al comando del reparto devo passare il torrente a guado, in mezzo a lastroni di ghiaccio. Nel risalire la sponda opposta col mio inseparabile attendente Antonio Tavazza, ci sfiorano raffiche di parabellum, fortunatamente senza colpire né noi né gli altri alpini del reparto che ci seguono in ordine sparso. Raggiunta un’isba, mentre tentiamo di asciugarci, si precipita fra noi il tenente di amministrazione Piero Fossati e mi investe: “Comandante, non seppelliamo i morti? Perdio, vado a parlare col generale Reverberi!”.
Senza cappotto, con la camicia grigioverde sbottonata, con le mani nude, arranca nella neve: gli occhi spiritati denunciano il suo stato di alienazione mentale già manifestatasi il 23 gennaio a Malakijewa. Non voleva mangiare perché il cibo, diceva, era avvelenato; in ogni alpino vedeva un partigiano, in ogni isba un pericolo di incendio o di scoppio; dormiva solo, all’addiaccio, nonostante il nostro prodigarci per cercare amorevolmente di persuaderlo e di tranquillizzarlo. Inutilmente. Se ne va nella neve, si ribella, con la Beretta in pugno, a chi vuol trattenerlo: “Dov’è Reverberi?” grida. Si unisce alla colonna tedesca, poi a quella ungherese, gesticola, parla, parla, minaccia, ride. E nella massa scompare. Disperso.

Nel mezzo di una colonna, la più eterogenea per abbigliamenti e armamenti, lentamente proseguiamo verso Nikolajewka: si attraversano le tristi testimonianze di un duro combattimento. Un alpino con gli arti inferiori sfracellati da un colpo di mortaio, giace in una pozza di sangue, morente, e invoca: “Mamma, mamma, aiuto, acqua, acqua”… Sostiamo presso di lui e cerchiamo di tamponare l’emorragia con un pezzo di coperta: si avvinghia con la poca forza che gli rimane ai miei valenki e sussurra: “Salvatemi, salvatemi, mamma, Italia…”. Sono le sue ultime parole, mentre un cappellano militare sopraggiunto, chino su di lui, gli da l’estrema unzione e gli chiude gli occhi.
Pallido, gli zigomi sporgenti, il viso incavato, ascetico, illuminato da occhi dolci e mesti e umidi di lacrime: è don Carlo Gnocchi. Quante volte l’ho visto dire l’ultima parola buona ai morenti, raccoglierne il piastrino, e proseguire, e prodigarsi sempre incurante di sé, tutto per gli altri! Marciamo lentamente nella neve alta, con lunghe soste. In testa alla colonna si susseguono i combattimenti contro lo sbarramento russo, e si può proseguire soltanto dopo la vittoria e il sacrificio degli alpini.

Nelle soste, col mio attendente Tavazza sempre al mio fianco, ci scambiamo impressioni e ricordi: “Ricorda capitano, la notte di Schabeskoje?” “Quando ho preso a schiaffi i soldati all’addiaccio che non volevano alzarsi e proseguire?” “Schiaffi santi, capitano! Sarebbero rimasti tutti in mano ai russi. Che notte capitano! Le isbe che bruciavano, spari da tutte le parti! E che gelo!” “Saranno stati 40 sotto zero!” “E che fame. Da due giorni mangiavo soltanto neve. Se non ci fosse stata la sua scatoletta di carne!” “Tavazza, e la fortuna dopo Scheljakino?” “Eh capitano, se non avessimo prudentemente atteso l’Edolo e proseguito con loro prendendo al bivio la pista di sinistra, saremmo caduti in mano ai russi a Warwarowka. Chissà che fine avrà fatto il Morbegno…?” “E che fine avranno fatto gli alpini feriti, gravissimi, intrasportabili, lasciati nelle isbe e affidati alla pietà e alla bontà dei mugik russi?” “Quelli non li rivedremo più capitano.”

Si proseguiva lentamente. Nelle prime ore del pomeriggio nella piana di Nikolajewka è attestata tutta la colonna di quello che fu il Corpo d’Armata Alpino. Un colpo di mortaio colpisce in pieno una cucina da campo tedesca che poco prima aveva distribuito il rancio caldo solo ai tedeschi. Mi ero avvicinato per chiederne una gavetta per un ferito: mi era stato risposto un altezzoso “Nicht”. Gli alpini si vendicarono applaudendo al colpo fortunato agitandosi, fischiando, bestemmiando.
Poco dopo eravamo tutti a terra: piccoli aerei russi caracollavano su quella nera informe massa, buttata sulla neve come relitti di un naufragio, e mitragliavano, mitragliavano. Sentivo sul ventre e sul viso il gelo della neve, ma sopra di me un peso e un calore umano, quasi un abbraccio: il mio attendente Tavazza, sempre vigile, si era gettato su di me per farmi scudo col suo corpo! Caro Antonio! Verso le 16 vediamo sferrarsi l’attacco finale dell’Edolo al comando del maggiore Belotti: “Edolo, Edolo, avanti!” si gridava fra le file. Gli alpini dell’Edolo col loro armamento, arrancavano nella neve: dovevano farsi strada a viva forza nella calca degli sbandati. Giunsero in testa. Dall’alto di un semovente tedesco, il generale Reverberi incitava all’attacco.

Il terrapieno venne superato, i russi messi in fuga, Nikolajewka conquistata, l’ultimo anello della sacca infranto. A tarda sera arrivava anche il mio reparto, si potevano medicare i feriti fra i quali il comandante del 5^ Alpini, colonnello Adami, coi pacchetti di
medicazione lasciati dai russi in fuga. Prima di gettarmi sfinito su un giaciglio bacio una medaglietta che mi era giunta col pacco di Natale: da una parte vi era incisa una data: “21 luglio 1942”; giorno della partenza del 5^ per la Russia; dall’altra: “Il bacio della tua mamma ti protegga”. Piangevo.
Capitano Arnaldo Negri
25ª Sezione Salmerie, 5^ Reggimento Alpini
19 gennaio: Podgornoje; col comando del 5^ e della C. C.R. la mia sezione inizia la ritirata verso le ore 8 del mattino. Stacco direttamente al comando del 5^ due conducenti che porteranno in salvo, unitamente alla scorta dei carabinieri, la gloriosa bandiera e la cassa del reggimento. A fatica ci incolonniamo raggiungendo il pianoro della steppa dove fra tormenta e sbandati il reparto trova serie difficoltà a proseguire compatto. Raggiungiamo sul tardi Scororib conquistata dal Tiràno comandato dal maggiore Maccagno e dall’Edolo del maggiore Belotti.

20 gennaio. Al mattino, ormai in marcia, il reparto deve assumere formazione di combattimento (ad ogni conducente vengono affidati due muli) per un improvviso attacco di carri armati russi. Durante la marcia: è ancor presente in me la figura di un alpino quasi seduto sulla neve ai lati della pista; teneva abbracciato il fucile appoggiandosi; nell’incitarlo guardai i suoi occhi ormai senza espressione, il viso di quel colore cereo caratteristico del gelo. Scrollò leggermente la testa e rimase fermo: inchiodato al suo destino.
21 gennaio. Raggiungiamo Nowo Karkowka poco prima di mezzogiorno; sono ben visibili le conseguenze dei combattimenti. Improvvisamente scorgo poco lontano una figura scura su un leggero declivio; mi avvicino. E’ un russo, col caratteristico pastrano grigio marrone, il cui corpo giace nell’atto di scappare, con la mano destra protesa in avanti e la gamba destra in ginocchio affondate nella neve; mentre la mano sinistra tesa verso il cielo e la gamba alzata nell’atto del passo sono rimaste irrigidite dal gelo ed il corpo è in equilibrio. Ho ancor oggi presente la figura, è simile a certi calchi della tragedia di Pompei!

Scheljakino, 22 gennaio 1943. Sono le 16, ormai la notte sopraggiunge, mi avvio al ponte, non intendo aspettare oltre. La mia attenzione è richiamata da un grido e da punti neri che si avvicinano rapidamente; sono carri armati russi provenienti sulla destra. Il reparto raggiunge la sommità della salita, con grande difficoltà, le slitte sono troppo pesanti, cariche di soldati congelati, feriti, munizioni e vettovagliamento. Una massa di sbandati, in questo frangente si è infilata nel reparto, portando ancora maggior scompiglio e difficoltà di collegamento.
Mi trovo in testa, il buio non mi fa scorgere la pista, così devio sulla mia destra, in leggera discesa. Mi riferiscono che siamo preceduti da soldati del Morbegno; senza più esitazioni ci uniamo alla colonna. Da tempo è scesa la notte, buia e fredda, illuminata da lontano da sinistri lampi di fuoco, da colpi di mortaio, sibili di mitraglia. Improvvisamente uno sferragliare veloce si avvicina, preceduto da scariche di mitraglia dai lunghi nastri rossi e verdi; dalla testa gridano di non sparare, trattasi di cingolati tedeschi che ci proteggono… erano invece russi!

Improvvisamente il primo cingolato sul lato sinistro della colonna non si sente più; aveva investito un nostro mulo che con il conducente Oreste Pizzini ed il caporal maggiore Domenico Cristini fiancheggiava la colonna; così il sacrificio del mulo è valso a mettere fuori combattimento il cingolato essendosi rovesciato. …Sono circa le ore 5 del 23 gennaio. In testa alla colonna, fra Ossaski e Warwarowka siamo distolti da uno sferragliare improvviso. A meno di un centinaio di metri, un carro armato ci assale. A mala pena ci si salva, abbandonando tutto, correndo sulla neve fresca dove si sprofonda; ci si defila.
Un gruppo di soldati russi cerca di assalirci invitandoci alla resa. La fucileria, dalla testa della colonna, li fa desistere momentaneamente dall’avvicinarsi, ma il carro armato prosegue sull’esterno; prendendo d’infilata la colonna, schiacciando e demolendo tutto! Alpini feriti, congelati, muli, slitte tutto un ammasso, un groviglio, grida, quanto avviene è indescrivibile, muli che fuggono scavalcando, trascinando ogni cosa. Terminata questa prima azione, il carro armato ritorna sulla pista e si ritira, ne approfitto per richiamare e cercare i miei soldati. Sono coadiuvato nel ricomporre il reparto dal sottotenente Varetto e dai graduati rimasti illesi.

Purtroppo questa nostra opera ha poca durata perché nutrite scariche di mitraglia, mortai, anticarro ci colpiscono; ci si salva spostandosi nella neve, sprofondando fino alle cosce, si ansima in cerca di un riparo, tutto attorno la neve ribolle, zampilla per gli scoppi. Una serie di carri armati, alla distanza di circa 150-200 metri ci bersaglia frontalmente su un terreno in salita! Speriamo di raggiungere la sommità e di poterci defilare; dalla parte opposta, altri carri armati ci attendono! Così mi trovo con una quarantina di miei alpini ed altri soldati in un canalone; delle slitte, dei muli, dell’equipaggiamento non rimane più nulla, solo un mulo dei 130.
Raduno i pochi soldati rimasti ed ordino di suddividersi in squadre, deciso di attendere gli eventi mentre alcuni volenterosi abbinati, mòntano di sentinella per preservarci da eventuali sorprese; siamo ad una temperatura di 30, 40^ sottozero. Considero, nell’incerta situazione, l’impossibilità di poter risalire la colonna, la possibilità di essere nuovamente intercettati dai carri armati, l’enorme ingombro in coda alla colonna.

Dopo un attento esame della carta al 3.000.000 rendo edotto il sottotenente Varetto ed altri ufficiali e i soldati della situazione, delle enormi difficoltà ed incertezze di poterne uscire seguendo le piste già tracciate. Decido di “crepare nella steppa, piuttosto che in mano ai russi”, lasciando libero ognuno della propria iniziativa; chi sarebbe rimasto doveva ubbidire ed essere pronto a sacrificarsi, se così fosse stata la sorte. Dispongo di tagliare per la linea più diretta: Ossask, Kalinin, Waluiki attraversando la steppa.
Ognuno si deve rendere conto che non abbiamo altra risorsa se non la forza della nostra volontà; domando ubbidienza e disciplina, decisione: chi non può camminare deve sapere di non poter contare sui compagni, ed io per primo dovrò essere abbandonato se le forze mi mancheranno. Attendiamo l’imbrunire per riprendere la marcia, siamo subito fatti segno ad alcune scariche di parabellum; proseguiamo aprendoci la pista nella neve alta, deserto di neve tutt’attorno, freddo intenso, grida nella gelida notte, buio pesto; l’ansia, il timore di trovarci all’improvviso di fronte ai russi, trattiene quasi il respiro. Silenzio, solo il fischiare del vento.

Con l’avvicinarsi del mattino inizia una forte nevicata e tormenta, la colonna è aumentata, il sottotenente Zanotti con la sua bussola ci è di grande aiuto nella direzione. Ormai si fa giorno, tutt’attorno neve piatta piatta, si procede a stento battendo la pista, dandoci a turno il cambio dopo 5-10 minuti. La tormenta è forte, ci sferza il viso e le mani, non un albero, non un’isba, solo grigiore, sete, fame, freddo. A sera inoltrata ci troviamo quasi improvvisamente nei dintorni di Kalinin. Stacco una pattuglia per raccogliere notizie. Sembra che i russi abbiano occupato Waluiki. Nell’incertezza di queste poche notizie, decido di spostarmi leggermente a nord.
Proseguiamo così nella notte fra il nevischio ed il freddo. Con sorpresa ci troviamo in un avvallamento con alcune isbe incendiate e pochi soldati, fra questi il sergente Bracelli della 25ª Sezione Salmerie, a cavallo di un mulo dal quale non può più scendere perché congelato alle gambe ed alle mani, proseguiamo fino verso le ore 4 del 24 gennaio, in alcune isbe vuote ci si ripara, esausti dell’enorme sforzo, circa 36 ore ininterrotte di marcia per almeno 60-70 chilometri, sulla neve fresca senza alcuna pista, temperatura 30, 40^ sotto zero.

Ci si sta riscaldando ed asciugando quando un allarme improvviso per un attacco di carri armati ci costringe ad abbandonare tutto; cerchiamo scampo nuovamente nella steppa; sono le ore 7 ca. del 24 gennaio. Si riprende la marcia riorganizzandoci, da nord un continuo martellare di mortai e di mitraglie sempre più intenso si fa sentire, tremenda compagnia alla fame ed al sibilo della tormenta. Per tutto il giorno proseguiamo indisturbati nella lotta fra la neve, la stanchezza e l’ansia degli attacchi.
Sull’imbrunire incrociamo una larga pista nella balka, ci imbattiamo con alcuni cavalleggeri tedeschi di retroguardia ad una colonna; ci indicano la direzione da seguire. Verso le 19 circa del 24 gennaio, ci si trova nel paese di Samarino, ormai tutto occupato, ed a malapena rintraccio un ricovero dopo aver conferito col maggiore Schlitt comandante della colonna tedesca; ricordo un particolare, prima di parlare volle la parola d’ordine, per fortuna da me conosciuta.

Mi invita a formare un reparto organizzato dagli italiani, la partenza dovrebbe avvenire al mattino del 25 verso le ore 8; qui finalmente trovo un nucleo del Morbegno, tenente Bonari e Noseda, inoltre il sottotenente Melli con salmerie del Tiràno ed altri alpini e soldati di altre armi. Al mattino purtroppo la partenza è anticipata di circa 2 ore e pur sforzandoci per il coordinamento del reparto con l’aiuto del sottotenente Varetto e sottotenente Zanotti, non raggiungiamo lo scopo per la necessità di non perdere i collegamenti con i tedeschi.
Questo giorno trascorre abbastanza tranquillo e solo dopo aver attraversato la ferrovia WaluikiAlexsejewka nei dintorni di Mandrowa la colonna degli italiani è improvvisamente fatta segno ad intenso fuoco di armi automatiche individuali. Staccate tre squadre al comando del sottotenente Varetto, rintuzziamo e costringiamo il nemico a desistere. Giunti alla periferia di Mandrowa possiamo a mala pena trovare alcune isbe per asciugarci cercando di rifocillarci con rape, cavoli conservati sotto acqua salata e gelata. Una donna pur di salvare il salvabile, cuoce delle frittelle di farina nera, ed a turno, dopo un energico intervento, ce le dividiamo coi tedeschi.

Verso le 23 del 25 gennaio, riprendiamo la marcia in direzione di Prinzewka, preceduti dalla colonna tedesca e dalla nostra squadra con incarico di collegamento. Un primo combattimento in testa obbliga la colonna a sostare; siamo ammassati disordinatamente all’inizio del bosco, sotto il fuoco dei mortai. Dalla testa nel frattempo ci richiedono rinforzi e munizioni, purtroppo non possiamo; noi stessi siamo soggetti a fuoco ravvicinato di armi automatiche che ci costringono a staccare pattuglie di volontari sui fianchi della colonna per tenere lontano più possibile il nemico.
Le poche munizioni vengono raccolte in elmetti e depositate lungo la pista a disposizione degli ultimi, che coi pochi colpi di moschetto rintuzzano alla bene meglio e tengono lontano i partigiani e militari russi. Particolarmente si distinguono per abnegazione i sottotenenti Varetto, Melli, Zanotti; tenenti Noseda, Bonari. In questa circostanza è ferito il sottotenente Bianchi, una pallottola gli trapassa le guance senza ulteriori conseguenze.
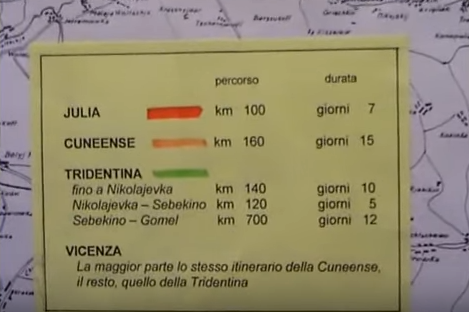
Che dire in questa situazione dei congelati, dei feriti e degli esausti! Ormai è notte, ci si affaccia sulla radura mentre i reparti tedeschi ci hanno staccati di parecchio, ci accoglie con razzi illuminanti un tiro ben diretto di armi automatiche e mortai, e mine disseminate lungo la pista. La pronta reazione del reparto, mentre miriadi di nastri rossi e verdi, sibilano radenti sulla testa, ci indica l’origine, ci permette di organizzare con precisione la nostra reazione e di ridurre al silenzio una mitragliatrice troppo vicina. A poche centinaia di metri ci attende una radura dove la colonna è illuminata a giorno da una serie di continui colpi di mortaio.
Ci dividiamo in tanti gruppi alla ricerca di scampo. Rimaniamo sotto questo intenso fuoco per parecchio tempo, fino a quando, evidentemente privi di razzi i russi non possono più illuminarci e smettono. Le poche slitte cariche di feriti e congelati, sono colpite, o sprofondate nella neve, non possono più proseguire col loro pietoso carico, molti alpini non se la cavano, i rimasti vagano nella balka affondando nella neve fresca. Raggiungiamo l’opposto altipiano a notte inoltrata, di umano abbiamo solo la volontà di vivere. E’ necessaria una sosta di almeno due ore per attendere e richiamare i dispersi.

Intanto un forte vento, gelido, si è alzato da nord, non permettendo quasi il respiro. In questa occasione pur indossando la tuta bianca impermeabile, mi accorgo di avere la camicia gelata. Riprendiamo la marcia verso le 1 del 26 gennaio, oltrepassiamo la seconda
linea ferroviaria WaluikiBudenkosk. Ormai sicuro di essere fuori dalla sacca, sono colpito da un momentaneo rilassamento e solo con l’aiuto di alcuni miei alpini che mi sostengono riprendo le forze, sorretto dalla volontà per la mia famiglia, per i miei figlioli; quanti altri si sono trovati in queste condizioni! La colonna raggiunge così verso le ore 2 del 27 gennaio, Prinzewka, dopo una marcia ininterrotta di circa 28 ore. Assaliti dai russi, attanagliati dal freddo e dalla tormenta, per molti di noi un bicchiere d’acqua fu il pasto di quei giorni.
Caporale Noradino Olivier
623º Ospedale da Campo
17 gennaio 1943, domenica. Dei feriti e congelati che ieri abbiamo avviato verso Postojalyi, nelle retrovie, ne sono rientrati alcuni durante la notte ed in mattinata. Sono ritornati quelli che hanno potuto arrangiarsi da soli; degli altri, dei più gravi non si sa nulla: forse ricoverati da gente pietosa in qualche isba, forse morti lungo il tragitto od abbandonati. Postojalyi è occupata dalle truppe russe, non abbiamo più retrovie. Ci troviamo circondati in una sacca ed il fronte è tutt’attorno a noi.

All’ospedale da campo – il 623º della Tridentina sistemato nella “Casa del Soviet” di Podgornoje – continuano ad arrivare feriti e congelati, molti di più questi ultimi, di ogni corpo ed arma. I locali ne sono tutti pieni ed i corridoi pure. I più fortunati (fortunati per modo di dire) sono sdraiati sulle brandine, altri su pagliericci stesi sul pavimento ed altri ancora sopra un pugno di paglia. Quanti sono? Non so! Non ci è possibile tener nota di chi
arriva o parte: tutti, medici e soldati, siamo indaffarati nell’intento di alleviare qualche sofferenza. Lelli mi chiama; sul cassone di un camion abbandonato ad un centinaio di metri di distanza c’è un militare che bisogna portare al riparo.
Corro subito, chiamo l’alpino: è seduto sulla panchina e non risponde. Salgo sul cassone per aiutarlo, lo scuoto e mi si rovescia addosso: è morto! Tiene ancora stretta con le mani rigide la coperta che s’era messa in capo per difendersi dal freddo. Povero alpino, non avrà avuto la forza di scendere con gli altri, forse dormiva. Lo portiamo all’interno, in quella posizione tragica che ha assunto il suo corpo e più tardi col cappellano lo andranno a mettere sotto un palmo di neve. Con la bufera che tira e con 40 sotto zero non c’è possibilità di fare fosse.

Ed ancora giungono congelati! Tutto il giorno, tutto ieri, che faccio iniezioni antitetaniche; non mi trema più la mano ora come nel gennaio dello scorso anno quando feci la prima a un fante della Pasubio. Iniezioni sulle cosce, sul petto, sul ventre, dov’è possibile; solo far presto. E poi frizioni di pomata anticongelante alle mani ed ai piedi. Piedi violacei od addirittura neri e con le carni già aperte. Poveri piedi! Quant’è che non vedono acqua e sapone; ed al lezzo delle carni martoriate si unisce quello del sudiciume.
“Sono grave, caporale, guarirò, credi che ce la farò a guarire?” chiedono quasi tutti. Mi sforzo di infondere un po’ di coraggio, di dire una parola di conforto: “Sì, sì, guarirai, stà tranquillo!” rispondo. Pietosa bugia: ben lo so che se gli arti congelati non verranno presto amputati, la cancrena non si fermerà e li porterà a morte in breve tempo.

Sono spossato oggi, non ne posso quasi più dal gran lavoro che c’è stato. Scrivo queste righe qui, in quella che era la direzione del 623º O. C. al chiarore di un lume a petrolio. Anche gli ufficiali sono qui sdraiati alla meglio per terra. Il capitano Siili ha appena commentato: “Tra una settimana, ragazzi, o saremo salvi o tutti morti”. Un boato fa rintronare l’edificio: sarà forse saltata la torre in cemento verso la stazione.
18 gennaio, lunedì. Ci portano a ricoverare un tedesco. E’ un “vecchio” di circa quarant’anni della “Feldgendarmerie”, di quelli, cioè, che incutono timore anche al vederli agli incroci delle strade con quella catena appesa al collo e la placca sul petto. Faceva parte, ci dice, di una compagnia, e del suo reparto sono rimasti in venti. Assieme a Baroni gli tolgo i valenki, gli stivali di feltro: sono tutto un pezzo con i piedi. Li tagliamo fino alle caviglie e poi con forza tiriamo. Orribile! Delle falangi dei piedi non restano che le ossa spolpate! Fa pietà a vederlo, poveretto, non un lamento esce dalla sua bocca, anzi ci ringrazia molto. Non ci resta che fasciargli i piedi alla meglio e lasciarlo così nel corridoio, dove si trova. Corre voce che si dovrà abbandonare l’ospedale, ma non ci sono ancora ordini precisi.

La situazione è gravissima, fuori non si vede che truppa a passare, proveniente da Rossosch e dal Don e diretta verso nord. Si vedono per le strade anche alcuni ubriachi che, si dice, hanno trovato il cognac nei magazzini della sussistenza. Oggi sono in meno a farsi ricoverare; anzi, chi si fida delle proprie forze lascia l’ospedale e s’incammina come può tra la massa. 19 gennaio, martedì. Qualche ricovero ancora: fasciature, iniezioni, massaggi di anticongelante; ma chi non è proprio grave cerca di raggiungere il proprio reparto e si mette in viaggio alla ventura per paura di venire catturato prigioniero.
Poi giunge l’ordine di partire lasciando ospedale e materiali. L’ordine precisa che sul posto deve rimanere, per la cura dei degenti, l’ufficiale medico più giovane con sei militari infermieri, anch’essi i più giovani. Tutti gli altri si devono preparare per la partenza. Degli ufficiali medici il più giovane è il sottotenente Gramegna, ma è coniugato ed allora la sorte tocca al sottotenente Boero che da neanche un mese si trova da noi in sostituzione del sottotenente Marzocchi trasferito all’artiglieria alpina. (Il sottotenente Boero rientrerà nel 1946 dalla prigionia, mentre il sottotenente Gramegna risulterà disperso.)

Appena divulgatasi la notizia che l’O.C. sarà abbandonato, ci sono stati tra i ricoverati momenti di disperazione: è successo un ammutinamento, quasi una rivolta. Pianti, grida, bestemmie, un correre per i corridoi alla ricerca affannosa di armi. Temevano di essere lasciati soli e c’è voluto del tempo per rabbonirli e spiegar loro che non sarebbero stati abbandonati alla mercé, ma che un medico e degli infermieri sarebbero rimasti per assisterli. Si sono poi dovute ritirare tutte le armi e rinchiuderle in un locale per tema che i russi arrivando avessero a trovare resistenza e massacrassero tutti. Ed intanto sulla facciata dell’edificio, di fronte al monumento decapitato di Lenin, viene issato il tricolore assieme alla bandiera bianca con la croce rossa.
Alla disperazione subentra un periodo di calma e silenzio, proprio quel silenzio greve che precede l’uragano. E’ sera quando giunge l’ordine di mettersi in marcia. La partenza è quanto di più doloroso e commovente si possa credere. Tutti abbiamo le lacrime agli occhi: chi è costretto a restare come chi si mette in cammino. Non si sa a chi la sorte sarà più favorevole. Il sottotenente Boero ci accompagna sino all’altezza delle scuole dove trovasi il 622º O. C. Indossa il camice bianco e la temperatura si aggira sempre sui meno 40. Ci abbraccia uno per uno: sembra proprio un addio per sempre!

L’attesa di mettersi in colonna è ancora lunga, siamo tra gli ultimi della Tridentina a lasciare la zona. Son circa le 20 quando ci mettiamo in cammino, ed uno spettacolo tragico ed allucinante lasciamo dietro di noi: Podgornoje arde tutta eccetto gli ospedali; i bagliori del fuoco rischiarano fino le alture circostanti.
La marcia procede lenta verso nord; allontanatici dal paese giriamo sulla sinistra, passiamo sul ponte ed iniziamo la ripida erta in direzione di Opyt. A destra ed a sinistra della pista immensi roghi, le macchine che indugiano a salire l’erta vengono buttate fuori strada ed incendiate. E’ questa la fine anche del nostro Fiat 626! E qui ha inizio il nostro calvario: la Via Crucis che ci trascinerà per due settimane a Schebekino, lasciando sulle nevi più della metà del nostro organico.

Da Opyt, dal primo attacco di carri armati sovietici che ci ha sorpreso la mattina seguente, saremo degli “sbandati”, questa parola villana affibbiata a chi, come noi, rimasto solo di fronte a se stesso, senza un comando, senza una guida, ha cercato di seguire la corrente di quel fiume immenso che è stata la ritirata dal Don.
Ma anche se “sbandati”, ci sono numerosi esempi di chi ha saputo non venire mai meno alla propria personalità ed alla dignità umana. Ci sono, al contrario, anche ufficiali, graduati che buttano le armi e si tolgono i gradi per paura di venire fucilati se cadono prigionieri. Anche un cappellano si toglie la croce rossa dal petto per non farsi riconoscere. Ma il nostro vecchio cappellano, padre Lino Pedrini, passato nel settembre scorso in forza al Battaglione Vestone è stato un eroe.

Non l’abbiamo visto morire, ma troviamo il suo corpo stroncato da una granata a Nikolajewka e testimoni della sua morte ci dicono che è morto alla testa dei suoi alpini invocando l’Italia, la madre celeste e quella terrena. Schena, il suo ex attendente, gli leva di dosso l’orologio e gli altri documenti personali che porterà, se sarà possibile, ai suoi familiari a Trento. Il cuore s’indurisce lungo la pista gelata e senza fine: non si fa tanto caso ai cadaveri di russi e di italiani irrigiditi nelle posizioni più disparate: si passa senza commuoversi pensando che oggi stesso o domani saremo anche noi così. C’è chi invoca aiuto ai margini della pista: hanno moglie e bambini a casa; ma com’è possibile aiutarli se siamo tutti circa alle medesime condizioni?
E’ il 28 gennaio, non abbiamo, da tanti giorni, più muli: morti e mangiati! Ma un cavallino russo tira la slitta sulla quale è adagiato Bellabarba ed a turno vi sale anche qualcuno di noi. Bellabarba ha una febbre altissima, forse ha la polmonite addosso ed è anche ferito ad una gamba; lo si tira innanzi da diversi giorni così. Troviamo ricovero per passare la notte in una di quelle cantine fuori dalle isbe, dove i contadini russi usano tenere, a molti metri di profondità, le patate e gli altri alimenti per preservarli dal gelo.

Lasciamo il cavallino con la slitta legato all’entrata. Il mattino successivo non troviamo più né il cavallo, né la slitta che ci sono stati trafugati durante la notte. Restiamo costernati. Per Bellabarba la situazione è gravissima e comprende, vedendo i compagni allontanarsi ad uno ad uno, che per lui è la fine. Io sono il solo ad essere ancora armato e Bellabarba mi chiede di sparargli. “Sparami alla testa” mi dice. Ma come potrei commettere un omicidio?
Il momento è critico, non so come venirne fuori; misuro le mie forze e non le trovo di molto superiori alle sue ma il coraggio di abbandonarlo mi manca. Intanto rimaniamo noi due soli ed egli insiste: non mi chiede di aiutarlo a proseguire la strada, vede che è quasi impossibile, ma di essere ucciso. Ma la mia decisione è presa: “Andiamo Arturo, gli dico, o ci salveremo tutti e due o moriremo assieme”.

E con fatica, lentamente, sostenendoci a vicenda riprendiamo il cammino. Verso sera ritroviamo il sergente Vignali ed il 2 febbraio arriveremo a Schebekino di dove Bellabarba proseguirà in ambulanza e ritornerà in Italia. Il primo permesso che poi mi sarà concesso a Verona, lo usufruirò per recarmi a casa sua a Caprino, dove la sua mamma mi abbraccerà e mi benedirà come il “salvataggio” di suo figlio.
Tenente farmacista Giuseppe Lora
622º Ospedale da Campo
A Nikitowka eravamo arrivati colla colonna nel pomeriggio del 25 gennaio, provenienti da Romankowo, col gruppo abbastanza numeroso del nostro ospedale, attorno al nostro comandante. Trovammo tutti buona sistemazione per la notte. Io capitai in un’isba piuttosto grande e disabitata, ma in ottime condizioni, situata, mi pare, nella parte centrale del paese, sulla strada principale, assai larga e fiancheggiata da isbe dalle due parti.
I miei compagni si erano sistemati nelle vicinanze: io finii per trovarmi, unico ufficiale, assieme a sei o sette soldati, di cui due o tre del mio Reparto; vi era anche un sergente degli alpini. Accendemmo la stufa, ed ognuno tirò fuori quello che aveva da offrire di viveri: saltarono fuori due o tre galline, carne di mulo, patate, miele, ecc.; mentre io purtroppo non offrii altro che pastiglie di vitamina C, di cui mi ero messo in tasca un grosso flacone prima di partire da Podgornoje.

Ne venne fuori una solenne mangiata, la prima ed unica di tutta la ritirata. Ci mettemmo quindi a dormire e beatamente (a me venne riservato il letto!) senza predisporre alcun turno di guardia, tanto ci sentivamo sicuri. Il sonno durò, ininterrotto e pesante, l’intera notte, durante la quale successe il finimondo che sappiamo, con allarmi e sparatorie, attacchi di partigiani casa per casa, e partenza frettolosa di tutta la colonna, quando era ancora notte.
Quello che io, a distanza ormai di trent’anni, non riesco ancora a comprendere, è come nella nostra isba, non abbia tentato di entrare nessuno (russi o italiani) durante tutta la notte, e che nessuno di noi si sia svegliato (ed eravamo in sei o sette!) a causa del finimondo che stava succedendo fuori. Comunque, ad una certa ora (calcolo che fossero circa le 8,30 del mattino del 26 gennaio), io mi risvegliai, mentre gli altri ancora dormivano, indossai cappotto e scarpe, e mi affacciai, dalla porta d’ingresso dell’isba, sulla strada: vi regnava un silenzio assoluto e non si vedeva anima viva, mentre il sole splendeva nella gelida mattinata.

Mi prese un colpo al cuore al pensiero di essere rimasti soli e mi precipitai nell’isba a svegliare gli altri, per decidere assieme sul problema più immediato: come raggiungere la colonna. Ci affacciammo tutti sulla strada ed affrontammo il dilemma, purtroppo presentatosi a molti durante la ritirata, di quale direzione prendere: io decisi di proseguire in direzione opposta a quella da cui eravamo arrivati alla vigilia, e cioè verso ovest, e di uscire da Nikitowka, cercando il più possibile di non percorrere le strade del paese, per evitare eventuali attacchi di partigiani.
Accettata da tutti la mia proposta, ci mettemmo in cammino il più velocemente possibile, nascondendoci dietro le isbe, attraversando orti e scavalcando steccati e recinti. Il silenzio continuava a regnare assoluto in paese e non si vedeva anima viva: certamente eravamo gli ultimi ad abbandonare Nikitowka. Saranno state le 9, ed ormai eravamo quasi fuori del paese, quando, mentre procedevamo sparpagliati su neve non battuta su cui si affondava fino al ginocchio, il nostro gruppo venne improvvisamente investito da raffiche di mitra provenienti da alcune isbe.
Cercammo di fuggire, ma dopo pochi passi precipitai in una buca piena di neve portata dal vento, e vi rimasi affondato fino al collo. I partigiani continuarono a sparare a me ed ai miei compagni, che si trovavano vicino, per un tempo che mi sembrò interminabile. Ricordo gli spruzzi di neve sollevati dalle pallottole che cadevano in mezzo a noi e ricordo che in quegli attimi rividi tutta la mia vita passata con estremo distacco: so che ero calmissimo, perché ormai mi consideravo morto.

Intanto il fuoco dei partigiani cessò: ci chiamammo l’un l’altro e tutti erano vivi ed illesi, almeno così mi parve. Rimanemmo fermi quanto più potemmo, immersi nella neve ad una temperatura di almeno – 25°, finché lentamente ci tirammo fuori dalla neve e ci rimettemmo in cammino velocemente: ci sentivamo in forze dopo la mangiata della sera precedente e per lo scampato pericolo.
Proseguimmo quindi sempre in direzione ovest, senza veder nessuno attorno a noi finché cominciammo ad incontrare tracce di passaggio di colonne a piedi, non tali però da darci ancora la certezza di essere nella direzione giusta. Proseguimmo ancora, quando, dopo circa un paio d’ore di veloce cammino in piena solitudine, arrivati al colmo di un dosso, vedemmo in lontananza la coda della colonna della Tridentina: la salutammo con urla di gioia ed abbracci.
Proseguendo rapidamente arrivammo ad una palude gelata, piena di canne palustri; c’era un ponticello di legno presso il quale si trovava un nostro grosso trattore d’artiglieria abbandonato. Mentre stavamo attraversando la palude, fummo di nuovo investiti da raffiche di mitragliatore, provenienti questa volta dalla colonna: probabilmente eravamo stati scambiati per partigiani. La colonna stava risalendo in quel momento il costone che precede il pianoro, che si affaccia alla grande conca in cui si trova Nikolajewka.

Calcolo che quando noi la raggiungemmo saranno state le 12,30-13. Entrato nella colonna, il nostro gruppo vi si disperse: io continuai da solo, sempre risalendola, mentre essa si stava sempre più allargando a macchia d’olio, sul pianoro che sovrasta Nikolajewka. Superatolo, scesi assieme ad un reparto armato (Vestone o Val Chiese) un tratto verso il terrapieno ferroviario, ma fummo ricacciati indietro dal fuoco terribile che da esso partiva. Risalimmo quindi sul pianoro, dove mi misi immediatamente alla ricerca del mio comandante maggiore Sacchi e dei miei compagni: era davvero una bella pretesa la mia di trovarli in mezzo a quella massa eterogenea di più di trentamila uomini, muli slitte cariche di feriti ecc..
Ed il bello è che, dopo breve tempo, li ritrovai davvero, mentre infuriava uno dei numerosi attacchi aerei russi del pomeriggio. I miei compagni mi pensavano morto, non avendomi più visto dal pomeriggio precedente. Assieme a loro vissi tutte quelle tragiche e gloriose ore, dagli attacchi al terrapieno da parte del 6^ Alpini, ai mitragliamenti e bombardamenti aerei, dalle ultime salve dei 75/13 del Gruppo Bergamo, al grido del generale Reverberi “Tridentina, avanti!”, dalla tumultuosa discesa nella grande balka, all’entrata nella notte a Nikolajewka ormai conquistata, attraverso il famoso sottopassaggio che ci aperse la via alla salvezza, grazie al sacrificio cosciente di tanti valorosissimi alpini.
Tenente medico Virgilio Appino
618º Ospedale da Campo
Dopo trent’anni dalla giornata di Nikolajewka mi viene chiesto di rammentare un episodio particolarmente saliente della mia vicenda. Ebbene, nel grigiore di questo lungo dopoguerra, nel quale i nuovi idoli variano dalla droga alla criminalità, dalla contestazione all’obiezione, dall’anarchia all’ateismo, dall’egoismo più sfrenato alla negazione della patria, io dimentico volutamente tutti i particolari che ho innumerevoli e ben precisi davanti agli occhi e che movimentarono la ritirata di Russia.

Campeggia su tutto e su tutti la fede rabbiosa e sconfinata in Dio, l’amore per la patria lontana, l’affetto per le mamme le spose e i figli al focolare lontano, la totale dedizione al proprio dovere, la solidarietà di uomini semplici e buoni. Tutto ciò insomma che permise ad un manipolo di pigmei di diventare giganti e di vincere l’impreparazione fisica e psichica, la situazione bellica, le condizioni climatiche e lo sconforto montante.
Davanti a questo mio sentimento non avrebbe senso che io esaltassi l’uomo o il reparto o il fatto particolare più o meno edificante o esaltante. Ha secondo me un senso ricordare ed esaltare i caduti, che dettero più di noi, ma le cui “penne” la sorte volle “mozzate” nella sua imperscrutabilità; e sperare che la vicenda da noi vissuta serva ad ammonire chi resta che senza gli intramontabili valori di sempre, un popolo diventa un gregge, una patria diventa un paese qualunque e nessuno potrà impedirne la catastrofe completa, quale appunto noi evitammo a Nikolajewka.
Autiere Amedeo Berton
245º Autoreparto Pesante
Io ero del 245º Autoreparto Pesante, noi 8 autieri erimo pieni di pedocchi, da 25 giorni si trovavimo al fronte. Io non sono politicante, solo un patriota, fino alla morte, solo a Dio credo, non più ali uomini. Della guerra che provai duramente in Russia ancora oggi qualche giorno non dormo, e mi viene il ricordo dei carri armati, i morti e i vivi italiani tedeschi e russi, squartati da pallottole o schegge di cannone.

Una notte avevo caricato un capitano dei bersaglieri squarciato a un braccio, lo legai forte io alla spalla, ma tra Karkow e Kantemirowka la seconda notte mi è morto dissanguato, lo coprii sotto la neve, era di notte, a poco lontano passarono via a grande velocità due carri armati russi, e non si accorsero di noi. Nel frattempo noi siamo rimasti in sei, con altri tre feriti. Guardo se c’è tutti, e mi accorgo che a cinque metri c’era un’ombra; io e un bersagliere ci avvicinammo con le armi in pugno: erano tre alpini abbracciati, morti e in piedi. Li abbiamo stesi e coperti di neve. Termino perché ho le lagrime ali occhi. Mi tiene in vita i morti che pregano per me.
Tenente medico Enrico Reginato, medaglia d’oro al V. M.
Battaglione Sciatori Monte Cervino, Corpo d’Armata Alpino
Io non ero presente alla giornata e alla battaglia di Nikolajewka; ero già, da tempo, in prigionia in mano dei russi. Ma appunto per ciò fui testimone delle estreme conseguenze della ritirata degli alpini (e di tutta l’armata italiana) in quell’inverno 1942-43, quando a conclusione della ritirata stessa per molte decine di migliaia di italiani si aprì l’appendice e il periodo della prigionia russa. Sono stato testimone delle sofferenze che prolungarono a innumerevoli alpini le sofferenze della ritirata: gli innumerevoli e quasi sempre mortali patimenti di quanti fra gli alpini non riuscirono a varcare il cancello di libertà di Nikolajewka.
Da allora penso che ritirata e prigionia costituirono un tutt’uno, la completezza di un calvario così irto di dolori e così prolungato nel tempo e nell’infinita varietà di patimenti da non consentire alla mente umana di concepirlo. Io ho visto soffrire e morire, in modo inenarrabile, e ne do qui inadeguata testimonianza, affinché il ricordo appassionato almeno permanga e sia di insegnamento al giorno d’oggi, e tutto sia fatto nel campo della dignità e della tutela dell’uomo al fine di tenere lontana la gioventù attuale dal ripetersi dei patimenti allora sofferti dagli alpini, e da quanti ebbero la suprema sventura di cadere in una prigionia quale fu quella che subimmo in mano dei russi.

Abbiamo visto colonne di prigionieri sospinti per giorni e settimane da urli, spari e percosse andar sempre più assottigliandosi perché chi non si reggeva per la stanchezza veniva finito con le armi.
Abbiamo sentito levarsi invocazioni disperate “dottore aiutami, non ne posso più”, ma anche i dottori non ne potevano più; si coprivano le orecchie con le mani per non udire quelle voci e in quell’istante avrebbero voluto morire per non sentire scaricare le armi sul caduto.
Abbiamo visto le strade segnate da cadaveri che genti e corvi profanavano: le prime per recuperare le vesti, i secondi per sfamarsi.
Abbiamo assistito a spogliazioni di scarpe, di vesti, di oggetti di ogni genere, appartenenti a uomini sfiniti che non potevano reagire di fronte alla violenza.
Abbiamo visto uomini disperati per fame tentare di eludere la sorveglianza per cercare del cibo, e venir abbattuti come cani.
Abbiamo visto esseri umani abbrutirsi per l’infinita stanchezza, un’umanità degradata nella quale pochi si sentivano ancora fratelli al vicino o sentivano ancora pietà per il debole o il morente.
Lo spirito di cameratismo che aveva legato, un tempo, i combattenti tra loro, sembrava finito con l’abbandono delle armi. Abbiamo visto entrare in campi di raccolta migliaia di uomini di molteplici nazionalità e uscirne vive poche centinaia nel breve arco di tempo di 30 giorni e, in quei trenta giorni, il dolore toccare il vertice dell’inumano.

I ricoveri, esposti ai rigori del clima, erano gremiti fino all’inverosimile di uomini doloranti: l’odore acre della cancrena ristagnava ovunque; la fame distruggeva i corpi, la dissenteria completava l’opera di disfacimento di esseri umani martoriati da fame e sete e da parassiti che brulicavano nelle barbe incolte e sotto le vesti sudice e lacere.
Un buio tragico e ossessionante scendeva su questi orrori fin dalle prime ore della sera, interrotto ogni tanto da torce agitate da figure umane urlanti che prelevavano uomini per il lavoro; poi tornava un cupo silenzio di morte interrotto da grida di dolore, da gemiti, da invocazioni pronunciate nelle più diverse lingue, da preghiere elevate al cielo ad alta voce da qualche cappellano.
Abbiamo visto uomini diventare, per fame, feroci come lupi. Alle prime distribuzioni di cibo, come colti da improvvisa follia, spettri umani si levavano e si precipitavano urlando e schiacciandosi, rovesciando a terra ogni cosa, buttandosi al suolo per succhiare il fango impastato con il cibo sparso. Guardiani armati di spranghe di ferro dovevano far scorta al pane per difenderlo dai branchi di uomini in agguato che si avventavano per impossessarsene.

Finalmente vennero convogli ferroviari a caricare e portare altrove questo resto di umanità carica di dolore e di parassiti: i convogli scaricavano i superstiti in altri campi che li accoglievano per rigettarli in fosse comuni; in essi li attendeva non la salvezza, ma il tifo, la tubercolosi, la difterite, la pellagra e ogni altro male.
I lazzaretti (così venivano chiamati i luoghi dove si moriva), erano uno spettacolo drammatico e straziante; corpi distesi su pancacci di legno o sulla nuda terra si sfasciavano per morbi sconosciuti. La morte passava come un’ombra senza requie: ogni giorno volti nuovi, nuove sofferenze; cervelli sconvolti dalla pazzia, deliri, dissenterie, arti deformati dagli edemi, ferite corrose dalla cancrena. I medici e i sanitari si trascinavano fra quegli infelici fintanto che il male portasse via anche loro.
Ricorderò per sempre che un giorno, in un campo di concentramento, durante l’infuriare di una epidemia che giorno e notte mieteva innumerevoli vite umane, mi sì avvicinò un giovane ufficiale medico austriaco, che parlava correntemente l’italiano. Egli mi espresse il desiderio di uscire dalla zona non infetta del campo per assistere gli ammalati, quasi tutti italiani. Lo sconsigliai per il grande pericolo al quale si esponeva; ma insistette con queste parole: “Collega, la prego, io non voglio perdere questa grande occasione di essere medico e cristiano”.

Profuse generosamente la sua arte e le sue energie per i contagiati; contagiato lui stesso, non trovò più in sé la forza di vincere il male che con parole semplici e grandi si era prefisso di combattere. Si spense con la serena dolcezza di chi è consapevole di non aver perduto né di fronte a Dio né di fronte agli uomini la grande occasione. Era difficile fare il medico, in quelle circostanze. I medicinali scarseggiavano, le poche fiale di analettici, per lo più canfora, dovevano essere utilizzate solo nei casi estremi.
Bisognava dosare tutti i farmaci con assoluta parsimonia, valutare lo stato di gravità di ciascun malato, decidere chi doveva avere la precedenza, stabilire una inutile graduatoria e talvolta si trattava di scegliere tra un paziente che invocava il medico nella sua stessa lingua e un altro sconosciuto figlio di Dio. I superstiti di tutti questi mali, uscirono dai lazzaretti con passi incerti e vacillanti. Quelli che alcuni mesi prima erano soldati pieni di vitalità e comandanti autorevoli, apparivano scheletri tenuti assieme da pelle ruvida e squamosa.

Le fisionomie erano irriconoscibili; i capelli aridi, incanutiti; gli occhi immersi nelle occhiaie profonde; la cute del viso raggrinzita in minime rughe, il sorriso una smorfia che lentamente si ricomponeva; i denti vacillanti su gengive brune e sanguinanti, le unghie delle mani e dei piedi segnate da un solco trasversale che pareva segnasse l’inizio della sofferenza. Molti avevano perduto fino al 40-50% del loro peso; attoniti, assenti, dovevano pensare a lungo prima di ricordare il loro nome; sembravano esseri spettrali usciti da un mondo irreale, insofferenti ed indifferenti a tutto che non fosse la distribuzione del cibo.
I mesi, gli anni di detenzione, non furono che tappe di un lungo calvario di rovina e di morte. Morte per esaurimento fisico, per interminabili marce, per i colpi spietati degli uomini di scorta, per epidemie incontrollabili, per inanizione. I superstiti, smarriti dal crollo repentino di ogni illusione, tormentati dalla fame, dalla miseria, dalla paura, rimasero, costretti ai più duri lavori, per anni in balia del nemico, il quale, con abilità e perseveranza, cercò di catturarne anche l’anima ed imporre la propria ideologia.

I detentori che avevano i corpi di quei vinti volevano il trofeo delle loro anime per vincerli due volte usando l’arma della propaganda e del ricatto: “tu devi cambiare opinione altrimenti non rivedrai né la patria né la madre, né la sposa e i figli”. Questo fu l’infame ricatto: cedere dignità, coscienza e fede in cambio di ciò cui i prigionieri avevano diritto senza concessioni e senza compromessi.
Finalmente, un giorno arrivò un ordine nei campi: i prigionieri non dovevano più morire; i medici dovevano attenersi ad esso sotto minaccia di gravi punizioni. Che cosa significava questa nuova disposizione? Invero la morte non si lascia impartire comandi. L’ordine voleva dire semplicemente che le restrizioni che determinavano la morte dei prigionieri dovevano cessare.
Venne, allora, concesso un miglioramento di vitto, modesto ma pure essenziale; vennero presi provvedimenti che crearono condizioni possibili di vita, la lotta contro i parassiti si fece efficace, i medici trovarono meno arduo il loro lavoro disponendo di una quantità maggiore di mezzi, in ambienti più igienici ed adeguati. Ciò bastò per notare nei prigionieri una lenta ripresa delle forze, un miglioramento progressivo dei rapporti sociali, un ritrovamento di dignità e coscienza, un albeggiare di nuove speranze.

Si riallacciarono vecchie amicizie, si riprese man mano a pensare, a parlare, a pregare, a confidarsi, a sperare, a credere nella salvezza. Ma ciò fu raggiunto quando già da tempo le fiamme della guerra si erano spente e nel resto del mondo iniziava, con la pace, una lenta resurrezione.
Alpino Antonio Pinco
45ª Compagnia, Battaglione Morbegno
Verso Natale del ’42 “Radio scarpa” parlava che i russi avevano sfondato le linee più a sud e che la nostra divisione fosse accerchiata. Difatti il 17 gennaio ci ordinarono di ripiegare; così lasciammo la prima linea ed in ordine con tutto il materiale ci dirigemmo verso un paese che si chiamava Podgornoje.
Qui fummo attaccati dai russi ma respingemmo l’attacco; il 18 subimmo un attacco da parte di caccia sovietici che mitragliarono la colonna, lasciammo sul terreno parecchi morti e dopo l’attacco riprendemmo la nostra marcia. Il 19 mentre ci avvicinavamo ad un gruppo di isbe, verso l’una di pomeriggio, un gruppo di soldati russi ci attaccò a colpi di mitragliatrice, individuammo subito la posizione da cui provenivano le raffiche e ci disponemmo, guidati da un caporal maggiore della Valtellina, ad attaccare i russi i quali vista la nostra decisione dopo alcune raffiche fuggirono su di una slitta; mi ricordo che una vecchia uscita da un’isba non so per cosa fare, si trovò tra i tiri nostri e quelli dei russi e colpita si accasciò a terra.
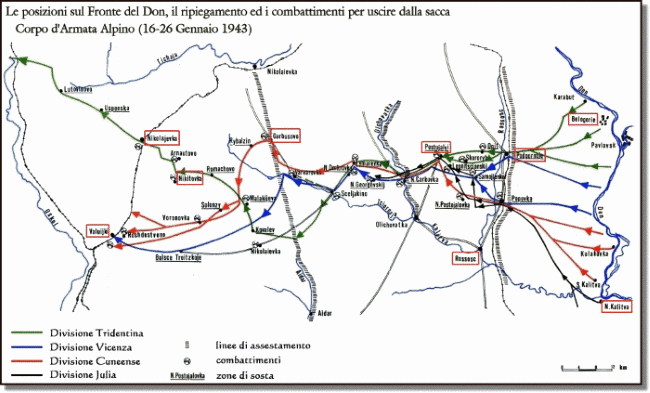
Da parte nostra vidi cadere il caporal maggiore mentre si slanciava in testa verso la posizione tenuta dai russi. Subito dopo il combattimento, il fratello del caporale, che era della mia stessa compagnia, mi chiese se avevo visto suo fratello e non ebbi il coraggio di dire che era morto. Avvertii un cappellano militare, il quale si incaricò di indicargli dove era caduto suo fratello. Il mio commilitone si avvicinò al corpo senza vita del fratello; lo guardai in faccia non lo vidi piangere ma solo sentii dire: me la pagheranno. Riprendemmo il cammino dopo aver sepolto il caporale sotto la neve. Intanto perdemmo di vista la colonna principale.
Alla sera del 22 ci trovammo in un paese che poi seppi essere Warwarowka. Appena entrati tra le isbe cercammo di rifugiarci in qualche posto per passare la notte, io con altri 50 o 60 alpini ci ritirammo in una stalla abbastanza ampia, ero appena seduto sul mio zaino che i russi ci attaccarono con un fuoco infernale di katiuscia e cannoni; allora uscii e mi misi dietro un muro tra la neve. Ad un tratto sentii un terribile frastuono e mi trovai sepolto sotto un cumulo di tavole travi ed altro materiale; cominciai a gridare aiuto, le mie grida furono udite da un certo Vivaldi di S. Remo il quale mi trasse dalle macerie.

La stalla dove ero rifugiato coi miei compagni era sparita, tutto intorno corpi dilaniati, muli morti, grida spaventose dei feriti. Di tutti gli occupanti della stalla non ne vidi uno uscire vivo; mi ero salvato per miracolo. Ma dovemmo abbandonare tutto perché le fanterie russe attaccavano e dovevamo difenderci. Io e Vivaldi con pochi altri superstiti sempre sparando ci ritirammo fuori dal paese. Ci ritrovammo forse in 200 e con un violento fuoco costringemmo i russi verso il centro del paese.
Camminammo tutta la notte e verso le 4 o 5 del mattino raggiungemmo una colonna che ben presto dovette fermarsi perché truppe russe erano attestate su una collina appoggiate da artiglieria. Andò all’attacco la Divisione Vicenza, i fanti della divisione attaccarono per circa due ore ma dovettero ripiegare. Allora verso le 16 o alle 17 i resti del mio battaglione andarono all’assalto, mi trovai vicino Vivaldi e un certo Luigi di Chiavenna della classe 1922; prendemmo le posizioni tenute dal nemico e si fece un centinaio di prigionieri.
La colonna poté così riprendere la marcia. All’indomani nuovo attacco russo e questa volta quelli dell’Edolo sfondarono, ma lasciarono sul terreno numerosi morti. La colonna riprese la sua lunga marcia. Poi, una notte, mentre violenta imperversava la bufera mi trovai solo in fondo alla colonna, le gambe non mi reggevano più, le ginocchia sembravano di marmo, vedevo ormai la colonna allontanarsi, strinsi i denti e piangendo continuai a camminare, rivedevo ora il mio paese lassù anch’esso ora coperto di neve, pensavo che avrei fatto la fine di mio fratello Giacomo caduto sul fronte greco l’anno prima; anch’egli era negli alpini come lo era l’altro mio fratello Albino. Lassù nel mio piccolo paese dei Sette Comuni forse i miei fratellini giocavano a palle di neve o forse erano in chiesa a pregare per me che ero così lontano.

Così piangendo e pregando non mi accorsi che le gambe cominciavano a girare come sempre e verso le 5 del mattino raggiunsi nuovamente la colonna. Trovai Vivaldi, ero affamato, non mi ricordavo più quando avevo mangiato per l’ultima volta. Chiesi all’amico di andare a cercare qualcosa; era troppo stanco e non se la sentiva. Allora viste un gruppo di isbe in lontananza lasciai la colonna e andai diritto verso quel gruppo di case.
Alla prima mi feci coraggio, bussai, mi aprì la porta un vecchio, all’interno vidi una cassa da morto e delle donne piangenti attorno ad un corpo senza vita; chiesi del pane al vecchio, questi mi porse un pezzo di pane, poche patate cotte e avendo sete mi diede un po’ d’acqua. Uscii in fretta da quell’isba. Raggiunsi la colonna e trovai subito Vivaldi al quale diedi del pane e delle patate.

Entrammo in un paese verso le 10 del mattino e subito fummo attaccati da 5 o 6 carri armati. Non capivo più niente, vedevo alpini aggrappati ai carri che cercavano di sollevare le torrette mentre dai carri partivano raffiche di mitragliatrice e numerosi compagni cadevano uccisi. Il mio gruppo cercò di bloccare un carro e mettemmo delle barre di ferro tra i cingoli in mezzo ad un inferno di colpi. In breve tre carri furono distrutti e gli altri si ritirarono.
Vidi il fratello del caporal maggiore valtellinese colpito a morte mentre tentava di aprire un carro. Abbandonammo il paese e riprendemmo la marcia. Mentre ero in pattuglia avanzata, da una collina una mitragliatrice cominciò a sparare, la nostra pattuglia fu decimata in breve. Sentivo il fischio delle pallottole e dai colpi presi dai caduti mi accorsi che i russi sparavano pallottole esplosive.

Vidi il mio amico Luigi cadere avanti bocconi sulla neve, cercai di sollevarlo, cercò di parlare ma ne uscì solo un rantolo; una pallottola lo aveva colpito alla gola procurandogli un foro da parte a parte. I russi intanto continuavano a sparare, colpivano tutto, anche i muli che presentavano nel corpo buchi grossi come un pugno. A piccoli salti in cinque o sei riuscimmo a passare oltre, nascondendoci anche dietro i corpi dei nostri amici caduti.
Mentre la colonna si fermava e i russi dirigevano il tiro verso il grosso di essa ci slanciammo all’assalto a bombe a mano sorprendendo i russi alle spalle ed in breve furono tutti annientati. Così nuovamente la colonna riprese la marcia. Proseguimmo lungo una ferrovia; ad un tratto udimmo spari e grida in testa alla colonna, vicino ad un lungo capannone vedemmo gente fuggire e altra che alzava le braccia al cielo gridando, erano questi circa duecento italiani che, prigionieri dei russi, ora ci venivano incontro festanti.
Giungemmo in un paese dove aveva preso posto un circo equestre.

Ci impadronimmo di un cammello e di tre zebre nonostante le proteste del padrone del circo. Caricammo sul cammello o dromedario due o tre feriti, e si proseguì. Le zebre evidentemente non sopportarono il freddo e presto morirono. Incontrammo una postazione di artiglieri alpini con un cannone anticarro, gli artiglieri giacevano tutti morti vicino al cannone che era privo di munizioni.
La fame si faceva sempre sentire, allora cercai di andare verso un gruppo di isbe, bussai alla prima ma non ottenni alcuna risposta, allora sfondai la porta e vidi un vecchio barbuto che cercava di non farmi entrare, ma con la fame non si ragiona, spinsi da un lato il vecchio ed entrai. Trovai molto miele, chiamai i miei compagni e si mangiò miele ed api insieme. Ripresi la colonna, una slitta trainata da due cavalli con conducenti tedeschi passava avanti, quando improvvisamente delle raffiche di mitraglia provenienti da una piccola collina colsero in pieno cavalli e conducenti stendendoli sulla neve.

Con un balzo fui in un piccolo avvallamento fuori dal tiro della mitraglia. Vi trovai una cinquantina di soldati italiani e tedeschi; ero furente, cercai di convincere quei soldati di andare a prendere quella mitragliatrice che provocava l’arresto della colonna. Nessuno mi ascoltava, allora mi decisi di andare da solo, non so perché lo feci, so che mi trovai nella neve mentre salivo piano piano verso la mitragliatrice che continuava a sparare.
Il russo evidentemente non si accorse e quando mi fu possibile lanciai una bomba a mano, questi ferito alzò immediatamente le braccia, lo presi per il cappotto e lo perquisii, non aveva indosso che un accendisigari. Chiamai quelli che erano nell’avvallamento, volevo fucilare il russo, piangevo dalla rabbia e pensavo a tutti i miei compagni caduti per colpa sua. Alcuni ufficiali sopraggiunti mi presero in disparte mi chiesero come mi chiamassi e a quale battaglione appartenevo.

Ho cercato per tanti anni qualcuno che fosse stato presente quel giorno; chissà che qualcuno leggendo queste mie povere righe non si ricordi dell’alpino che qualche giorno prima di Nikolajewka andò da solo a prendere quel russo che sparava sulla colonna. Il 26 mattina, di fronte a Nikolajewka, andammo in pattuglia verso la città.
Avanzavamo a piccoli balzi. Sembrava di essere all’inferno, i colpi venivano da tutte le parti, sulla mia destra vidi su di un carro tedesco il generale Reverberi lo udii gridare: “Avanti alpini chi ha una bomba a mano, chi ha una cartuccia avanti”. A sinistra vidi un carro tedesco che avanzava sparando. Così, tra colpi di cannone e raffiche di mitraglia, avanzavamo di isba in isba. Poi alla stazione ferroviaria ci nascondemmo dietro le ruote di un carromerci mentre i russi sparavano da tutte le parti.

Giunsi così dentro l’atrio della stazione, assieme a 5 o 6 alpini. Trovammo, mi pare, due o tre donne, qualche vecchio e delle signorine che penso fossero addette alla stazione. Quest’ultime ci offersero delle sigarette. Uscimmo dalla stazione, si cominciò di nuovo a sparare di casa in casa. Non ricordo bene quanto si sparò quel giorno, so che sparammo fino a tarda sera. Il mattino seguente riprendemmo a camminare. Si soffriva la fame e la sete, giungemmo in vista d’un pozzo; in fondo vidi dell’acqua, mi feci calare dai miei compagni con una corda, l’acqua era quasi verde, centinaia di topi morti stretti dalla morsa del ghiaccio, mi calarono le gavette e le rimandai su piene di quell’acqua.
Ad un tratto dall’orlo del pozzo mi gridarono: “Arrivano i russi”, pensai che questa volta era proprio la fine. Cercai di arrampicarmi su ma non ci riuscivo, aspettai la fine, sentii dei cavalli avvicinarsi sull’orlo del pozzo, sentii chiamare kamarade, per fortuna erano soldati tedeschi, mi trassero dal fondo. Quando salii i miei compagni erano tutti spariti. Poi piano piano si avvicinarono e proseguimmo la marcia. Verso le dieci di sera di non so quale giorno giungemmo in vista di un caposaldo tedesco ci gridarono il “chi va là” rispondemmo italiani; allora ci fecero avanzare e fu un grande abbraccio con tutti italiani e tedeschi insieme, chi piangeva, chi urlava dalla gioia.

Dopo circa 15 giorni giungemmo a Gomel. Un capitano friulano fece l’appello della 45ª Compagnia del Battaglione Morbegno, ufficiali uno solo, lui, sottufficiali nessuno, soldati 47 compreso un unico graduato, un caporal maggiore. La maggior parte erano feriti o congelati. Eravamo in circa 650 fra ufficiali ed alpini prima della ritirata, ora si rientrava in Italia in 47 alpini, per molti di noi non era ancora finita, pochi mesi dopo parecchi di noi, io compreso, finivano in campo di concentramento presso Berlino.

Ora vivo ancora sui miei monti; durante la buona stagione, da aprile a novembre, sono occupato come stradino sulla strada che da Gallio porta all’Ortigara; durante l’estate cerco sempre fra i molti reduci che salgono in visita sul monte sacro degli alpini qualche volto a me conosciuto, qualche volto che mi ricordi quel lontano inverno ’42-’43, fino a Nikolajewka, ma non ho più rivisto nessuno.
Se qualche amico di allora salirà durante l’estate verso le Melette, Marcesina, l’Ortigara, e incontrerà uno stradino che con carriola e badile sta sistemando la strada, si fermi; quello stradino sono io, Antonio Pinco della 45ª Compagnia del Battaglione Morbegno.



